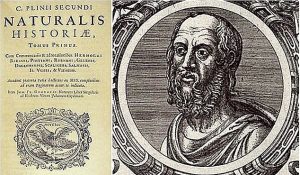È uscito il numero unico “La tempesta – L’imprevisto palestinese nella guerra globale”

Riceviamo e diffondiamo dall’assemblea “sabotiamo la guerra”:
È uscito il numero unico “La tempesta – L’imprevisto palestinese nella guerra globale”
Prezzo: 3 euro a copia, 2 euro per i distributori dalle tre copie in su
Per ordini scrivere all’assemblea “sabotiamo la guerra”: appelloantimilitarista@anche.no
Qui copertina, indice e introduzione in pdf: numerounico_indice_intro
Di seguito l’introduzione e qui la sola introduzione in pdf: numerounico_intro
Introduzione
Non ti accorgi che ogni generazione è in attesa di un cataclisma spaventoso; che sente salire la tempesta, e che ogni borghese si affretta ad assicurarsi contro la morte vicina, dovesse pure far perire, per ciò, tutti quelli che gli sono cari? A che servono i discorsi da maestro di scuola a della gente per tre quarti annegata?
Ernest Cœurderoy, Giorni d’esilio
Se esiste oggi della «gente per tre quarti annegata», questa è senz’altro la popolazione di Gaza. Rinchiusa tra due frontiere, sistematicamente bombardata da oltre quattro mesi, in fuga dalle macerie, alloggiata a migliaia in tende di fortuna, esposta alla fame, alla sete, alle malattie. La distruzione degli ospedali e degli impianti di desalinizzazione dell’acqua, la cementazione dei pozzi, il fuoco contro le ambulanze, gli attacchi ai rifornimenti di cibo, un infanticidio di massa, la cancellazione di ogni memoria storica e culturale: questo orrore senza fine ha i tratti inconfondibili del genocidio. Di più: visto l’uso strutturale dell’intelligenza artificiale (Vangelo, hanno chiamato la pianificazione algoritmica dei bombardamenti su Gaza), stiamo assistendo al primo genocidio automatizzato della storia. Contemporanei di una nuova Nakba – con i rappresentanti del governo israeliano che propongono apertamente la deportazione dei gazawi nel deserto del Sinai, nelle terre del Congo o su di un’isola artificiale –, solo l’azione risoluta può salvarci dall’inerzia, dalla disumanità o dalle lacrime. Cosa possono fare, ai bordi di un tale abisso, le parole? Scriveva Simone Weil in un testo del 1937 (Potere delle parole): «Mettiamo la maiuscola a parole prive di significato e, alla prima occasione, gli uomini spargeranno fiumi di sangue, a furia di ripeterle accumuleranno rovine su rovine […]; niente di reale può davvero corrispondere a tali parole, poiché non significano niente». “Democrazia”, “valori occidentali”, “Diritto internazionale” non sono soltanto vuote parole sepolte sotto le macerie di Gaza; sono la “scorta” di quelle bombe, di quel sangue, di quei morti. Ad altre parole – a bocche e a cuori capaci di avvertirne tutto il peso – la giovane Simone affidava un compito opposto, necessario e impossibile: «Chiarire i concetti, screditare le parole intrinsecamente vuote, definire l’uso di altre attraverso analisi precise, ecco un lavoro che, per quanto possa sembrare strano, potrebbe preservare delle vite umane». Dobbiamo pensare, parlare e scrivere come se fosse così.
Dentro le sue incancellabili specificità – che attengono alla doppia natura dello Stato israeliano: avamposto dell’imperialismo occidentale e allo stesso tempo unico colonialismo d’insediamento non ancora concluso –, la guerra contro i palestinesi è parte di un conflitto mondiale tra i diversi blocchi statal-capitalistici. Per questo la questione palestinese è riflesso di un sistema mondiale e contemporaneamente il suo imprevisto. Non solo perché l’azione del 7 ottobre – comunque la si voglia leggere – ha avuto il significato del riscatto della variante umana e oppressa contro l’onnipotenza tecno-militare, contro i suoi muri elettronici, i suoi droni, la sua sorveglianza di massa; ma anche perché la soluzione della questione palestinese non può avvenire senza lo smantellamento di un intero sistema coloniale e dell’imperialismo occidentale che lo sostiene. Qualunque cosa ci sia nelle teste dei resistenti palestinesi, la liberazione dal sionismo non può che passare attraverso un urto rivoluzionario contro i nostri stessi oppressori. Qui si collocano sia il rapporto tra la lotta di classe alle nostre latitudini e la decolonizzazione di quella terra, sia la necessità di dare un significato preciso all’espressione «Palestina libera». «Due popoli, due Stati» è ormai una barzelletta insanguinata. I “territori palestinesi occupati” rappresentano il 22% della Palestina storica; in Cisgiordania è insediato un colono israeliano ogni tre palestinesi; l’Autorità Nazionale Palestinese è di fatto un poliziotto e un carceriere al soldo dell’occupante. Ma soprattutto: mai si è visto nella storia uno Stato di colonizzati a fianco di uno Stato di colonizzatori. La prospettiva di uno Stato unico aconfessionale da erigere sulle rovine del sistema coloniale sionista è certo più logica e conseguente (infatti questa è sempre stata la rivendicazione dei palestinesi dalla fine degli anni Sessanta fino al “tradimento” di Al Fatah con gli accordi di Oslo, e oggi torna con forza nel dibattito). Ma tale prospettiva – che, lo ripetiamo, presuppone un vero e proprio processo rivoluzionario sia nella regione sia nei rapporti internazionali – porterebbe allo sviluppo di quella classe borghese palestinese che dentro il sistema coloniale non può che rimanere poco più di un ceto privilegiato e collaborazionista. In poche parole: com’è sempre successo nella storia, anche in Palestina lo Stato, qualsiasi Stato, sbarrerebbe la via a un’autentica rivoluzione sociale, che rimane sempre possibile finché i giochi non sono fatti. Se, come scriveva nel lontano 1907 l’anarchico ebreo tedesco Gustav Landauer, «lo Stato è la forma storica che ha sostituito la convivenza», solo la sostituzione dello Stato israeliano con la libera federazione di libere comunità può impedire che decenni di violenza e di disumanizzazione impediscano ogni convivenza, creando un nuovo dominio di classe. Questo significa per noi «Palestina libera», un intreccio di decolonizzazione e di trasformazione radicale dei rapporti sociali post-coloniali. È tardi, in tal senso, per i discorsi da maestri di scuola. Primo perché quando in gioco non sono, come per il proletariato occidentale, le condizioni di vita, ma la sopravvivenza stessa di fronte a un sistema che fa dell’eliminazione un principio organizzativo, il ricorso alla violenza è una necessità assoluta; secondo, perché soltanto chi lotta in quelle terre può decidere concretamente del loro avvenire. A noi il compito di attaccare i padroni di casa nostra, cioè di spezzare le collaborazioni tra il “nostro” Stato e i massacratori del popolo palestinese (collaborazioni che l’operazione militare contro lo Yemen trasforma in appoggio diretto al genocidio in corso). Soltanto un movimento internazionale in grado di mandare in crisi il sistema-Israele potrà dire la propria sul futuro comune delle terre e della Terra.
Nella tempesta di una tendenza strutturale alla guerra, mentre tutti i cantori del dominio vorrebbero farci spalancar la bocca davanti all’imperiosa necessità della Forza, le forze in campo dimostrano ogni giorno di più il loro carattere contingente. La NATO sta perdendo in Ucraina, l’Africa ribolle, il commercio mondiale è messo in crisi da uno dei Paesi più poveri della Terra, le basi militari USA sono colpite da formazioni non statali. Per questo la repressione contro gli immigrati (e contro i compagni) avanza. Per questo i piani di riarmo, gli annunci di arruolamenti di massa, la censura che getta ogni maschera. «Rivoluzione o guerra»: ecco un concetto che è già dentro la materia del mondo; un concetto che, «per quanto possa sembrare strano, potrebbe preservare delle vite umane». Mentre sale la tempesta, questo numero unico vuole soffiare in tal senso.