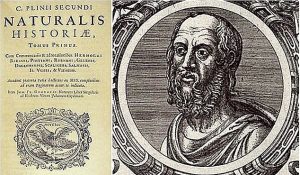Nelle braccia del Leviatano – Note contro lo Stato

Dalla rivista anarchica “i giorni e le notti”, numero 14, luglio 2022
Scaricabile in pdf: Nelle braccia del Leviatano
NELLE BRACCIA DEL LEVIATANO
Note contro lo Stato
La “volontà di potenza” è stata finora uno dei motori più forti nello sviluppo delle forme della società umana. L’idea che tutti gli eventi politici e sociali siano soltanto il risultato di determinate condizioni economiche non resiste ad un’attenta considerazione.
Rudolf Rocker
[Il Capitale di Marx è] l’unico grande testo di demonologia che l’età borghese ha prodotto.
Roberto Calasso
Mi rifiuto di accettare il declino del nostro ordine mondiale.
John McCain
(noto “falco” neocon statunitense, alla
conferenza sulla sicurezza di Monaco del 2017)
Contro l’eterno presente
Se c’è una questione che la dichiarata pandemia ha rimesso all’ordine del giorno, questa è senz’altro la questione dello Stato. Non potrebbe essere diversamente. Dopo anni in cui, da destra a manca, si è vaneggiato sul suo decadimento o addirittura della sua progressiva scomparsa, lo Stato si è infatti ripresentato nella sua interezza. Se nessuno, di fronte alla sua pretesa di interferire e regolare, autorizzare o negare anche i comportamenti più minuti, ha potuto ignorare il suo carattere sfacciatamente poliziesco (con tanto di tremori e timori di rinascita dello Stato etico che, da sinistra a destra, hanno assalito anche gli statalisti più convinti), stavolta lo Stato non ha fatto sentire la sua mancanza neppure dal lato economico, tra interventi straordinari di riconversione produttiva (come per le fabbriche messe da un giorno all’altro a produrre mascherine) e santificazione del «debito buono», funzionale prima all’affrontamento della Grande Emergenza e poi a una «ripartenza dell’economia» ancora tutta da vedere. Se ai piani alti della società il ritorno dello Stato è stato salutato in pompa magna (con un investimento propagandistico che dovrebbe già bastare a intendere le reali intenzioni della classe dominante), ai piani bassi non ha fatto che dare la stura alle ipotesi più strampalate, soprattutto per quanto riguarda le diverse aree militanti che si richiamano, con varietà di accenti, al pensiero marxista. Mentre tutta la galassia postmodernista e identitale ha praticamente ignorato la questione, riducendo la gestione della “pandemia” a un mero problema di volontà politica (che sarebbe marcata solo da un atteggiamento più o meno “abilista”: come se i diversi uomini al balcone decidessero in base alla loro “sensibilità”, al pari dei comuni mortali, e non tenendo conto innanzitutto di determinanti sistemiche!), tanti “comunisti” non hanno fatto altro che disvelare la sostanziale confusione che da sempre permea la loro tradizione storica rispetto a questo problema. Con più o meno consapevolezza, e rivelando una latente subordinazione culturale al marxismo, molti anarchici ne hanno scimmiottato le analisi; altri sono semplicemente ammutoliti; qualcuno, pur di distinguersi da «gli idoti che votano Trump», non ha esitato a buttare a mare decenni di critica alle biotecnologie e persino all’intera «civiltà». Tra elogi del collettivismo cinese e improbabili ragionamenti sulla trascendenza del sociale, che in fondo finirebbe per mettere d’accordo Marx e Hobbes (!), marxisti autoritari e “libertari”, in compagnia di anarchici marxisteggianti, di Paese in Paese e da un continente all’altro, hanno ripetuto lo stesso ritornello volgarmarxista: essendo nato per ricomporre società lacerate dalla lotta di classe, lo Stato non sarebbe altro che il suo arbitro parziale (tendererebbe cioè a dar ragione al più forte tra i contendenti, divendone tendenzialmente, ma non necessariamente, il gendarme); ma in quanto superfetazione storica dei “rapporti sociali di produzione”, lo Stato si farebbe anche garante della riproduzione sociale complessiva, seppure nella forma alienata del capitalismo, curando in particolare il mantenimento-in-vita della forza-lavoro. In parole più triviali: se la base economica della società capitalistica è l’estrazione del plusvalore, questa può darsi soltanto finché la classe sfruttata sopravvive ed è in condizione di lavorare; se “moriamo tutti” e non resta nessuno da sfruttare, il capitale crepa come Sansone con tutti i filistei. Mentre questa sonora sciocchezza non regge neppure a una prima analisi meramente materiale (una malattia che uccide quasi esclusivamente anziani e persone affette da altre patologie è una vera e propria manna in tempi di tagli draconiani allo Stato sociale, togliendo letteralmente dalle spese migliaia e migliaia di improduttivi, e le relative pensioni), rivela anche una visione del rapporto tra Stato e capitale ferma al liberal-liberismo, e schiacciata su un immaginario del tutto ottocentesco: l’epoca del laissez-faire, quando lo Stato sembrava effettivamente presentarsi – con qualche limite, come vedremo – quasi solo come «un sistema d’allarme per proteggere la villa dei padroni» (secondo la bella espressione polemica di “Vetriolo”); in altre parole, come semplice gendarme. Messa così, la dinamica del capitalismo si riduce a un eterno presente, in cui gli “attori” economici e il loro lenone politico giocano di epoca in epoca il medesimo ruolo. Per questo giova ricordare che la storia del capitalismo ha un prima e un dopo, abbracciando quantomeno un periodo che va dai secoli della cosiddetta accumulazione originaria (potremmo dire, dalla “scoperta” dell’America ai primi decenni della rivoluzione industriale in Inghilterra) fino a un Novecento segnato prima dal protezionismo e dalla programmazione economica e poi dalla scienza applicata all’industria (senza contare alcuni illustri precedenti medievali: di questi diremo dopo). Dal canto suo, la storia dello Stato (o meglio della “forma-Stato”) è ancora più antica, e abbraccia diversi millenni. A mio modesto parere, non solo non si può minimamente dipanare questa matassa di problemi (il rapporto tra sfruttamento dell’uomo sull’uomo, «modo di produzione capitalistico» come sua forma storicamente determinata, e autorità politica) senza considerare il capitalismo come accumulazione di capitale più lo Stato; ma soprattutto non si potrà avanzare verso un mondo più libero e giusto senza sottoporre a critica lo Stato in sé. Senza alcuna pretesa di completezza, e neppure di non commettere errori, vorrei abbozzare alcuni lineamenti critici in questo senso. Da nano che poco capisce di economia politica, salirò più volte, nel corso del ragionamento, sulle spalle di un gigante: il compianto storico dell’economia Giovanni Arrighi, e il suo grandioso Il lungo XX secolo.
La questione dello Stato
La questione dello Stato è un vero e proprio labirinto, che non finisce mai di snodarsi in più direzioni. Da un lato, si collega e rientra nella più complessa questione del potere; dall’altro, si tratta di un fenomeno che nel corso dei millenni si è ripresentato più volte in forme diverse, in cui i tratti comuni, di epoca in epoca, non sono per forza maggiori di quelli divergenti. La filosofia politica, al riguardo, si è per lo più divisa secondo due filoni: quello marxista, al quale in parte si è già accennato, e quello contrattualista, del quale Hobbes è senz’altro il rappresentante più coerente. Il primo mette al centro la società e i rapporti di produzione, muovendo da un’idea dell’essere umano naturalmente sociale e gregario, e spiegando la nascita e la funzione dello Stato a partire da quelli; il secondo, viceversa, mette al centro gli individui e la loro «insocievole socievolezza» (come più tardi dirà Kant), chiedendosi come sia possibile che esseri per natura divergenti, spinti da una pulsione cieca all’autoconservazione e dominati dai capricci delle passioni, riescano a convivere: lo Stato ne esce come un meccanismo artificiale coercitivo ma necessario. Mettendo da parte le interpretazioni anarco-primitiviste (che mentre ne denunciano i mali finiscono per giustificare lo Stato, che sorgerebbe già ai minimi livelli di complessificazione sociale: una spiegazione da sussidiario), a questi illustri filoni filosofici se ne può aggiunge un terzo, fornito dalla storiografia e dall’antropologia, cui si rifanno diversi anarchici: lo Stato deriverebbe insieme da dei differenziali sociali, siano essi economici o d’altro tipo (come vuole anche la tradizione marxista), e dalla conquista brutale e violenta operata da alcuni gruppi umani a danno di altri (come i “mitici” indoeuropei del neolitico inferiore a danno delle popolazioni dell’antica Europa e dei dravidici in India: una ricostruzione alla quale l’archeologa lituana Marija Gimbutas ha fornito più di un argomento convincente). L’educazione e la cultura (e all’interno di quest’ultima, la religione), strutturate dalle caste dominanti a loro uso e consumo, provocherebbero poi la riproduzione e la trasmissione del medesimo modello socio-culturale di generazione in generazione, legittimando il monopolio della violenza di pochi privilegiati. Con buona pace di tutti i “filosofi” che si dilettano di astrazioni, sacrificando la resistenza della materia alla coerenza del ragionamento chiaro e distinto, quest’ultima ipotesi ha dalla sua l’evidenza empirica. Tuttavia, se essa spiega bene, al netto di qualcosa, per quale motivo lo Stato sorge, essa non basta a spiegare perché sussiste, e soprattutto per quale motivo, da premesse materiali, storiche e culturali differenti, gli esseri umani finiscano per giungere al medesimo risultato. Se questa spiegazione può reggere per la Roma antica, e “funziona” molto bene per la gran parte degli Stati moderni, nati dalle bande di popoli “barbari” militarmente organizzati (in latino, il populus è etimologicamente la “banda di saccheggiatori”), non spiega del tutto alcuni casi. Per quale motivo, ad esempio, la Confederazione Svizzera, sorta dalla resistenza federata di gruppi umani differenti anche linguisticamente, avrebbe poi finito per adottare anch’essa un modello statale? La risposta potrebbe ricondurci ancora al paradigma marxista: generando differenze sociali, e quindi conflitti, l’attività economica rende necessaria un meccanismo di mediazione autoritaria superiore alla società. Spiegazione probabilmente perspicua, ma che da un lato esclude altri aspetti della vita materiale, con i loro inevitabili riflessi sulla psicologia collettiva (nel caso in esame, ad esempio, l’attività di mercenariato svolta dai Cantoni a partire dal basso medioevo, in particolare al servizio degli Asburgo); e dall’altro non ci restituisce perché siano esistite (ed esistano attualmente) popolazioni senza Stato caratterizzate da differenze economiche, per quanto minime, tra clan o famiglie; e come queste popolazioni non siano necessariamente nomadi o composte da cacciatori-raccoglitori, ma in alcuni casi pratichino l’agricoltura o l’allevamento. Non vale del tutto nemmeno l’obiezione che l’organizzazione statale “scatterebbe” a partire dall’ottenimento di un certo agio materiale, almeno se si prende per buona la ricostruzione di Gimbutas, per la quale l’antica società egualitaria sarebbe stata già molto evoluta (padroneggiando l’arte della ceramica, della produzione di mattoni e di calce, e in alcuni casi – forse – essendo giunta a una rudimentale forma di scrittura). Ancora, come negare che durante processi insurrezionali di segno più o meno “libertario” – dalla Spagna del 1936 al Chiapas contemporaneo, passando per l’Ucraina del 1917-21 – milioni di esseri umani siano capaci di dare vita a forme di convivenza egualitaria non-statale, in contesti di agricoltura avanzata e persino di moderata industrializzazione?
Il confronto tra “Stati” antichi e moderni complica ancora più il problema, a partire dalla terminologia utilizzata. Dando praticamente per scontata l’esistenza dello Stato, la storiografia dominante definisce con lo stesso termine tanto le poleis greche quanto l’antica res publica romana e gli Stati moderni: mentre le differenze saltano all’occhio a partire dagli stessi nomi con cui gli antichi auto-definivano le forme delle loro “comunità politiche”. Mentre il termine moderno, “Stato”, comincia a essere pronunciato agli inizi del Cinquecento oscillando tra il senso di “patrimonio personale di un signore” e “organizzazione politico-statale” (come si può vedere in Machiavelli), polis significa semplicemente “città”, mentre la res publica è “la cosa del popolo”, ovvero l’insieme dei cittadini che possono portare armi (si ricordi il legame tra “saccheggio” e populus, di cui publicus è una variante) e che non possono essere schiavizzati. Dalle parole ai fatti, non è poco significativo che ad Atene la polizia fosse composta esclusivamente da schiavi che si occupavano di tenere sotto controllo altri schiavi, mentre non potevano toccare i “cittadini liberi”; che non esistesse una magistratura professionale e separata, ma che al contrario le cause fossero discusse da un’assemblea di centinaia di cittadini eletti a sorte, mentre l’azione penale – salvo le colpe che rischiavano di attirare sulla città l’ira degli dèi, come la blasfemia o il parricidio – veniva esercitata solo a partire da una querela; che le decisioni venissero prese direttamente da assemblee di cittadini, più o meno allargate o ristrette secondo il censo a seconda dei momenti storici… Viceversa, se Roma finì precocemente per divenire uno Stato nel senso moderno del termine, assumendone in tutto e per tutto i tratti nei suoi ultimi secoli (quelli noti come Impero), è anche vero che essa vide per centinaia di anni una pluralità di consigli (dai “comizi curiati” e poi “centuriati” fino al Senato, passando per l’assemblea della plebe e i suoi tribuni), spesso in conflitto anche armato tra loro. Non è un caso che Thomas Hobbes, che era una carogna ma non era uno stupido, parli nel De cive di «anarchia dei Greci e dei Romani», sottintendendo ciò che differenzia lo Stato moderno dalle città antiche: l’assoluta superiorità dello Stato nei confronti della società.
Potere, dominio, Stato
Dicevamo sopra che il labirinto dello Stato si snoda anche attraverso la questione del potere. Non ce ne siamo dimenticati. In un articolo dei primi anni Ottanta intitolato Potere, autorità, dominio, l’anarchico Amedeo Bertolo propone una distinzione tra i termini di rara attenzione. Particolarmente interessante è quella tra “potere” e “dominio”, una sorta di “rasoio di Ockham” dell’anarchia. Bertolo rileva giustamente l’ambiguità del termine “potere”, che oscilla sempre tra un “poter fare” e un “poter far fare”, e mette in guardia dall’usarlo come sinonimo di potere politico, economico, di “status” ecc. La sua proposta è di utilizzare la parola in senso socio-antropologico, come funzione – presente in forme diverse in ogni società possibile o pensabile – del prendere decisioni e farle rispettare per mezzo di sanzioni (si tratti di sanzioni “positive” o “negative”, di premi e gratificazioni o di resistenze e punizioni). Il dominio diventa a questo punto una distribuzione diseguale del potere. Laddove io e tutti gli altri possiamo fare le stesse cose senza che intervenga alcuna sanzione; laddove possiamo concorrere allo stesso modo all’elaborazione delle regole, alla loro modifica, revisione o abrogazione; laddove tutti possiamo pretenderne e imporne il rispetto, non c’è dominio. Viceversa, il potere socialmente determinato degli uomini di “poter far fare” qualcosa alle donne, o di “poter fare” cose che le donne non possono fare, è già una forma di dominio a pieno titolo, come le analoghe sperequazioni di potere tra il capobastone e il quartiere, il padrone e gli operai ecc. Lascio qui da parte il ragionamento di Bertolo sul concetto di “autorità”, che in questa sede non mi interessa, e mi chiedo cosa contraddistingue il dominio dello Stato. La dottrina dello Stato individua, fin dagli ultimi secoli del medioevo, tre elementi distintivi: la sovranità, il popolo e il territorio. Il primo elemento troverebbe la propria legittimità nel secondo e i propri limiti nel terzo. Ma per chi, come gli anarchici, pensa che lo Stato sia un’appropriazione indebita della facoltà decisionale (al pari, per fare un paragone, del patriarcato), ritenendo quindi che quelle sulla legittimità siano tutte chiacchiere e menzogne, solo il terzo elemento – il territorio – è davvero interessante. Mentre ogni altra forma di dominio, infatti, vede al centro il rapporto personale tra dominante e dominato (com’è evidente nell’interazione autoritaria tra uomo e donna, tra padrone e schiavo, tra adulto e bambino, pure se in quest’ultimo caso la sperequazione è ovviamente giustificata dalla natura), il dominio dello Stato si esercita prima di tutto come controllo del territorio da parte di un ente che si arroga la facoltà di prendere e far rispettare le decisioni al suo interno. Torniamo alle diverse “teorie del potere”, ed esaminiamole da questo punto di vista. Cos’hanno in comune tra loro? Il conflitto (sia esso più per le risorse o per il comando, dove il secondo ha tra l’altro l’importantissima funzione di regolare la distribuzione delle prime) all’interno di un determinato luogo geografico. Lasciamo da parte la spiegazione “marxista” e quella “anarchica”, di cui si è già parlato, e prendiamo sul serio Hobbes che, come è già stato detto, era una carogna ma non era uno stupido. Nel De cive, Hobbes contrappone «diritto naturale» e «legge (della ragione) naturale». Il diritto naturale è, per così dire, il “diritto soggettivo” proprio dell’individuo, isolato e non ancora giunto allo «stato civile», di provvedere alla sua autoconservazione, accaparrandosi le risorse di cui abbisogna e provvedendo alla propria difesa come meglio crede, compresa la facoltà di attaccare per primo. Infatti, nel momento in cui non c’è “un terzo” (lo Stato, l’uomo artificiale) a garantire per la parola del mio vicino, io non ho alcuna garanzia rispetto ai patti che rendono possibile la nostra convivenza, segnata dalla necessità di accedere a risorse limitate o comunque ottenibili solo attraverso degli sforzi: così l’offesa finisce per rientrare nel diritto di difesa. Ne deriva la lotta permanente di tutti contro tutti (bellum omnium erga omnes). Contro il diritto naturale, che lasciato a se stesso non può che negarsi (l’istinto d’autoconservazione finisce infatti per divorare se stesso nel conflitto universale), si leva la «legge naturale» o «legge di ragione», che comanda innanzitutto di «cercare la pace e, qualora non sia possibile, cercare aiuti per la guerra». A partire da ciò, gli esseri umani si accordano tra loro, «con chiari segni», per trasferire il loro diritto naturale (disposizione sulle risorse e diritto d’offesa) a un “essere artificiale” (lo Stato), che garantisca gli obblighi reciproci tra gli individui senza avere alcun obbligo nei loro confronti.1 Almeno centocinquant’anni di antropologia non hanno fatto che smentire questa fantasmatica ricostruzione: gli esseri umani non hanno mai vissuto isolati (Marx, che si appoggiava in questo alla migliore antropologia del suo tempo, aveva ben intuito che l’uomo, all’origine, è un «animale gregario», che «solo nella società può isolarsi»: il resto sono «robinsonate»); i «patti di soggezione» all’autorità stipulati «con chiari segni» sono più l’eccezione (riscontrata prevalentemente in età feudale) che la regola; infine, e più importante, gli individui, all’interno di comunità non-statalizzate o lontane dall’autorità centrale (come sulle montagne), hanno sempre regolato i loro affari direttamente, senza o contro l’autorità statale. Tuttavia, il ragionamento di Hobbes può contenere un elemento di verità. Se passiamo dal piano del rapporto tra gli individui di uno stesso gruppo al rapporto tra comunità differenti, il discorso cambia: il conflitto omicida è molto frequente, forse la regola più che l’eccezione. Tra le società tribali del Sudamerica descritte da Clastres, la guerra tra comunità è permanente, anche se è meno distruttiva della guerra tra civilizzati (non essendo volta alla conquista territoriale, si ferma alla semplice umiliazione dell’avversario, e magari riprende finché non si ferma la catena delle faide: ma senza mai vedere né la schiavizzazione di gruppi ad opera di altri, né tantomeno le devastazioni perpetrate dalle civiltà “superiori”). Perché? «Finché un uomo ti incontra e non si riconosce…», dice il poeta in una famosa canzone sulla persecuzione dei Rom. All’interno delle medesime comunità, nella collaborazione data dalla vita quotidiana, gli esseri umani tendono a riconoscersi reciprocamente. Ricucire i conflitti, prima che si allarghino e lacerino tutto il gruppo, diviene allora una semplice questione di istinto sociale. Finché la società non sembra andare avanti da sé, nella sua forma impersonale moderna, attraverso gli automatismi prodotti dall’intreccio di burocrazia, polizia e attività economica; ovvero finché l’organizzazione sociale non arriva a prescindere dal concorso attivo degli individui, tutti sanno, più o meno inconsciamente, che la loro sopravvivenza dipende dalla cooperazione di tutti con tutti; se in caso di conflitto entra in gioco la mediazione del “saggio”, degli anziani, dell’assemblea, è comunque tutto il gruppo, direttamente o indirettamente, a spingere verso una soluzione. Viceversa, quando il riconoscimento reciproco non c’è, com’è nel caso di gruppi distinti tra loro, può bastare il minimo pretesto… e si scatena l’inferno. Ora, nelle guerre, sempre e particolarmente nelle età più antiche, il primo fattore di vantaggio è quello demografico: normalmente, tra due armate, quella in minoranza soccombe. Di fronte a popolazioni più folte e bellicose, e alle prime forme di imperialismo, le comunità possono o meno «cercare aiuti per la guerra», federandosi con altre comunità (il che non è infrequente). Ma siccome il riconoscimento reciproco – “sentirsi” come la stessa comunità – è più una conseguenza che una causa della cooperazione, è più facile che a trovarsi uniti siano quei gruppi umani che vengono assoggettati dai gruppi più forti e violenti, che impongono loro l’unità forzata, riunendoli in un fascio di forze. Così, la prima classe – o meglio “casta” – dominante, è il gruppo dei guerrieri e dei conquistatori, che col tempo si presenta come “protettore”, ed esige tributi e privilegi; col passare delle generazioni, la casta guerriera si fa man mano classe proprietaria e dirigente, delegando in tutto o in parte il mestiere delle armi ad altri. La funzione dello Stato, quindi, non è tanto favorire l’unione, ma impedire la dis-aggregazione. Ancora con Hobbes: «si deve fare qualcosa di più, affinché coloro che hanno consentito per una volta alla pace e all’aiuto reciproco, in vista del bene comune, sia proibito con la paura di cadere nuovamente nel dissenso, quando un loro bene privato divergerà dal bene comune» (ibidem; il primo e il terzo corsivo sono miei). Qui Hobbes ha ragione: quale che sia la sua origine, lo Stato è l’artificio sociale che «proibisce con la paura» di dissentire e dividersi di fronte al nemico (prima ancora che di confliggere al proprio interno): ovvero, è essenzialmente una tecnologia di guerra e per la guerra. Si tratta, va riconosciuto, di una tecnologia particolarmente efficiente, che ha passato la prova della storia. Dal canto loro, infatti, le società più pacifiche ed egualitarie sopravvivono ai margini, oppure vengono schiacciate o assimilate, o ancora, per difendersi, adottano a loro volta questo qualcosa di più.2
Chiaramente, non sto dicendo che le cose siano andate sempre così (semmai, per lo più). A volte si può osservare, per esempio, una preminenza sociale della casta burocratica o religiosa (anche se in genere queste si collocano accanto alla casta guerriera, più che al di sopra); altre volte, è invece osservabile una preminenza del fattore economico (lo Stato sorge anche per regolare i conflitti di classe interni alla comunità), ma sempre, in misura maggiore o minore, in relazione all’attività bellica. A questo proposito, la storia antica ci fornisce ancora una suggestione. Com’è noto, Roma divenne una repubblica pienamente aristocratica col passaggio dai comizi curiati (l’assemblea “democratica” che riuniva tutte le gentes, cioè i clan, a parità di voto) ai comizi centuriati: sperequazione del voto secondo il censo e quindi secondo il ruolo rivestito nell’armata dalla centuria (a seconda del numero di armati a piedi e a cavallo che ciascuna centuria poteva mettere in campo: questione di censo, appunto, perché le armi costano). Viceversa, Atene passò alla “democrazia” – inventandone il nome – quando i cittadini più poveri rivendicarono il ruolo avuto nella guerra contro i Persiani: erano sprovvisti di armamento personale; ma senza le loro braccia la flotta d’Atene, che ne faceva la potenza, non si sarebbe mossa. Chi è artefice della potenza della città, rivendica la potenza della città. Così il fattore militare e il fattore di classe tendono a implicarsi a vicenda, a raggiungersi e sovrapporsi, e spesso a coincidere; mentre il conflitto di classe deve essere impedito, o almeno contenuto, in quanto disgregatore. Le armi si collocano all’incrocio tra l’uno e l’altro.
I moderni
Nella “modernità” (che comincia, strano a dirsi, dal medioevo…) le cose si sono ulteriormente complicate. Le società antiche erano più società “di casta” che “di classe”, anche se pure queste ultime non erano del tutto assenti (dipende chiaramente dai contesti). In ogni caso, per esprimerci in termini contemporanei, si può dire che al loro interno le élite “politiche” ed economiche erano più o meno coincidenti, mentre la “mobilità sociale” era assente o quantomeno scarsa. Chi possedeva, dirigeva lo Stato, e viceversa. La storia della “modernità” è anche storia di un lento trapasso da una società di caste a una società di classe. Ci sfiora l’idea che nel mondo contemporaneo la ruota della storia stia girando, da questo punto di vista, in senso inverso. Ma procediamo con ordine.
È praticamente una banalità dire che quando si parla di “modernità” si parla di capitalismo. Ma cosa si intende esattamente con questa parola? Facciamo ancora un passo indietro.
Praticamente tutta la storia del medioevo è la storia di tentativi fallimentari di ricreare uno Stato sul modello dei Romani, e particolarmente sul modello romano dei secoli imperiali. Ma i conati dei re e dei sedicenti imperatori si scontravano ripetutamente sia con l’anarchia dei poteri tipica dell’epoca (dai feudatari felloni alle molteplici forme di auto-organizzazione delle masse contadine e urbane, passando per la concorrenza sdegnosa della Chiesa), sia con i limiti tecnici e politici della loro potenza militare, consistente in un numero limitatissimo di nobili armati, e sempre pronti ad anteporre i propri interessi a quelli della corona. Dall’altra parte, il capitalismo, nel senso più generale possibile di «denaro che genera altro denaro», e del potere sociale che ne deriva, restò, fino alla fine del medioevo, un fenomeno portentoso ma marginale e periferico, relegato a poche “città libere” dell’Ansa germanico-fiamminga e dell’Italia. Se anche molte città – ma non tutte… – svilupparono presto o tardi forme di organizzazione statale o semi-statale, il loro dominio non si estese mai oltre la dimensione regionale. Fu invece l’incontro tra le monarchie nazionali in formazione e i mercanti divenuti banchieri a trasformare piano piano entrambi in una vera potenza, con l’inaugurazione di un modello destinato a durare fino ai giorni nostri, e che non si è ancora estinto: il prestito a interesse per finanziare le guerre. È a partire da questa relazione che il capitalismo comincia a trasformarsi, da semplice fenomeno sociale, ad autentico sistema, destinato a “rifare il mondo” a propria immagine e somiglianza. È da quel momento che gli Stati in formazione cominciano a fare i propri interessi facendo quelli dei possessori della nuova pietra filosofale: il denaro. Lasciamo la parola al lucido borghese Max Weber: «Nell’antichità la libertà cittadina è scomparsa a favore di un impero mondiale organizzato burocraticamente, all’interno del quale non vi era più spazio per un capitalismo politico […]. [A] differenza di quanto era avvenuto nelle fasi precedenti, [nell’epoca moderna le città] caddero sotto il dominio di Stati nazionali in concorrenza tra loro, e in costante conflitto per il potere, sia in forma pacifica sia in forma bellica. Questo conflitto concorrenziale determinò le massime opportunità per il moderno capitalismo occidentale. Il singolo Stato doveva competere per il capitale, che poteva spostarsi liberamente e gli prescriveva le condizioni a cui era disposto a dargli l’aiuto necessario per diventare una potenza. […] È dunque lo Stato nazionale chiuso ciò che assicura al capitalismo le opportunità per continuare a sussistere» (in Giovanni Arrighi, cit.). Tra Stato e capitale nasce un rapporto simbiotico: l’uno fa la potenza dell’altro. Sarà la “scoperta” dell’America a dare slancio a questa simbiosi. Avviata dalla monarchia spagnola e proseguita da tutte le altre potenze statali in formazione, la conquista del Nuovo Mondo inondò l’Europa con nuovi prodotti e ricchezze di ogni genere, a partire dal celebre argento peruviano che fece le fortune dei banchieri genovesi, finanziatori dei sovrani iberici. L’attività economica capitalistica ne venne stimolata; le casse degli Stati rimpinguate; il partenariato tra le corone e affaristi di ogni genere ne uscì rafforzato. Nella colonizzazione del mondo cominciata da occidente, fu centrale il ruolo delle “Compagnie privilegiate”: le varie “Compagnie delle Indie” occidentali e orientali, di cui si dotarono tutti gli Stati più potenti. Raggruppamenti di mercanti e avventurieri organizzati nella forma della società per azioni, che agivano con discreti margini di autonomia, ma solo previa autorizzazione dei rispettivi Stati di riferimento, con la loro protezione armata e con l’impegno di realizzarne gli interessi strategici. Lungi dall’essere una recente scoperta dell’economia politica, che il Forum Economico Mondiale di Davos ha apertamente fatto propria col suo recente piano di Grande Riaggiustamento (Great Reset), il “capitalismo dei portatori d’interesse” (stakeholder capitalism) è la prima forma del capitalismo come rapporto sociale complessivo, alla quale il capitale incessantemente ritorna. Chi, nel fare i propri interessi, fa gli interessi dello Stato, ne è a sua volta favorito.
Espropriazione
Appropriandosi della facoltà comunitaria di difesa e offesa nell’unità territoriale forzata, lo Stato, nella sua forma antica quanto moderna, muove una guerra progressiva e sistematica all’anarchia dei poteri fondati sui rapporti personali (si tratti di clan, di feudi, di vicinìe, di comuni urbani e di villaggio o di corporazioni di mestiere), percepiti come ostacoli e concorrenti alla sua forma totalitaria. Confiscando «tutti i possibili contenuti di un agire aggregato» (Weber, Comunità politiche), a partire dall’uso della violenza, lo Stato è costretto a dotarsi d’un apparato burocratico-poliziesco ipertrofico vòlto spesso alla loro disgregazione e sempre alla loro amministrazione, che necessita di un costante prelievo di risorse di ogni genere all’interno della comunità politica come al suo esterno. Così esso deve giostrare continuamente il proprio agire calmierando il livello di oppressione tra interno e esterno, di volta in volta vampirizzando la potenza sociale e indirizzandola verso la guerra, oppure redistribuendo i bottini ricavati dalle vittorie tra i propri membri subordinati, così da comprarne il consenso (una dinamica che alla fine dell’Ottocento riceverà un nome preciso: social-imperialismo). Del tutto coerentemente con la sua logica di fondo, lo Stato partecipa perciò al generale movimento di espropriazione che segna l’ascesa del capitalismo nei primi secoli dell’età moderna. Se all’esterno, in linea con la sua vocazione all’espansione territoriale, il primo impulso all’espropriazione è dato direttamente dallo Stato col colonialismo, all’interno questo appare effettivamente impresso da un movimento dal basso delle «forze produttive». La nota vicenda delle enclosures fu generata dalle trasformazioni economiche indotte in Europa dalla peste nera, che per circa un secolo infuriò a più riprese a partire dalla prima ondata del 1347-48. Trovatasi praticamente dimezzata dal morbo, la popolazione europea si scoprì improvvisamente più ricca (la ricchezza precedentemente prodotta era adesso a disposizione dei sopravvissuti). Se questo da un lato spostò i rapporti di forza a favore delle classi popolari (che restate in meno, pretendevano di più), attizzando una serie di rivolte che devono aver messo non poca paura alle classi dirigenti dell’epoca, la nuova ricchezza popolare stimolò nuovi consumi, in particolare di carni e di panni di lana. Boschi, paludi e terreni agricoli vennero eliminati per fare spazio ai pascoli. Quando la febbre della lana giunse in Inghilterra, i locali proprietari terrieri cominciarono ad allargare i propri possedimenti a spese dei piccoli contadini, espulsi dalle terre e costretti a vagabondare. Inizialmente, il debole reame inglese di Enrico VII e dei suoi successori cercò più di contenere questa grande trasformazione che di profittarne, applicando però due pesi e due misure differenti secondo la linea di classe: multe ai proprietari terrieri che demolivano i cottages (regolarmente condonate dai giudici di pace), pene draconiane (marchiatura a fuoco, schiavizzazione, morte) per i vagabondi, riconoscimento del fatto compiuto da parte del parlamento. Finché sul trono d’Inghilterra non salì finalmente una statista di razza: la regina Elisabetta, che attuò quella serie di riforme strutturali che avrebbero gettato le basi della supremazia capitalistica inglese. Nel corso del suo lungo regno, Elisabetta stabilizzò il valore della sterlina; promosse la borsa di Londra; avviò la colonizzazione dell’Irlanda e la penetrazione britannica nel Nuovo Mondo (com’è noto, la prima colonia venne dedicata alla “regina vergine” sotto il nome di Virginia); finanziò le prime compagnie dotate di privilegi con l’oro sottratto ai galeoni spagnoli per mezzo della guerra corsara; varò lo Statute of officers, sorta di prima “carta del lavoro” che disciplinò dall’alto le corporazioni di mestiere, con l’importante effetto, assolutamente ricercato, di spostare parte della manodopera dal settore tessile, fino allora dominante, all’attività estrattiva e alla siderurgia; con la famosa Poor Law del 1572, impose alle parrocchie di mantenere i vagabondi in cambio di lavoro forzato, trasformandole di fatto in “centri di collocamento”; con la promozione della Virginia Company, diede inizio alla deportazione nel Nuovo Mondo di migliaia e migliaia di poveri ingaggiati come servi a contratto, sotto la minaccia della galera, della tortura e della forca. Solo pochi anni dopo, il poeta ed ecclesiastico John Donne poteva proclamare, in un sermone del 1622, che «se davvero l’intero Paese fosse un correzionale in modo da costringere gli oziosi a lavorare, darebbe buoni risultati». Ai nostri giorni, le riforme elisabettiane sarebbero chiamate un piano di sviluppo.
Se questo processo si sarebbe riproposto, in tempi e con modalità diverse, in tutti i Paesi avviati a divenire aree centrali del capitalismo, chi non sa riconoscervi il ruolo dello Stato – ridotto a mero “accompagnatore” di «forze produttive» che paiono quasi svilupparsi da sé – sembra non aver imparato nulla dalla storia. È vero che questa “grande trasformazione” ebbe il primo impulso nel ventre della società globale di allora, a partire dallo sviluppo impersonale dell’industria laniera; ma è altrettanto vero che l’intervento statale ne deviò significativamente il corso. Se lo Stato inglese si fosse limitato a un mero intervento di gendarmeria, il «movimento delle forze produttive» lasciato a se stesso non avrebbe generato altro che un debole capitalismo semi-feudale di proprietari terrieri e piccole manifatture, e non la prima vera potenza capitalistica della storia. Infine, se ritroveremo il settore tessile nella rivoluzione industriale, le fortune del complesso statal-capitalistico britannico saranno realmente decise dal controllo delle rotte marittime, permesso dalla colonizzazione del Nordamerica; dal settore estrattivo e siderurgico, che renderà l’Inghilterra il primo esportatore di fucili e cannoni e, successivamente, il primo costruttore internazionale di ferrovie; dalla tratta di schiavi africani in mano alle compagnie privilegiate inglesi, che con la pace di Utrecht del 1709 se ne aggiudicano il monopolio; dalla stabilizzazione monetaria, che farà della sterlina la prima moneta di scambio internazionale.3
Il reticolato statale
Nonostante le periodiche lamentazioni contro l’invadenza dello Stato e a favore della libertà d’impresa, la borghesia, tanto nel suo intimo quanto nei suoi reali progetti politici, è sempre stata ferocemente statalista. Allevata nel seno dello Stato, vi trovò il mezzo per espandere le proprie rapine e i propri commerci e insieme per piegare le classi popolari al nascente lavoro salariato, superando i limiti della sua dimensione urbana e l’inefficienza dello sfruttamento feudale. Basato sull’estorsione di prodotti e prestazioni, il sistema del feudo implicava il controllo diretto sulla manodopera, con l’inflizione di dure punizioni fisiche (come le mutilazioni) a chi veniva meno agli obblighi del “patto”. L’esemplarità delle punizioni, tuttavia, non bastava minimamente ad assicurare che il servo si presentasse regolarmente sulle terre del signore nei giorni stabiliti, né che non gli rifilasse i prodotti più scadenti delle proprie terre, né tantomeno ad impedirne la fuga verso le città o le montagne. Le nuove forze produttive e politiche premevano in un’altra direzione: l’organizzazione della fame. Tutto concorreva a procurarla: da un lato la privazione dei mezzi di sussistenza e produzione (le terre coltivabili e i diritti consuetudinari su boschi, paludi, pascoli); dall’altro le guerre incessanti e crescentemente distruttive che accompagnarono prima la formazione degli Stati e poi le loro lotte per la spartizione del mondo, con il passaggio dai séguiti feudali, composti da alcune centinaia di armati a cavallo, a eserciti sempre più estesi formati da decine di migliaia di professionisti della guerra, per lo più mercenari, che per secoli (soprattutto nel Cinquecento e nel Seicento, prima dell’organizzazione degli eserciti permanenti) batterono l’Europa in cerca d’impiego, diffondendo epidemie tra le popolazioni e saccheggiando villaggi e a volte anche città. In questa fase, lo Stato impone al capitale la propria forma più di quanto ne assorba lo spirito cosmopolita: le guerre non decidono solo della spartizione dei territori, ma anche dei monopolî commerciali; mentre all’interno delle monarchie nazionali permangono rigide forme di regolazione della vita economica (come fa notare Kropotkin, ne Lo Stato e il suo ruolo storico, le nuove corporazioni calate dall’alto usurpano il nome e la funzione delle vecchie gilde medievali), fino all’estremo dell’iper-dirigismo detto mercantilista della monarchia francese. Mentre i trattati inter-statali organizzano la circolazione del capitale all’interno del proprio reticolato, il combinato disposto della fame e delle persecuzioni poliziesche costringe le classi popolari a vendersi a padroni vecchi e nuovi, rovesciando i rapporti di forza del vecchio «secolo della peste». La letteratura borghese del Settecento, particolarmente di area scozzese e inglese, straborda di elogi della fame come leva dell’operosità. Un noto pubblicista dell’epoca, Hutcheson, sintetizza così lo spirito del tempo: «uno dei grandi disegni delle leggi civili è rafforzare le leggi della natura attraverso le sanzioni politiche […] il popolino deve essere educato e guidato dalle leggi verso i migliori metodi di amministrazione dei propri affari e verso le arti meccaniche»; per un altro, Arthur Young (1771), «tutti, tranne gli idioti, sanno che le classi inferiori devono essere tenute nella povertà, altrimenti non lavorerebbero».4 Con le rivoluzioni del periodo tra il 1642 e il 1688 in Inghilterra, del 1776 in America e soprattutto del 1789 in Francia, la borghesia si metterà alla testa di vasti movimenti popolari contro una situazione divenuta insopportabile, conquistando (ed ereditando) la macchina dello Stato e fissando al suo interno i confini della tanto rivendicata libertà di impresa. Come ricorda Marx nel celebre libro primo del Capitale, è la monarchia costituzionale scaturita dalla gloriosa rivoluzione del 1688 che impone finalmente per legge la recinzione delle terre (anziché limitarsi a legalizzarne il furto post festum); che attraverso la legge svende i beni dello Stato ai suoi parlamentari borghesi; e che ancora sotto Giorgio II (1727-1760), quando «il modo di produzione capitalistico si era sviluppato in maniera sufficiente per rendere irrealizzabile e superflua una regolamentazione legale del salario […] non si faceva scrupolo di adoperare le vecchie armi in caso di necessità» (ibidem), fissando le paghe al ribasso (oltre a impedire le coalizioni operaie). Nell’Unione scaturita dalla rivoluzione americana, furono proprio i capitalisti più forti, legati agli ambienti finanziari di New York e Boston, ad esigere e ottenere un vero e proprio Stato federale (con un suo esercito e un governo centrale) contro l’ipotesi contraria di mantenere l’autonomia delle colonie, e dazi doganali a protezione delle manifatture; mentre i proprietari terrieri del sud, che vendevano il cotone all’Inghilterra finalmente industrializzata, volevano il “libero mercato” (nel Novecento, la posizione si rovescerà).
Infine, se il lungo e tormentato percorso della rivoluzione francese ebbe il merito di rinegoziare una volta per tutte il rapporto tra sudditi e autorità politica (limitandone l’arbitrio), essa, almeno sotto un aspetto, perfezionò la macchina dello Stato, dotandolo di una precisa ideologia: la nazione. Da allora in poi, le chiacchiere sulla «legittimità» del potere uscirono dai dibattiti dei dotti per divenire popolari, lasciando tra l’altro in eredità alle generazioni future, nella canea ininterrotta sui “diritti” e i “doveri” dei citoyens, la luminosa istituzione della leva obbligatoria.
Governare le contraddizioni
Se la società capitalistica non ha mai smesso di riprodursi anche per espropriazione, è innegabile che il suo pieno dispiegamento contemporaneo, e particolarmente ottocentesco, è segnato dall’accumulazione del capitale fondata sulla compravendita della forza-lavoro: la produzione e la vendita di merci fondata sull’acquisto a tempo di braccia, cervelli, sudore e sangue umani ridotti essi stessi a merci. Mancava solo una «forza produttiva» per fare del furto di lavoro la leva principale dell’accumulazione di capitale. Arrivò con la macchina a vapore, e la nascita del sistema di fabbrica. Col salto che impresse alla produzione, l’introduzione del macchinismo impose la necessità di allargare le maglie del reticolato in cui il capitale circolava: crescendo a volumi mai visti prima e incessantemente riprodotte dalle macchine, le merci cercavano ed esigevano sempre più sbocchi. Parafrasando Marx, se in Inghilterra il nuovo padronato compiutamente capitalistico fu “l’economista” di questa nuova trasformazione, il padronato francese ne fu il cervello politico: la libertà d’impresa sancita dalla rivoluzione, con l’abolizione di tutti i privilegi feudali e delle cosiddette “corporazioni” dell’ancien régime, anticipò, per quanto di pochissimo, quel liberismo che i nuovi «mulini satanici» (William Blake) industriali avrebbero imposto ovunque. Con le conquiste e i nuovi codici civili e penali borghesi, il genio politico di Napoleone – espressione di uno spirito francese sempre in anticipo sui tempi – introdusse il liberismo politico nelle nuove repubbliche rivoluzionarie e nei diversi Stati-satellite dell’Impero, accelerando la rivoluzione tecnologica: se le nuove macchine pretendevano una nuova economia, la nuova economia esigeva le nuove macchine. Dal canto suo, la Restaurazione non poté che accettare il fatto compiuto, incamerando tanto la prima che le seconde.
È in questa fase che la violenza strutturale dello Stato comincia a nascondersi e dissimularsi dietro il velo della violenza dispiegata, in forma apparentemente anarchica, dai nuovi rapporti sociali di produzione, fornendo alle classi dominanti il vantaggio ideologico di naturalizzare l’una e l’altra: le ingiustizie sociali cominciano ad apparire prodotti di una natura umana irremediabilmente malvagia, che lo Stato si cura di tenere a freno. Assieme alla libertà d’impresa e ai diritti dell’uomo e del cittadino, però, l’eredità lasciata dalla Grande Rivoluzione alla Francia fu – ancora una volta! – la definitiva abolizione dei diritti sulle terre comunali, al centro di un aspro scontro di classe almeno nei primi anni del decennio rivoluzionario. Il fatto compiuto comincia ad apparire eterno. Le terre comuni? E quando mai ci sono state? La polizia non fa che proteggere ciò che è e sempre sarà: ciò che è sempre stato.
Così lo Stato comincia a presentarsi come il mero stabilizzatore di rapporti sociali che si creano “da sé”, sulla spinta naturale della concorrenza; la violenza strutturale dei padroni sui servi si nasconde dietro l’eterno presente dello Stato. Dal canto suo, la macchina statale assorbe completamente le logiche, le esigenze e i ritmi del capitale, sommando il compito di governarne le contraddizioni alle sue funzioni di polizia contro le classi dominate. Le banche centrali nazionali diventano il cuore del sistema che, nella prima fase del capitalismo maturo, si pretende di far battere a ritmo costante con la base aurea (gold standard). Ciò non toglie che, anche nel pieno dell’ebbrezza liberista ottocentesca, lo Stato continua a tracciare le principali linee di sviluppo sistemiche: infrastrutturazione (particolarmente ferrovie), armamento e conquiste, attraverso l’antico sistema del debito pubblico (che come si è già accennato non è affatto una patologia recente, ma una caratteristica fondamentale della storia moderna). Non è poco, se si pensa che questa fase passa alla storia come “l’età dell’imperialismo” per antonomasia, quando l’Inghilterra realizza il più grande impero coloniale di tutti i tempi, mentre la corsa agli armamenti degli Stati per conquistarsi ciò che sarà poi chiamato “spazio vitale” determinerà l’esplosione del primo conflitto mondiale. Tuttavia, in questa nuova stagione di lotta per la potenza, lo Stato inglese può contare su un’industria (e una tecnica) in pieno sviluppo, sulla quale ha ben poco interesse e occasione di intervenire. Le stesse compagnie privilegiate, ricreate per dare l’assalto all’Oriente, vengono velocemente sciolte una volta avviata l’industrializzazione dell’India. Tutto sembra concorrere a proiettare l’immagine marxiano-marxista dello Stato-sovrastruttura, che accompagna pedissequamente lo sviluppo del capitale. Altrove, però, l’industrializzazione viene guidata dall’alto, come nella Prussia e poi nella Germania di Bismarck o nel Giappone dell’èra Meiji (dove tutto il processo di accumulazione originaria, che in Europa era durato tre secoli, si svolge nel giro di trent’anni!). Tuttavia, nell’èra dell’egemonia inglese dispiegata sui cinque continenti, la potenza diabolica del denaro venne lasciata libera di dispiegarsi come non mai; finché la crisi del 1929 rese chiaro che non la si poteva lasciare completamente a se stessa, pena il rischio di cadere per qualsiasi suo capriccio o giravolta. Com’è noto, gli anni Trenta vedono in tutto il mondo il ritorno (dai secoli del cosiddetto mercantilismo…) delle politiche protezionistiche, e l’intervento diretto dello Stato sull’economia. Ma in che maniera? E soprattutto, a partire da quali molle?
Dal keynesismo militare al liberismo militare
L’ascesa degli Stati Uniti d’America comincia col declino della potenza inglese. Incalzato dalla Germania guglielmino-bismarckiana, col suo «contromovimento protezionista» per il controllo delle rotte marittime, il Regno Unito comincia a prepararsi alla guerra: si arma fino ai denti, dedicandosi particolarmente all’ampliamento della flotta. Per farlo, comincia a indebitarsi col capitale statunitense, all’avanguardia nella produzione pesante e a sua volta indebitato con quello inglese, per ottenere forniture militari. Fino al 1914, la bilancia commerciale pendette dalla parte degli inglesi: «tra il 1850 e il 1914 gli investimenti esteri e i prestiti a lungo termine concessi agli Stati Uniti ammontarono così a 3 miliardi di dollari. Ma in questo stesso periodo gli Stati Uniti effettuarono pagamenti netti di interessi e dividendi, per lo più alla Gran Bretagna, per un totale di 5,8 miliardi di dollari» (Arrighi, cit). A guerra iniziata, il rapporto si rovesciò: «nel 1915, tuttavia, la domanda di armamenti, macchinari e materie prime da parte della Gran Bretagna superava di gran lunga quella programmata dalla Royal Commission nel 1905. Buona parte dei macchinari necessari potevano essere forniti solo dagli Stati Uniti, e fu il loro acquisto che avviò l’erosione dei titoli inglesi sui redditi prodotti negli Stati Uniti e l’aumento dei titoli statunitensi sui redditi e sulle attività inglesi» (ibidem). Niente di strano: il Regno Unito era stato in guerra cinque anni; gli USA circa uno. Il logoramento bellico dei primi fece la fortuna dei secondi; il dollaro salì la gerarchia dei pagamenti internazionali, divenendo moneta di conto insieme alla sterlina. Tuttavia, gli americani seppero approfittare relativamente poco di questo primo giro di boa. Da liberisti rozzi e faciloni, sottovalutarono la potenza diabolica. Incapace di gestire la speculazione, una Federal Reserve ancora ai primordi, priva di statuti precisi e dai lineamenti pubblico-privati indefiniti, conobbe presto le sante virtù del mercato autoregolato: il risultato fu la crisi del 1929. Le note politiche “espansive” keynesiane, con la creazione di debito pubblico vòlto a far ripartire produzione e occupazione, tamponarono la crisi senza mai risolverla. Finché il secondo conflitto mondiale, l’equilibrio del terrore nato a Jalta e la lotta di classe che esplodeva in tutto il mondo, non riuscirono a mettere d’accordo governo degli Stati Uniti e alta finanza: «Quello che i calcoli costi-benefici non potevano conseguire […] poté invece la paura. Finché i capitali eccedenti stagnarono negli Stati Uniti e nel loro entroterra regionale (Canada e America Latina), il caos in Eurasia continuò ad aggravarsi e a creare un terreno fertile per l’assunzione del potere statale da parte di forze rivoluzionarie. L’idea geniale di Truman e dei suoi consiglieri fu quella di attribuire il risultato di circostanze sistemiche che nessuna particolare forza aveva creato o controllava alle presunte inclinazioni sovversive dell’altra superpotenza militare, l’Unione sovietica» (ibidem, ultimo corsivo mio). Si noti, in quest’ultimo passo, la perfidia di Arrighi: l’Unione Sovietica non voleva fare la rivoluzione, ma le élite finanziarie di New York non lo sapevano. «L’invenzione della guerra fredda», sorta di bufala complottista per i ricchi, richiamò i banchieri ignoranti alla ragion di Stato, convincendoli a fare il proprio dovere. Di nuovo, a tornare in gioco sono le armi: con la guerra di Corea dei primi anni Cinquanta, «gli aiuti militari ai governi stranieri e le spese militari statunitensi dirette all’estero […] garantirono all’economia-mondo tutta la liquidità di cui aveva bisogno per la propria espansione». Il «debito buono» (militare) fece ripartire l’economia: la massa di denaro che ne fu generata alimentò la spettacolare ripresa industriale del secondo dopoguerra; il keynesismo realizzò finalmente le sue promesse come keynesismo militare. Con le “istituzioni di Bretton Woods”, e in particolare la creazione del Fondo Monetario Internazionale, il capitale statunitense si installò al vertice della catena mondiale del valore, manipolando l’emissione del credito a livello internazionale. Lasciamo la parola alla sintesi operata recentemente da alcuni compagni: «Il sistema prevedeva un rigido controllo dell’economia da parte di una piramide gerarchica di Stati ovviamente a egemonia americana […] così strutturata: al vertice c’era il dollaro, l’unica moneta convertibile in oro; subito dopo c’era la sterlina inglese e poi sarebbe emerso il marco tedesco; tutte le altre monete [… erano convertibili] in dollari e dovevano vincolarsi a un tasso di oscillazione dell’1% annuo. Solo se il loro bilancio fosse stato gravemente in crisi potevano concedersi di svalutare fino al 10%, ma se […] avessero voluto svalutarsi ancora oltre, avrebbero dovuto chiedere il permesso al Fondo Monetario Internazionale. Ovviamente l’azionista di maggioranza era (e lo sono ancora) gli Stati Uniti d’America, pertanto queste richieste di svalutazione venivano concesse in cambio di favori politici, militari o di altra natura agli USA. Attraverso la catena di Bretton Woods, quindi, gli USA utilizzavano la leva monetaria per le proprie politiche imperialistiche. […Tuttavia], pur potendo dominare il mondo dal vertice della piramide, gli USA non erano liberi in casa propria. La loro moneta, infatti, era la sola che non si poteva svalutare, essendo legata al dollaro. È stato così che Nixon ha deciso nel 1971 di mandare tutto all’aria [abolendo la convertibilità del dollaro in oro] (aveva bisogno di stampare dollari a causa della guerra in Vietnam). In Europa nel frattempo anche la Francia stava svalutando per rispondere al maggio ’68, l’Italia stampava lire per recuperare con l’inflazione gli aumenti salariali ottenuti con l’autunno caldo […]. La guerriglia in Vietnam, il maggio ’68, l’autunno caldo italiano, le tensioni coi paesi arabi… tutto questo ha dato un duro colpo all’economia occidentale» (Economia della miseria, “Vetriolo”, num. 6, estate 2021, corsivo mio). Negli anni Settanta, insomma, il capitalismo a trazione statunitense era assediato da tutte le parti, dalle lotte di classe e contro l’imperialismo; fu ancora la spesa militare (stavolta per il Vietnam) a spingere in avanti le lancette della storia. Svincolato dalla convertibilità in oro (e quindi “stampabile” all’infinito), il dollaro inondò il mercato mondiale; con la conseguenza per nulla ricercata di avvantaggiare tutti i concorrenti degli USA (negli anni Settanta, la quota non-statunitense del profitto mondiale passa dal 48 al 58% del totale, cfr. ancora Arrighi). Ad approfittarne furono soprattutto i Paesi del “terzo mondo”, già nel pieno delle rivoluzioni anticoloniali, e in particolare quelli che producevano petrolio. Mentre l’impantanamento statunitense in Vietnam infliggeva colpi durissimi al prestigio militare del dominus a stelle e strisce, umiliato da uno dei popoli più poveri della terra, una coalizione araba guidata da Egitto e Siria faceva altrettanto contro Israele nella guerra dello Yom Kippur. Sulla spinta dei mutati rapporti di forza, l’organizzazione dei Paesi produttori di petrolio (OPEC) decise il rialzo unilaterale dei prezzi del greggio, determinando la crisi petrolifera del 1973. La golden age del capitalismo cominciò a chiudersi: i Paesi subordinati non accettavano più di restare al proprio posto ad alimentare il “benessere” occidentale. Ci vollero tuttavia alcuni anni prima che la reazione padronale riuscisse ad attivarsi: gli anni Settanta furono tanto un’età nera per il capitalismo egemone quanto una nuova èra della cuccagna per gli sfruttati di tutto il mondo, con una redistribuzione di ricchezza mai vista prima. La contro-insurrezione riuscì ad attivarsi solo alla fine del decennio, con un cambiamento della politica economica, e facendo dello stesso riarmo un’arma economica. Ancora una volta, a sbloccare la situazione fu la paura, stavolta ingenerata dall’Iran, dove la rivoluzione del 1979 strappava agli USA proprio quel Paese su cui essi avevano più investito per controllare il Medio Oriente: ne seguì il secondo shock petrolifero. La prima manovra di risposta venne dalle banche: sotto la guida di Paul Volcker, la Federal Reserve e l’FMI al seguito cominciarono ad attuare una politica monetaria restrittiva, alzando i tassi di interessi sui prestiti, così da produrre una contrazione del mercato mondiale (per i profani: più si alzano i tassi d’interesse, meno denaro circola, più il denaro vale; ma l’effetto è anche di deprimere gli investimenti nell’economia reale). I produttori di petrolio del “terzo mondo”, fino al giorno prima corteggiati dai banchieri di tutto il globo, cominciarono a vedere vuote le loro anticamere: adesso che i dollari in circolazione erano meno (e quindi valevano di più), gli investitori tiravano a tenerseli (per reinvestirli nella speculazione finanziaria) anziché spenderli nell’acquisto di materie prime. Strano a dirsi, il prezzo del greggio, anziché diminuire, cominciò a lievitare: reinvestito, durante i decenni precedenti, nelle riserve di dollari europei (la cosiddetta “eurovaluta”, che coincideva in larga parte con i petroldollari, cioè i dollari ricavati dal petrolio), il valore di mercato dell’oro nero seguì la moneta egemone mondiale nel suo processo di rivalutazione: schizzò alle stelle, determinando a sua volta un rialzo dei prezzi di tutte le materie prime. In un contesto di depressione dell’economia reale, e quindi di minor richiesta da parte delle industrie, i Paesi produttori (ovvero, in larga parte, i Paesi “poveri”) non riuscivano più a piazzare le materie prime sul mercato mondiale; nel frattempo, il dollaro rivalutato gonfiava i debiti contratti con l’FMI (siccome adesso il dollaro valeva di più, i prestiti contratti in dollari si accrescevano conseguentemente): cominciava la politica della assoluta condizionalità: se vuoi continuare ad avere prestiti, o dilazioni sul pagamento dei debiti precedenti, mi fai le riforme strutturali, ovvero apri la tua economia ai miei investimenti e mi cedi le tue risorse a prezzi stracciati. Con l’elezione di Reagan nel 1981, la reazione imperialista si completò: sfidando nella corsa agli armamenti un’Unione Sovietica già indebolita dalla stagnazione del mercato delle materie prime, Reagan ne portò a termine l’erosione economica: per tenere testa al riarmo statunitense, tutto il plusprodotto degli operai sovietici finiva adesso in armi, soprattutto nucleari; il gigante “rosso” barcollava e sarebbe presto caduto. Dal canto loro, con la costante crescita della spesa militare, gli USA vedevano aumentare il debito pubblico a livelli mai visti, trasformandosi nel Paese più indebitato del mondo (un primato che non hanno mai smesso di detenere). Ma stavolta, a differenza degli anni Cinquanta e Sessanta, la massa di denaro creato col debito finiva solo in misura minore alle industrie non-belliche, e veniva ingoiato dall’alta finanza: tassi di interesse reali particolamente severi sorvegliavano l’accesso al credito alle piccole e medie imprese, mentre incoraggiavano il prestito a interesse sui mercati finanziari, già ampiamente “deregolamentati” dall’abbandono della base aurea nei Settanta (poiché il denaro, non più vincolato all’oro, era “stampabile” all’infinito, la solvibilità dei debiti pubblici non era più un problema). In altre parole: anche stavolta veniva creato denaro dal nulla, attraverso la spesa militare; ma alla “economia reale” toccavano le briciole (in relazione, ovviamente, alla massa di moneta complessivamente prodotta). Mentre si estendeva all’Europa passando dall’Inghilterra di Margareth Thatcher, la deregulation reaganiana, con l’abolizione di ogni vincolo all’attività di impresa, compensava la strozzatura del credito con l’attrazione di investimenti di ogni tipo, ma favorendo sistematicamente le imprese più forti (le famigerate “multinazionali”), che a loro volta si finanziarizzavano reinvestendo i profitti nelle Borse. A sostenere le azioni provvede in gran parte il plusvalore estratto dai Paesi del “terzo mondo”, ricattati dall’FMI. Così, col passare degli anni, si stringe sempre di più un circolo vizioso: solo le grandi impresi possono indebitarsi, mentre finiscono per ricavare gran parte dei loro profitti dal prestare. Sarà la crisi del 2008 a presentare il primo conto di questo vero e proprio delirio economico autoalimentato.
Nelle braccia del Leviatano
Torniamo adesso all’analisi dello Stato. Prima di esaminarne le differenze, ricerchiamo i tratti comuni tra lo Stato antico e moderno. Come si è visto, lo Stato nasce e si mantiene fondamentalmente come un tecnologia sociale di guerra, vòlta a mantenere l’unità collettiva – e quindi anche a frenare il conflitto di classe – in vista di possibili conflitti con altri Stati. Tuttavia, se lo Stato è anche questo, non è solo questo. Per sancire la propria unità, esso deve assumere molteplici tratti soggettivi: radicato su un territorio, ha una propria storia, i propri simboli (il fascio littorio nello Stato antico, le bandiere nella modernità…), i propri miti, spesso una propria ideologia più o meno definita; ma soprattutto si assegna una precisa missione morale: difendere la propria popolazione dagli altri e dal caos, ed eventualmente conquistarle spazio vitale. Il fatto che poi finisca per difendere e affermare se stesso, e tutta la rete di manutengoli che gli ruotano attorno, piuttosto che la popolazione astrattamente considerata, ci dice solo della sua natura alienante; il fatto che tenda a selezionare come proprio personale i più farabutti, spietati e ambiziosi (dal loro punto di vista: i più realisti) ci dice molto del suo carattere, ma non ci dice per forza che questi non credano alla propria missione: chi non sa «mantenere lo Stato» è uno statista fallito. Così, se la connotazione dello Stato come persona morale non può che apparire una fumisteria giuridica e ideologica, ciò non toglie che abbia una sua realtà: richiamandoli alla propria funzione, l’ideologia agisce sugli esseri umani e produce effetti concreti («il senso dello Stato»); mentre d’altra parte, come “istituzione” nel significato più generale della parola, lo Stato forza gli individui a comportarsi diversamente da come farebbero, lasciando da parte tanto le proprie voglie come la propria “sensibilità” o “coscienza”. Così, irreggimentando la loro attività, lo Stato vi si sostituisce, fino a divenire «la costituzione esterna della potenza sociale» (Proudhon). Gli individui continuano a cooperare tra loro: ma gran parte della loro attività cooperativa si svolge nelle forme e modalità previste dallo Stato, quando non direttamente al suo servizio: gran parte delle interazioni umane sembrano adesso svolgersi da sé, persino indipendentemente dal loro concorso: le tasse che pago (che siano frutto del mio lavoro o del lavoro estorto ad altri, è in questo caso secondario) potranno servire a costruire l’acquedotto o una nuova fortezza, indipendentemente dal fatto che io li costruisca direttamente, e dalla mia volontà che esistano. In un modo o nell’altro, la mia potenza ne risulta espropriata. La differenza tra Stato antico e moderno è come viene compiuta questa espropriazione.
Lo Stato antico soffocava il “capitale” («il denaro che genera denaro») sussumendo l’economia in un sistema burocraticamente accentrato, che esercitava un semplice prelievo dall’attività economica attraverso le tasse. Così esso tendeva a riprodurre la vita economica tale e quale, mantenendo il denaro come mero mezzo di scambio delle cose, e per il resto tendendo ad allargare solo la propria struttura burocratico-militare. Nella Roma imperiale la vita economica si espandeva al seguito dello Stato: gli interessi del padronato di allora si ampliavano di territorio in territorio al traino dell’espansione imperiale. Questo, a sua volta, determinava effetti sui rapporti di classe (e casta): l’accrescimento della struttura burocratico-militare causava un prelievo crescente di risorse materiali e umane: lavoro schiavistico e salariato-servile, e una ridefinizione dei rapporti di forza (con l’aggiramento del Tribunato, attribuito agli imperatori dall’età di Augusto): ma sempre al passo dello Stato. Lo Stato moderno, viceversa, continua ad espropriare l’attività sociale proprio come l’antico, ma si trova alle prese con una attività già parzialmente sussunta e che non può controllare, perché circola al di là dei confini: il denaro. Preso atto della sua incontrollabilità, deve dunque rincorrere e attrarre il maledetto «capitale mobile»; trovandovi la propria principale fonte di potenza, deve anche curarlo, accrescerlo, espanderlo. Questo non significa però che lo Stato scompaia o si subordini interamente alla potenza diabolica del denaro: al contrario, quello Stato che riesca a catturarla con successo ne trae benefici enormi in termini di potenziamento, che potrà sia utilizzare in funzione della propria unità (rafforzando la propria struttura burocratico-militare, la propria propaganda, il proprio prestigio o ancora il consenso della propria popolazione, qualora redistribuisca la ricchezza prodotta), sia contro gli altri Leviatani, nel conflitto armato o in altre modalità di competizione. Questa differenza di fondo determina tutte le altre, in primis quella delle forme del dominio di classe: l’integrazione delle classi dominanti all’interno dello Stato antico, come caste; la loro esternità, ma marcatamente privilegiata, nello Stato moderno. In secondo luogo, a cambiare è il rapporto con la potenza in senso strettamente militare. Se il modello antico avanzava attraverso la cultura della potenza (in latino la virtus è prima di tutto la virtù in guerra, il valore del vir: il maschio-guerriero), il modello moderno può fare anche altrettanto,5 ma soprattutto incorpora la potenza negli oggetti.6 Ciò che fondava il potere delle classi dominanti nello Stato antico (il possesso delle armi, e più in generale il loro concorso economico alla sua potenza) vede lo Stato moderno dotarsi delle prime (le armi) e favorire il secondo (il concorso dei ricchi) con un’unica mossa: l’indebitamento statale finalizzato a stimolare “l’attività economica”. Così lo Stato, più che una sovrastruttura, appare come sotto-struttura del capitale: sua base necessaria, che precede, prepara, segue, alimenta, soccorre la sua espansione e accumulazione. Marx sembra intravederlo proprio quando affronta la questione del debito pubblico: «Il debito pubblico, ossia l’alienazione dello Stato […] imprime il suo marchio all’èra capitalistica. Come con un colpo di bacchetta, conferisce al denaro, che è improduttivo, la facoltà di procreare, e così lo trasforma in capitale, senza che il denaro abbia bisogno di assoggettarsi alla fatica e al rischio inseparabili dall’investimento industriale e anche da quello usuraio. In realtà i creditori dello Stato non danno niente, poiché la somma prestata viene trasformata in obbligazioni facilmente trasferibili, che in loro mano continuano a funzionare come se fossero altrettanto denaro in contanti» (Il Capitale, libro primo). Ma poi il Moro di Treviri, come sempre quando si trova ad affrontare il tema, abbandona l’intuizione, derubricandola alla voce «accumulazione originaria», che viene ulteriormente specificata come «alienazione dello Stato»… senza voler vedere che alla base c’è una «alienazione» di segno opposto. È vero che lo Stato «si aliena» (cioè si fa altro e insieme si estrania) nel capitale, perché vi trasferisce la propria potenza; ma questo è possibile perché lo Stato si è prima alienato tutta la vita sociale, compresa quella economica. Se lo Stato diventa dipendente dal capitale come da una droga, la dipendenza è reciproca: senza il colpo della bacchetta magica statale, la potenza diabolica del capitale si estinguerebbe velocemente per asfissia; mentre lo Stato, che pretende di non riconoscere alcun superiore (superiorem non recognoscens), potrebbe terminare il patto diabolico con un colpo di bacchetta, o almeno rinegoziarlo. In fondo, cos’è che tiene insieme tutta la baracca? La forza armata… dello Stato. Cosa fa sì che il denaro valga qualcosa anziché nulla? Lo Stato. Che poi l’autorità politica possa o non possa svincolarsi dai diktat del capitale, o meglio che possa farlo in una certa misura, dipende dalle circostanze e dai rapporti di forza: dallo spazio che il singolo Stato occupa sul mercato internazionale, dalle pretese della sua popolazione e dalla capacità di tenerla a bada, dalle minacce che deve affrontare da parte di altri Leviatani, dal suo livello di dipendenza dalle malìe del denaro… Tutto preso dalla sua metafisica materialista, attendendo da un momento all’altro la rivoluzione comunista che non poteva non accadere, Marx tirò dritto sulla questione, limitandosi a prendere in considerazione solo lo Stato del suo tempo e per di più dalla sua visuale londinese, in un’Inghilterra in piena sbornia liberista. Oltre a ciò, Marx era anche il capo di un movimento politico che pretendeva di rappresentare «il movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti», identificato col proletariato di fabbrica: e gli operai, salvo una minoranza pronta alla lotta “eroica” e “apostolica”, volevano anche votare, conquistando rappresentanti in parlamento che gli facessero da tribuni. Va bene denunciare le “degenerazioni parlamentari”, ma insomma, rinunciarvi del tutto… Così, con la sua penetrante intelligenza, il Moro ci ha lasciato pagine bellissime sull’accumulazione originaria (e pagine interessanti, ma sempre reticenti, sullo Stato), senza però trarne le debite conseguenze.
Statalizzazione finanziaria
È quasi un luogo comune dire che le guerre scoppiano nei momenti di «crisi». Se c’è sicuramente del vero nel dire che con la guerra lo Stato esporta la crisi fuori dai propri confini, ricompattando la propria popolazione nello sforzo bellico, questo lo è soprattutto in senso sociale o “sociologico”. Ma c’è anche una precisa ragione materiale: la bacchetta magica dello Stato agisce quando ce n’è bisogno, quando il capitale è in affanno, e lo fa principalmente investendo in armamenti. A quel punto i Leviatani si scrutano: ciascuno, vedendo le armi avversarie, comincia a preparare le proprie. I capitalisti fiutano l’affare, e iniziano a soffiare sul fuoco della guerra. Tuttavia, la bacchetta magica può essere usata anche in altri modi, non “bellici” in senso stretto. Pensiamo ad esempio alla linea ad Alta Velocità (un’altra valanga di debito pubblico, e di dimensioni europee). Decantando il suo valore strategico, lo Stato la invoca e la impone in nome del bene comune, dello sviluppo, del progresso ecc.: pazienza se intere generazioni dovranno ripagarla. Ora, non c’è dubbio che il TAV sia strategico, ovviamente in senso capitalistico: ogni “grande opera” ne chiama un’altra, e determina una serie di conseguenze. Così la parziale realizzazione del TAV in Italia ha provocato prima di tutto l’aumento generalizzato delle tariffe ferroviarie, poi il progetto «Grandi Stazioni», le quali a loro volta hanno fatto da volano al car sharing Frecciarossa-ENI, che a sua volta è un passo in direzione della smart city e del furto elettronico di dati ecc. (ultimamente, sulla spinta dei venti di guerra, sta emergendo anche un uso militare del TAV, per lo spostamento veloce di soldati, armi, forniture belliche). Ma anche se alcuni tratti della linea Alta Velocità non fossero completati, essi contribuirebbero comunque a profitti capitalistici di tipo finanziario. La finanza si fonda sulla dilazione dei pagamenti, sul “prima o poi pagherò”, su soldi che potranno arrivare in futuro ma che attualmente possono anche non esserci: un’azione dell’Alta Velocità è una promessa su soldi che attualmente non ci sono. Una società finanziarizzata è quindi una società altamente statalizzata, in cui lo Stato interviene continuamente sulla vita per dare un minimo di concretezza al denaro che non ha e in fondo non c’è; ogni suo intervento è un’ipoteca sul futuro, che porta sempre con sé un carico di rapina, oppressione e militarizzazione; che non distrugge solo risorse materiali, ma anche spirituali: modi-di-stare-insieme, modi di vita, piccole e grandi cosmovisioni. Più la «crisi» avanza (ovvero più il capitale non riesce a trovare una valorizzazione sufficiente nello sfruttamento della forza-lavoro), più la bacchetta magica statale deve intervenire. Oggi la notte è più avanti che mai. Come ci ha mostrato Arrighi, storicamente i «cicli sistemici di accumulazione» (“spagnolo-genovese”, olandese, britannico, statunitense) hanno raggiunto i loro esiti critici in un numero di anni sempre più breve, passando da momenti di espansione materiale (territoriale, industriale) alla mera rapina finanziaria in tempi altrettanto contenuti. Per spiegare questa ciclicità della caduta del saggio di profitto, non occorre mobilitare per forza il «mutamento della composizione organica del capitale», l’esigenza capitalistica di investire in «capitale fisso», macchine e materie prime ecc. Se anche questo ha un ruolo (come vedremo tra poco), la meccanica alla base delle crisi tende ad accelerarsi per la stessa espansione dell’economia-mondo, che attira nella propria orbita sempre più investitori: il risultato è l’esasperazione della concorrenza, con la caduta dei prezzi in tempi sempre più veloci. Un’ulteriore espansione appare al momento impossibile. Non solo perché, da un punto di vista geografico, il capitalismo ha raggiunto ogni angolo del globo; ma anche perché un ulteriore sviluppo delle sue aree più arretrate entrerebbe in contraddizione con le sue esigenze di riproduzione a livello mondiale. Per produrre le merci, non basta trovare salariati che le producano: quelli si trovano sempre, mentre nel mondo la massa dei disoccupati o degli “intermittentemente occupati” ha raggiunto quote mostruose. Servono anche consumatori che assorbano i prodotti; ma i consumatori devono essere essi stessi “prodotti” dallo sviluppo industriale, che nelle poche terre ancora “vergini” (particolarmente l’Africa) è impedito dall’intervento predatorio dell’imperialismo, con il cappio del debito: e laddove si impedisce lo sviluppo industriale, così da non creare nuovi Paesi concorrenti e continuare a succhiare risorse, non possono formarsi sacche significative di consumatori seriali. L’espansione industriale a Oriente, e particolarmente in Cina, ha tamponato per un po’ di anni la crisi del capitalismo attraverso il “doppio furto” del plusvalore (rubato dalle classi dirigenti orientali ai propri operai, e succhiato a sua volta dal capitale occidentale ai padroni orientali). Adesso, non solo l’accumulazione del capitale in Oriente comincia a mostrare la corda (la Cina avrebbe raggiunto il proprio picco di produttività da una decina d’anni a questa parte); ma il proletariato orientale rivendica il proprio plusprodotto contro i propri padroni, i loro padroni rivendicano la propria fetta del mercato mondiale, le società orientali nel loro complesso pretendono di accedere a consumi di tipo occidentale… Il sistema è bloccato: non potendo espandersi, cerca semplicemente di riprodursi. Qui entrano in gioco il «capitale fisso» e soprattutto il capitale immateriale. Come ha mostrato Jeremy Rifkin in un libro pionieristico (L’era dell’accesso, 1999), già alla fine degli anni Novanta il capitale tendeva a ridimensionare le spese in macchinari attraverso varie strategie: in particolare con reti di collaborazioni e subappalti (più aziende si servono degli stessi macchinari) e soprattutto con la produzione just in time (si producono solo le merci che già si pensa di poter vendere, e le si produce man mano che le si vende: così da un lato si cerca di aggirare il rischio di non riuscire a smerciarle, e dall’altro si risparmia sui costi di stoccaggio). A scaturirne è stata non solo un’economia di velocità (non “vince” tanto chi produce di più a prezzi più contenuti, ma chi piazza prima le proprie merci: da qui il ruolo sempre crescente della logistica) ma anche un’economia di previsione e induzione (“vince” chi riesce a prevedere l’esito dell’investimento e a indurre bisogni consumistici). Queste basi, a partire dalle scoperte degli ingegneri di Google sul surplus comportamentale, hanno reso i Big Data il nuovo “oro nero” di questo inizio millennio, poiché la possibilità di piazzare velocemente le proprie merci muove dalla profilazione dei consumatori: così la valorizzazione dipende oggi in larga parte da risorse improduttive e in parte anche immateriali: il comparto logistico è materiale, ma non produce nulla di materiale; i Big Data necessitano ovviamente della rete internet, quindi dei computer e dei grandi server, quindi di una catena che va dall’estrazione di terre e metalli rari alla produzione dei supporti informatici, fino allo smaltimento dei rottami elettronici: ma di per sé i Big Data non sono altro che “pacchetti elettronici”, e non producono altro che i consumatori stessi. Se a questo aggiungiamo che il sempiterno indebitamento statale nelle spese militari oggi non è separabile dalla ricerca tecno-scientifica, poiché tutte le applicazioni della tecno-scienza hanno ormai un carattere duale, civile e militare; che nessun campo di ricerca è separabile dall’altro, ma ciascuno riversa nell’altro i saperi prodotti (per esempio, gli studi di biologia molecolare, biotecnologia, nanotecnologia guardano anche alla produzione di computer con caratteristiche organiche, mentre oramai non c’è ricerca che non si avvalga dell’Intelligenza Artificiale); che la concentrazione finanziaria ha raggiunto livelli inauditi (tra i grandi fondi di investimento, il solo Black Rock controlla più del 40% dell’economia globale), mentre la giostra dei mercati necessita sempre più di iniezioni di liquidità statale; che colossi informatici come Google e Microsoft (col loro indotto al seguito: Amazon) sono di fatto fusi col Pentagono degli Stati Uniti… ci si rivela tutto il ridicolo di chi ci accusa di soggettivizzare esageratamente il capitalismo, con la solita tiritera di formulette marxisteggianti. La giostra finanziaria fa capo a sempre meno investitori, mentre gran parte dei valori che vi vengono scambiati (come quelli militari e tecno-scientifici) trovano negli Stati più potenti i loro consumatori unici; altri – come i Big Data – fanno capo a colossi informatici legati a doppio filo al governo degli Stati Uniti, che non si sogna neanche lontanamente di partorire una legge anti-trust per smantellarli; tutti i valori, anche quelli ancora legati alla produzione, dipendono in ultima istanza dalla predazione di risorse militarmente organizzata dagli Stati.
Se il capitale in sé considerato non è minimamente un soggetto, ma piuttosto un fenomeno o un rapporto sociale acefalo o forse policefalo (nella forma di gruppi di interesse – industriali, bancari – capitalistici); il capitalismo sembra oggi assumere i tratti soggettivi dello Stato, nella forma di un qualcosa di antico sotto abiti nuovi: il suo nome, per ora, è stakeholder capitalism: “capitalismo dei portatori di interesse”, con la tecnocrazia come sua forma politica.
Controllo della vita
Oggi il mantenimento dello Stato, di tutti gli Stati, passa dal mantenimento dell’ordine internazionale, che a sua volta dipende dalla stabilità dei “mercati”, ovvero dalla giostra finanziaria mondiale. Se ogni “attore” (compreso ogni Leviatano) continuerà a fare il proprio gioco, è interesse di ognuno di essi far girare la giostra. Mentre il ruolo economico del Leviatano è sempre stato quello di tenere in vita la potenza diabolica del capitale indebitandosi, nella «crisi» tutti gli Stati sono chiamati a fare la propria parte, e nessuno può tirarsene fuori. A invogliarli, alla bisogna, saranno sconti e prebende (o minacce…) del Fondo Monetario Internazionale. Se questo esige misure straordinarie e distruttive per la vita, tanto peggio per la vita.
Oggi l’ordine internazionale vede una gerarchia di Stati ben individuabile, con gli USA al vertice e tutti i Paesi del G7 subito sotto, uniti in una sorta di “Occidente collettivo” che domina o tenta di dominare tutti gli altri, e la Gran Bretagna come partner privilegiato degli statunitensi (viste le numerose “porte girevoli” tra i loro apparati militari-industriali, come nel caso della DARPA del Pentagono e del Wellcome Trust britannico; stakeholder capitalism, appunto). Per quanto gli interessi specifici dei vari Stati “occidentali” possano divergere, i loro interessi generali – coloniali e imperialistici – sono assicurati dagli Stati Uniti, prima potenza militare del mondo. Il mercato mondiale, nella forma di Borse strabordanti di valori fittizi e sempre sull’orlo di una crisi di nervi, estende la rete di complicità tra i Leviatani e insieme ne esaspera le rivalità. Le Banche centrali, a partire dalla Fed, sembrano ormai trasformate in termostati impazziti che alzano e abbassano da un giorno all’altro le temperature dei mercati, attraverso la manipolazione dei tassi di interesse. La potenza diabolica del denaro pare ormai sfuggita di mano ai suoi padrini: il diavolo presenta il conto del patto ai suoi dissennati sottoscrittori. Tuttavia, se i Leviatani non possono controllare del tutto la potenza che hanno trasferito nel capitale (e che cercano di trarre da esso senza posa), possono ben servirsene per controllare gli umani, adattandoli alle esigenze di una “economia” burocraticamente manovrata con l’attivazione di una molteplicità di mezzi: dalla rete internet alle istituzioni internazionali. L’Occidente collettivo, e in particolare il complesso militare-industriale statunitense, ha predisposto da tempo le sue cabine di regia. Una di queste è senz’altro il Center for Health Security della John Hopkin’s University, divenuto durante la dichiarata pandemia il principale aggregatore di dati mondiali (“casi”, ricoveri, decessi ecc.) sulla Covid-19. Come ricostruisce il giornalista tedesco Paul Schreyer nella sua Cronaca di una crisi annunciata (edita in italiano dal gruppo OVALmedia), il Center nasce nel 1998 col nome decisamente più militare di Center for Civilian Biodefense. Si tratta di un centro-studi per la biosicurezza, che da più di vent’anni si occupa di predisporre la gestione di epidemie e pandemie, attraverso la loro simulazione nella forma di giochi di ruolo: membri dell’establishment economico, politico, militare, scientifico si siedono al tavolo e giocano a interpretare un certo ruolo secondo un copione predisposto. Alla prima conferenza del Center (Washington, febbraio 1999), l’allora coordinatore nazionale antiterrorismo degli USA, generale Richard Clarke, dichiara: «Per la prima volta il Ministero della Salute entra a far parte dell’apparato nazionale di sicurezza degli Stati Uniti». Nei vent’anni seguenti, e con più frequenza dopo l’11 settembre 2001, il Center si dedicherà a simulare epidemie dovute ad attacchi bio-terroristici. I copioni delle simulazioni contengono tutti gli elementi che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi due anni: lockdown, divieti di assembramento, mascherine, vaccini approntati a tempo di record, controllo centralizzato dell’informazione… All’indomani di una crisi di borsa a settembre 2019, i cui effetti sono stati contenuti con un’immissione di liquidità «senza precedenti» nei mercati da parte della Fed,7 il 18 ottobre, all’Hotel Pierre di Manhattan, il Center mette in campo una simulazione chiamata Evento 201, particolare sotto molti punti di vista. Per i finanziatori: Fondazione Melinda & Bill Gates e World Economic Forum (per chi non lo sapesse: l’assemblea degli uomini più ricchi del mondo). Per il tema: che stavolta non è più un “attacco bioterroristico”, ma una crisi sanitaria indotta da un virus zoonotico simile alla Sars ma più lieve, passato dai pipistrelli all’uomo. Per la modalità: stavolta, a differenza delle precedenti, i partecipanti non interpretano altri, ma se stessi: ciascuno nel ruolo che avrà neanche due mesi dopo. Per i partecipanti stessi: il vicepresidente di Johnson&Johnson; la presidente della CEPI (Coaltion for Epidemic Prevention Initiative, una creatura dei Paesi del G7 in combutta con farmaceutiche e OMS) nonché ex-ministra della salute e delle finanze australiana; il presidente della corporation delle comunicazioni Edelman nonché consulente di Microsoft; i direttori dei “Centri per il controllo delle malattie” (CDC) statunitense e cinese (praticamente gli omologhi del “nostro” Locatelli e del “nostro” Consiglio Superiore di Sanità); il direttore del dipartimento per le emergenze sanitarie dell’OMS; la presidente del potentissimo cartello dell’informazione NBC; tre membri della Fondazione Gates specializzati in controllo demografico (Family Planning), tra i quali Timothy Grant Evans, passato dai vertici della Fondazione Rockfeller, dell’OMS e della Banca Mondiale prima di co-fondare la GAVI (l’Alleanza internazionale per la promozione dei vaccini promossa dalla stessa fondazione Gates). Ultima ma nient’affatto meno importante, l’allora vicedirettrice della CIA Avril Haines, oggi promossa ai vertici dei servizi segreti nazionali, incaricata di tenere i rapporti tra intelligence, Pentagono e colossi informatici.
Vi sembra incredibile che alcuni degli uomini più potenti del mondo abbiano simulato tale e quale la “pandemia” neanche due mesi prima del suo scoppio? Questo scarno resoconto vi sembra una “teoria del complotto”? E perché mai si dovrebbe utilizzare questa parola? In questo caso è impropria due volte: primo, perché non si è trattato affatto di una riunione segreta, ma svoltasi alla luce del sole (i verbali e i video sono stati tutti pubblicati su internet, e in particolare sul sito del Center: centerforhealthsecurity.org). Secondo, perché non siamo di fronte a oscuri cospiratori che vogliono prendere o controllare il potere costituito, ma a chi il potere ce l’ha già, trovandosi ai vertici dello Stato e delle fondazioni più potenti del mondo, o di istituzioni internazionali come l’OMS, i cui primi finanziatori sono… gli USA e la Fondazione Gates. In breve, Event 201 non è stata altro che una delle tante riunioni dell’Apparato, e probabilmente solo una delle occasioni in cui è stato pianificato ancora una volta un trauma necessario alla sopravvivenza del capitalismo. Bisognava indurre e giustificare l’ennesima iniezione di denaro pubblico nelle Borse: in assenza di una guerra contro un nemico visibile, la si è proclamata contro un nemico invisibile. Bisognava fare arrivare il meno possibile la liquidità prodotta col debito pubblico nella cosiddetta “economia reale”, così da non fare esplodere l’inflazione: lo si è fatto prima con lockdown totali e parziali, e poi coi certificati verdi, scoraggiando l’accesso al credito della piccola imprenditoria (chi prenderebbe un prestito in banca, quando non sa neanche se potrà lavorare la settimana successiva?). Bisognava affrontare due volte una crisi economica devastante, contenendone gli effetti e stornandone la rabbia della popolazione impoverita: la si è rinviata con un’incredibile manovra di shock economy, e mascherata da crisi sanitaria. Bisognava dare impulso al capitale immateriale e alla tecno-scienza: lo si è fatto col furto di dati (DAD, smart working) e con la sperimentazione di massa di “vaccini” biotecnologici. Bisognava disciplinare la popolazione e piegarla alle esigenze cibernetiche del capitalismo: lo si sta facendo col green pass e col sistema dell’Identità Digitale. Bisognava prevenire le previdibili battaglie contro i progetti più devastanti e strategici del capitalismo, a partire dalla rete 5G: si sono ridicolizzate le preoccupazioni verso di essi associandole al “complottismo”. Bisognava portare avanti il potere dell’Apparato sui propri sudditi per scaricargli addosso la crisi: lo si sta facendo riportando indietro le lancette della storia: verso lo Stato Assoluto, ma stavolta tecnologicamente equipaggiato e tendenzialmente mondiale.
Contro l’Impero, contro lo Stato
Lasciato a se stesso, il movimento del capitale tenderebbe oggi a dirigersi a Oriente, laddove troverebbe ancora condizioni adatte per un proprio sviluppo industriale e commerciale. Ma oltre a urtare contro gli ovvi limiti geografici cui accennavamo sopra (“globalizzandosi” vieppiù, il mondo pare essersi ristretto: la prossimità tra i Leviatani ne accresce l’aggressività), si scontra con un limite tutto politico: lo Stato americano e i suoi manutengoli, possessori del più grande apparato militare al mondo e ancora insediati ai vertici delle “Banche centrali internazionali” (FMI, Banca mondiale), non sono d’accordo. Con le parole di Arrighi (nella postfazione del 2009 al suo libro più famoso), si tratta di una «biforcazione del potere militare e del potere economico» mai vista nella storia. La volontà di potenza dello Stato, insomma, arriva ormai non solo a deviare, ma addirittura a frenare il movimento “naturale” del capitale. La potenza diabolica sta quindi ristagnando come il gas in una stanza chiusa. Il rischio di deflagrazione è altissimo. Per dirla con le parole di uno dei loro accoliti, scomparso qualche anno fa dopo averne combinate di cotte e di crude (ultima sua fatica: il mezzo-golpe di Maidan in Ucraina nel 2014), le élite atlantiste, siano esse neocon o dem, «non accettano il declino del loro ordine mondiale». Al contrario, continuano ad accarezzare il vecchio sogno di un governo globale a guida USA: ciò che negli ultimi trent’anni hanno esercitato di fatto, punendo i vari feudatari felloni (Noriega, Saddam, Milosevic, Gheddafi, Assad…) a colpi di operazioni di polizia internazionali. Così, proprio come un governo, il complesso militare-industriale anglo-statunitense tenta di continuare a gestire le contraddizioni di cui è in buona parte il diretto e principale responsabile: «Fatte sue le acute analisi di Rosa Luxemburg – che vedeva inevitabile un crollo, o un’implosione, quando l’intero territorio mondiale fosse stato capitalistizzato e dunque senza più settori sociali o geografici in cui “incassare” il plusvalore estorto – [l’Apparato] non tende a una omogeneizzazione dei mercati, che comporterebbe un’irresistibile tendenza alla saturazione e, appunto, all’implosione […] né, infine, alla “capitalistizzazione” del mondo, nel senso di creare in ogni zona geografica un polo capitalista simile e dunque concorrente […]. All’opposto, tende all’assolutizzazione dei dislivelli creatisi, per consentire la loro regolamentazione attraverso l’Ordine ed il Governo mondiali, alla diminuzione progressiva della produzione in senso proprio, all’allargamento indefinito della riproduzione. La crescita esponenziale della microelettronica, della telematica, della cibernetica ecc. indica bene tale tendenza: queste nuove tecnologie vengono applicate alla produzione di beni materiali solo in misura ridotta (naturalmente rispetto alla loro quantità complessiva); la gran parte viene destinata ai beni immateriali, siano essi l’amministrazione, lo spettacolo, i servizi o la guerra stessa – tragico crocevia tra beni materiali e immateriali!» (Riccardo d’Este, La guerra come operazione di polizia internazionale. Si noti che questa lucidissima analisi è del 1991, quando il “Nuovo Ordine Mondiale” era appena agli albori!).
In breve, il capitalismo per come l’abbiamo conosciuto finora sembra declinare, raggiungendo i suoi limiti storici: ma le sue contraddizioni sembrano crescere di pari passo con un Apparato sovraequipaggiato e ultra-interventista, che si incarica di amministrarle imprimendo loro la forma soggettiva dello Stato. Soggettivizzandosi, il capitalismo pare trapassare in «un sistema leviatanico di predazione diretta» (Fabio Vighi, cit.) che irreggimenta e rapina senza più produrre alcuna ricchezza, ma finalizzando ogni risorsa (inorganica, vivente, umana) alla propria riproduzione attraverso il controllo e la guerra permanente.
Sarebbe da chiedersi cosa sarà del lavoro, in questo quadro. Non c’è dubbio che la fatica umana non scomparirà da questo mondo (le condizioni per un’automazione generalizzata al momento non ci sono, ma soprattutto l’Ordine non ha alcun interesse a crearle: perché dovrebbe rinunciare a una delle sue armi più potenti: il ricatto della fame?). Ma se il lavoro ha perso da tempo il suo carattere di motore nell’evoluzione complessiva del sistema, scippata dalle fonti di valorizzazione immateriali, si manterrà nella forma di lavoro salariato? E nell’attuale concentrazione tecnologica, economica e statale, quale sarà lo spazio per un autentico mercato? Il sistema leviatanico che avanza, infine, potrà ancora chiamarsi capitalismo? O prenderà forma qualcosa di diverso e ancora più orribile? Ancora una volta, la risposta è da cercare in relazione ai vari dislivelli del sistema-mondo incessantemente prodotti e riprodotti dall’amministrazione: ad esempio, mentre il salariato potrà servire a dare copertura giuridica al lavoro sempre più schiavile nei Paesi coloniali (particolarmente per l’estrattivismo necessario a costruire le macchine), alle nostre latitudini potrebbe essere sostituito da una sorta di “feudalesimo a programmazione statale”: io ti do il reddito di base per sopravvivere, e tu mi rendi il servizio sotto forma di corvée (non solo e necessariamente di tipo lavorativo). Senza perderci in troppi esercizi futurologici, per quanto basati su tendenze osservabili (il Reddito di Cittadinanza italiano viene già usato in questo senso, seppure in misura ancora minima; per non parlare della Cashless debit card australiana), torniamo al quadro complessivo.
Assorbendo la sostanza del capitale, la sua tendenza all’accrescimento geometrico, lo Stato ha cercato, in parte con successo, di inquadrarlo nella propria forma ad espansione aritmetica (la conquista militare e la regolamentazione governamentale). Questo tentativo, che ha conosciuto un discreto successo negli ultimi trent’anni (incominciando però ad impantanarsi in Afghanistan e in Iraq), tende di per sé a recuperare tutte le caratteristiche dello Stato Assoluto secentesco per estenderle all’intero globo: un’economia regolata dall’alto di tipo mercantilista; la completa ri-sudditizzazione del cittadino, chiamato ad assolvere obblighi di ogni tipo, lavorativi e soprattutto non-lavorativi (compreso accettare che lo sviluppo tecno-scientifico passi dal proprio corpo, nella forma di farmaci sperimentali). Nella sua forma imperiale, la missione morale dello Stato diventa difendere i propri cittadini globali dal caos e dalle contraddizioni che esso stesso ha creato, più che dalle minacce di altri Leviatani che si vorrebbe condannare alla semplice scomparsa. Così i suoi stakeholder si presentano sempre più spesso come filantropi che si auto-assegnano il compito di guidare l’umanità lontano dalla propria autodistruzione, con l’impiego di mezzi ultra-autoritari: dal loro punto di vista, il necessario cambiamento (Great Reset) non può che avanzare sui vecchi binari del profitto e del dominio: una salutare frenata d’emergenza rivoluzionaria non è neanche concepibile.
Cercando di mantenere la facciata della democrazia, il nuovo Stato Assoluto si afferma attraverso la produzione spettacolare di immagini di ogni tipo, e particolarmente di Emergenze, penetrando nell’intimo dell’individualità con l’induzione di paure, frustrazioni, desideri, rabbie, così da dissimulare il proprio dominio dietro il consenso apparente: «siamo la punta più avanzata di un colossale esperimento di cattura delle anime, che non passa più solo per l’imposizione violenta, come avveniva nel dominio classico, ma per l’adesione – rassegnata o entusiasta – a un regime pulsionale e concettuale molto soft, che si presenta come la quintessenza della libertà stessa. […] Qualcosa che, svuotando i soggetti delle loro forze, li assoggetta a un volere esterno e malevolo» (Stefania Consigliere, in Cose degli altri mondi). Questo regime pulsionale è tanto diffuso quanto centralizzato: ai suoi vertici stanno sempre di più i detentori della potenza tecnologica, la nuova casta (in quanto classe dominante sempre più integrata nello Stato) che accompagna il lento trapasso della società borghese verso un nuovo classismo complesso e stratificato: in cima alla piramide, i padroni del nuovo vapore elettronico; in mezzo i tecnici di ogni tipo (scienziati, politicanti, giornalisti), che ne ottengono privilegi in cambio dei servizi forniti; sotto, una pluralità di dislivelli incasellati nella divisione mondiale dell’oppressione e dello sfruttamento, tutti sempre più segnati, con modalità e in misure diverse, da proletarizzazione e asservimento.8 Questo regime pulsionale ci comanda in forme spesso inconsce, alternando seduzione (la fascinazione per le nuove diavolerie high tech, la promessa di svincolarci dai limiti naturali per mezzo della tecnologia) e costrizione morale (lo stigma contro chi “non rispetta le regole”, fregandosene degli “altri” e del Pianeta); non solo ci dice contro cosa non bisogna protestare (scendendo nelle piazze terrapiattiste e reazionarie dei “no vax”), ma addirittura quando invece si dovrebbe farlo (partecipando ai “buoni” e progressisti cortei verdi-fuxia). All’ideologia della nazione, miscuglio di chiacchiere sui diritti del cittadino, sul prestigio della “civiltà” e sull’ethos guerriero della potenza (quanto di più lontano dalle aspirazioni dei rammolliti occidentali), tenta di sostituire un’ideologia civico-cosmopolita-transumanista, impasto di “prima modernità” e post-modernismo: la subordinazione come conditio sine qua non di ogni diritto (compreso quello alla «nuda vita»): oltre questa soglia di assoluta obbedienza, l’accesso alle magnifiche sorti e progressive del corpo “aumentato”, e la fierezza di essere inclusi in quella parte di mondo che tiene la barbarie al di là del muro. Nel 2020, in un «tragico crocevia tra beni materiali e immateriali», questo regime pulsionale ci ha svuotati delle nostre forze come non mai, assoggettandoci al suo volere esterno e malevolo; a un punto tale che dobbiamo ancora riprenderci.
C’è senz’altro da riaversi in fretta, e la nostra estenuazione ci dice molto della potenza dell’Ordine. Tuttavia, non bisogna esagerarne la portata, fino a crederlo onnipotente. In realtà questo regime trova davanti a sé (e in sé) una molteplicità di ostacoli. Materiali, come la crisi dei microchip già determinata dalla corsa al gigantismo digitale (che lascio da parte perché qualcuno ne ha già trattato in modo avveduto). Economici, come il rialzo dei prezzi delle materie prime, e quindi dell’inflazione, determinato dalla stessa Operazione Covid: sia stato pure messo in conto (pur di frenare l’afflusso di merci cinesi), previsto o imprevisto, si tratta comunque di un fastidioso effetto collaterale che può determinare conseguenze ingovernabili. Ma gli ostacoli sono innanzitutto di natura umana e statale. Se la resistenza mondiale al lasciapassare verde è stata capace di farlo arretrare, l’Ordine mondiale trova al momento le maggiori resistenze negli altri Leviatani. Se togliere di mezzo i vari Saddam e Gheddafi è stato semplice, il gendarme anglo-americano e l’Occidente collettivo si sono rivelati del tutto incapaci di controllare i territori assoggettati, abbandonati al caos più completo o lasciati ai feudatari precedenti (come in Afghanistan). Adesso si trova ad affrontare vere e proprie potenze regionali e nucleari, poderose per peso demografico, capacità tecnologica ed influenza economica (come la Cina e l’India) o per dotazione militare e di risorse (come la Russia). Dopo molteplici sconfitte e brutte figure sul campo, la perdita di prestigio degli USA, unita all’esasperazione di sempre più popoli e governi di fronte all’arroganza e incapacità del gendarme striscestellato, potrebbe spingere sempre più Stati ad abbandonarne il carrozzone (la stessa Unione Europea, che dall’attuale conflitto in Ucraina non ha nulla da guadagnare, è sempre più tentata di mettere su un imperialismo in proprio, con la costruzione già avviata dell’Esercito europeo: tuttavia la cosa non si realizzerà da un giorno all’altro, e nel frattempo gli USA non resteranno certo a guardare…). Ad eventuali ritorsioni contro tentativi di fare i propri affari, molti Stati renitenti all’Ordine potrebbero rispondere: “volete metterci fuori dal mercato mondiale, come state facendo con la Russia e come presto tenterete con la Cina? Prego… in questo mercato che si fa sempre meno mondiale, ci resterete solo voi”. Se le defezioni statali si moltiplicassero, cosa potrebbe succedere? Lasciando da parte l’ipotesi nient’affatto peregrina di una guerra nucleare (con la quale semplicemente si chiuderebbero i giochi per l’umanità intera: se dobbiamo cercare di impedirla, non ha molto senso chiedersi cosa fare dopo), restano in campo due scenari: o l’Ordine mondiale si realizza, piegando le resistenze degli Stati rimasti in piedi e abbandonando al caos tutto il resto, oppure potrebbe frammentarsi in grandi potenze regionali (per sopravvivere, molti Stati minori si unirebbero ai maggiori). Se la prima ipotesi vedrebbe un assoggettamento praticamente irreversibile (la riproduzione sociale e persino biologica degli umani finirebbe per dipendere da un’unica mega-macchina, in un mondo senza fuori), la seconda potrebbe implicare la statalizzazione delle rivolte all’interno dei blocchi: un’umanità frammentata in Stati (e nelle loro alleanze) sarebbe probabilmente coinvolta in grandi guerre patriottiche contro il poliziotto del mondo (o specularmente, contro i tiranni dei popoli “barbari”). Futurologia da quattro soldi? Mica tanto… In Russia e in Ucraina sta già avvenendo… L’ideologia nazionale degli Stati risorge contro il cosmpolitismo autoritario del Super-Stato.
Inutile dire come, per resistere all’Impero, anche gli Stati più o meno “minori” sarebbero a loro volta costretti a dotarsi di tutti gli strumenti della potenza, compresi quelli iper-tecnologici, scaricando il peso dell’economia di guerra sul proprio proletariato. È questa, principalmente, la confutazione da opporre a ogni ipotesi sovranista, più che le chiacchiere sul suo carattere più o meno patriarcale, reazionario o razzista (che fanno solo il gioco del nuovo “buonismo” civilizzatore occidentale, passato dalla rozza maschera neocon a quella dem). Qua in Italia, questo conflitto tra “globalisti” e “sovranisti” non potrà che produrre ancora fenomeni particolarmente bizzarri ed estremi. In quanto fanalino di coda dell’Occidente, nonché cerniera geografica tra Europa occidentale e orientale, nonché avamposto sul Mediterraneo, nonché laboratorio sociale e politico della NATO fin dal secondo dopoguerra, il nostro Paese è “il primo tra gli ultimi e l’ultimo tra i primi”, esposto in prima fila al doppio fuoco degli attacchi cibernetici contro l’essere umano e degli attacchi politico-economici contro la sua industria e la sua autonomia imperialista (con forti e persistenti dolori di pancia della sua borghesia nazionale). È proprio il caso di dire: ne vedremo delle brutte…
In ogni caso, qualsiasi cosa succederà, la questione dello Stato sarà centrale, forse… più che sempre. Per questo è importante ricordarci perché lo odiamo, perché vogliamo abbatterlo e oltrepassarlo, e in quale direzione. Lo Stato, dicevamo all’inizio, è una delle forme che può assumere il dominio, non la sola. Tuttavia, a ben vedere, esso segna la storia dell’umanità da tempi remoti e fino ai giorni nostri, e minaccia di segnarla ancora, assumendo proporzioni mostruose (per estensione geografica e per capacità di controllo e penetrazione). Se anche la storia del capitalismo fosse alla fine, lo Stato sembra promettere ancora un avvenire per niente radioso allo sfruttamento e all’oppressione dell’uomo sull’uomo. Non potrebbe essere diversamente. Fondato nella guerra e per la guerra, continua a produrre la guerra. Fondato sull’assoggettamento, lo rinnova e lo intensifica nel suo attuale salto di specie tecnologico e nel suo tentativo di salto di scala planetario. Mentre promette la pace, prepara la guerra. Mentre sviluppa la potenza umana se ne appropria, e ne lascia i frutti ai suoi manutengoli privilegiati. Mentre impone l’unità, isola e divide, impedendo la relazione, la coalizione e la cooperazione reale. Il suo dominio è sempre più centralizzato e allo stesso tempo più diffuso. Così, se per abbattere lo Stato e la società che inevitabilmente produce si dovranno ancora assaltare le regge di Versalilles e i Palazzi d’Inverno, per oltrepassarlo sarà necessario, negli sconvolgimenti che verranno, anche liberare dalla sua presenza quei territori dove dare spazio a un’altra forma della potenza umana, e dove sbarazzarsi di tutto quanto ci aliena e ci diminuisce; mettendo in comune – ciascuno e ciascuna con chi vorrà farlo – il primo e più originario dei commons: la facoltà di decidere, finalmente in autonomia, per se stessi. Ma di questo, un’altra volta.
Un amico di Winston Smith
Nella stesura di questo testo, oltre ai libri e articoli già citati, sono stati variamente utilizzati anche i seguenti volumi:
S. Federici, Calibano e la strega
P. Linebaugh, M. Rediker, I ribelli dell’Atlantico
E. Krippendorf, Lo Stato e la guerra
1 Salvo che, quando lo Stato viene meno allo scopo per cui nasce, ovvero assicurare la protezione, esso tende a decadere e scomparire: è il caso della sconfitta in guerra o del terrore assolutamente indiscriminato contro la popolazione; ma se la dissoluzione dello Stato può avvenire in conseguenza dello scopo mancato, non può mai essere pretesa dai suoi cittadini, pena la caduta nella guerra civile.
2Interessante, a questo proposito, Machiavelli, che commentando Tito Livio traccia un paragone tra le popolazioni liberamente federate della più remota antichità e gli Svizzeri del suo tempo: «Il modo preallegato delle leghe, come viverono i Toscani, gli Achei e gli Etòli, e come oggi vivono i Svizzeri, è dopo quello de’ Romani il migliore modo; perché non si potendo con quello ampliare assai, ne seguita due beni: l’uno che facilmente non ti tiri la guerra a dosso; l’altro, che quel tanto che tu pigli lo tieni facilmente. La ragione del non potere ampliare è lo essere una repubblica disgiunta e posta in varie sedie, il che fa che difficilmente possono consultare e deliberare. […] Governonsi, oltra di questo, per concilio, e conviene che sieno più tardi a ogni dilibirazione. Vedesi ancora per spirienza che il simile modo di procedere ha un termine fisso, il quale non ci è esemplo che ci mostri che si sia trapassato: e questo è di aggiugnere a dodici o quattordici comunità, dipoi non cercare di andare più avanti; perché sendo giunti a grado che pare loro potersi difendere da ciascuno, non cercono maggiore dominio, sì perché la necessità non gli stringe di avere più potenza, sì per non conoscere utile negli acquisti, per le cagioni dette di sopra. […] Pertanto […quando giungono a un numero sufficiente] si voltono a due cose: l’una a ricevere raccomandati e pigliare protezioni, e per questi mezzi trarre da ogni parte denari […]; l’altra è militare per altrui, e pigliare soldo da questo e da quel principe che per sua imprese gli solda, come si vede che fanno oggi i Svizzeri, e come si legge che facevano i preallegati». (Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, libro II, IV, 23-29).
3 Senza limitarsi alle risorse materiali, il generale movimento di espropriazione dell’età moderna riguardò anche i saperi, in particolare quelli legati alla cura e al parto. Non si sa spiegare altrimenti quella grande ondata di follia collettiva nota come caccia alle streghe, con un massacro di donne (e in misura molto minore anche di uomini) che attraversò tutta la prima età moderna, raggiungendo il suo culmine tra la seconda metà del Cinquecento e la seconda metà del Seicento, e arrivando anche oltre (li ultime esecuzioni di streghe si hanno in Europa nella prima metà del Settecento, e in altri continenti arrivano alla seconda metà dell’Ottocento, come nella famosa vicenda di Salem del 1878). Se la responsabilità dello Stato è certa (in tutti Paesi, cattolici e protestanti, la gran parte dei processi fu tenuta dall’autorità civile e non da quella ecclesiastica), la posta in gioco è ampiamente intuibile sia dalle immagini evocate nei processi (la strega che somministra pozioni velenose, ha rapporti contronatura con il demonio, rapisce e sacrifica bambini ecc.) sia dal contesto, in cui lo Stato fonda e finanzia accademie scientifiche, si incamera le facoltà di medicina e la normazione della sessualità, mentre laici e spregiudicati teorici della “ragion di Stato” (da Jean Bodin al solito Hobbes) approvano la caccia alle streghe come forma di disciplinamento sociale. Se il clima di paura e sospetto generalizzato favoriva le trame statali e padronali, stornando il malcontento di una società sempre più impoverita e oppressa da carestie, guerre ed epidemie, accompagnava anche la nascita di uno specialista che negli ultimi due anni ci ha fatto sentire tutto il suo peso: il medico laureato.
4 Cit. in L’invenzione del capitalismo, https://finimondo.org/node/2309 basato sull’omonimo The invention of capitalism di Micheal Perelman.
5 Si pensi alla cultura nazional-popolare tedesca dell’Ottocento e del primo Novecento, che finirà per sfociare nel nazismo.
6 Detto di passata, bisognerebbe fare una riflessione in proposito: è probabilmente vero che la forma-Stato, di cui il capitalismo è una filiazione, nasce nel patriarcato; ma nella forma moderna tende a divenire più impersonale, spogliandosi sempre più dei suoi abiti maschili.
7 Su questo si vedano gli articoli di Fabio Vighi, a partire da Paradigma Covid: https://sinistrainrete.info/crisi-mondiale/20663-fabio-vighi-paradigma-covid-collasso-sistemico-e-fantasma-pandemico.html
8 Sarebbe opportuno rileggere sotto questa luce l’analisi di Alfredo Bonanno sulla nuova divisione di classe tra esclusi e inclusi: tra chi amministra e chi semplicemente subisce la tecnologia.