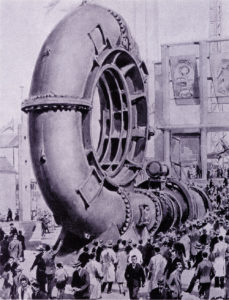L’avvenire in blocco
Il «fanale» precedente si chiudeva con la domanda (a proposito di interruzione del flusso storico del dominio): quali potrebbero esserne oggi la figura aurorale e il «dispositivo d’innesco»? Uno di quei quesiti che dànno le vertigini. Soprattutto perché attorno alla questione decisiva delle immagini viventi in grado di alludere a un mondo altro si è creato da tempo il vuoto.
Essa è invece al centro di una delle opere più inclassificabili, più potenti e più fraintese del pensiero rivoluzionario: le Riflessioni sulla violenza di Georges Sorel, pubblicate sotto forma di articoli nel 1905 e poi in volume nel 1906. Dove e quando – si chiede Sorel – si esprime in blocco l’«immagine motrice» della rivoluzione socialista? Come noto, egli risponde: durante lo sciopero generale proletario. Il perché sta in poche righe: «Lo sciopero generale è […] il mito nel quale è contenuto il socialismo nella sua interezza, ovvero una organizzazione di immagini capaci di evocare istintivamente tutti i sentimenti corrispondenti alle varie manifestazioni della guerra ingaggiata dal socialismo contro la società moderna. […] facendo appello a ricordi veementi di conflitti particolari, esso colora di una vita intensa tutti i dettagli della composizione offerti alla coscienza. Otteniamo così quella intuizione del socialismo che il linguaggio non poteva dare in maniera perfettamente chiara – e la otteniamo in un insieme percepito istantaneamente». Sorel non si limita a registrare un fatto, bensì trascina la filosofia del placido Bergson sulle barricate. Le pagine dedicate propriamente allo sciopero generale sono assai striminzite. Il grosso del suo lavoro consiste nel precisare cosa non è il socialismo: conquista progressiva di diritti politici e sociali; rappresentazione parlamentare; infinita schermaglia sindacale. Contro ogni illusione socialdemocratica e progressista, per Sorel l’ingresso del socialismo nella storia deve assumere la forma di una rottura (improvvisa e travolgente), di una secessione (il proletariato diventa potenza autonoma solo rescindendo ogni patto con il capitale), di un mito («il mito non precede lo sciopero, è lo sciopero stesso»). Non aveva certo torto Errico Malatesta a chiedersi, nello stesso periodo, se l’idea dello sciopero generale avesse fatto più male che bene al proletariato, spingendolo per lo più a sopravvalutare l’impatto dell’astensione dal lavoro, ad aspettare il dì dello scontro fatale e a trascurare la preparazione insurrezionale. Molto prima che fosse la ristrutturazione capitalistica a smussare l’arma dello sciopero generale, il «mito» si infrangerà nel 1914, allorché sarà la società moderna a ingaggiare la guerra contro il socialismo, mandando all’aria tutte le risoluzioni disfattiste dei suoi Congressi internazionali.
Ora, lo sciopero generale è tutt’altro che scomparso – basta pensare a cosa sta succedendo in Gran Bretagna in queste settimane –, ma da diversi decenni non è più l’elemento scatenante di rivolte generalizzate. In Cile come in Libano, in Ecuador come in Iran, nelle Antille come in India, la paralisi dell’economia si produce, quando si produce, come estensione di sommosse immediatamente sociali, e non come loro atto sorgivo. Non a caso le forme organizzative delle sollevazioni di massa sono assai spesso più comunitarie e territoriali che non espressioni dell’ambito lavorativo.
Si avrebbe torto a lasciar ingiallire le Riflessioni soreliane. Ciò che ne va attentamente attualizzato è innanzitutto il movente. Attraverso quali esempi concreti, attraverso quali immagini viventi l’intuizione può afferrare in blocco, oltrepassando la logica dell’a poco a poco, la sospensione del tempo storico e con essa un nuovo inizio possibile? Negli stessi anni in cui Sorel maturava le sue riflessioni, l’anarchico ebreo-tedesco Gustav Landauer parlava dell’utopia come di «una mescolanza di aspirazioni individuali e di tendenze della volontà, che sono sempre singole ed eterogenee, che in un momento di crisi nella forma dell’esaltazione ispirata si uniscono e si organizzano in una totalità e in una forma di convivenza». Ecco: dove e quando abbiamo visto, nelle lotte degli ultimi decenni in questo Paese, una «crisi nella forma dell’esaltazione ispirata» capace di attrarre donne e uomini in una «totalità» che fosse anche, sia pure per poco, «una forma di convivenza»?
Personalmente, risponderei senz’altro: durante i presìdi-blocchi contro il TAV e la polizia in Valsusa. Lì ho visto la rottura non effimera, l’intensità dei sentimenti e la riattivazione di un passato ribelle convergere nel tempo e nello spazio. Come tutte le forme inedite di organizzazione, quei blocchi-presìdi-spazi di convivenza non sono stati né spontanei né casuali. Il 27 febbraio 2012, mentre un compagno era appena stato trasportato in elicottero verso l’ospedale dove sarebbe rimasto a lungo in coma farmacologico, c’era chi proponeva un grande presidio davanti alla Prefettura di Torino. Li sì avremmo visto la «convergenza delle lotte» con le mille e una bandiera di rappresentanza giunte da ogni dove. Ci si è invece dati appuntamento in un luogo quasi invisibile sulla cartina geografica – Vernetto, frazione di Chianocco – per bloccare contemporaneamente l’autostrada e le due statali, cioè per «bloccare la Valle». Ci siamo rimasti tre giorni e due notti, scacciati dai manganelli, dagli idranti e dai lacrimogeni, non prima di aver lanciato un appello – generosamente raccolto in trentatré città – a «bloccare tutto». Potremmo dire, con il già citato Sorel, che il «mito non ha preceduto il blocco, era il blocco stesso» – cioè un’interruzione della normalità capitalistica che desse il tempo a chi voleva di raggiungerla o di riverberarne altrove l’impatto; e che trasformasse una nocività particolare – il TAV – nell’equivalente generale di tutte le nocività.
Perché non si è dato qualcosa di simile – uno spartiacque emotivo e sociale, un’interruzione materiale e spirituale della normalità capitalistica – di fronte all’assassinio di Abd Elsalam, travolto da un tir durante un picchetto operaio a Piacenza? Perché non si è alzato il grido «blocchiamo tutto!», ovunque? Consegnando le risposte al vento, possiamo constatare che l’azione collettiva più forte e più evocativa contro il «green pass» è stato il blocco-presidio al porto di Trieste.
Mentre l’attuale organizzazione sociale ci sta presentando in blocco tutte le sciagure che ha accumulato nella storia, queste intuizioni vagano ancora in cerca di mani, di menti e di cuori.