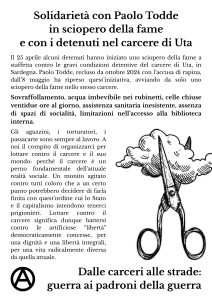Luci da dietro la scena (XVIII) – Toni Negri, ovvero longevità – e fine – di un’impostura
Luci da dietro la scena (XVIII) – Toni Negri, ovvero longevità – e fine – di un’impostura
In attesa di qualcosa di più articolato, riprendiamo queste note uscite all’epoca della pubblicazione di Impero.
[…] Non incorreremo nell’errore banale di credere che siano certe teorie a influenzare unilateralmente i movimenti. Le teorie si diffondono in quanto servono determinati interessi e rispondono a determinate esigenze. Impero di Negri e Hardt è, in tal senso, un libro esemplare. Assieme alle elaborazioni dei cugini “diplomatici” francesi [riferimento a “Le monde diplomatique”], le sue pagine offrono la versione più intelligente del programma di sinistra del capitale. I gruppi che ad esse si richiamano sono la versione globalizzata della vecchia socialdemocrazia e la variante gassosa – che alla rigida gerarchia dei funzionari ha sostituito il modello della rete (o del rizoma) in cui il potere dei leader appare più fluido – della burocrazia stalinista. Insomma, il partito comunista del terzo millennio, la pacificazione del presente, la controrivoluzione del futuro. Costruita sul declino del movimento operaio e delle sue forme di rappresentanza, questa nuova maniera di far politica non ha più campi privilegiati di intervento (come la fabbrica o il quartiere) e offre alle ambizioni degli aspiranti dirigenti un terreno più immediato di quello delle vecchie segreterie di partito: il rapporto coi mass media. Per questo partiti e sindacati di sinistra si pongono come suoi alleati e vanno sovente a rimorchio delle sue iniziative, ben sapendo che, al di là dei piercing di qualche piccolo leader e di certi slogan da retorica guerrigliera, la politica disobbediente rappresenta la base (anche elettorale) del potere democratico a venire. Dello stalinismo essa mantiene intatto il ruolo, ma il suo futuro si inscrive soprattutto nella sua capacità di porsi come forza di mediazione fra le tensioni sovversive e le esigenze dell’ordine sociale, portando i movimenti nell’alveo istituzionale e attuando un’opera di denuncia degli elementi che sfuggono al suo controllo.
D’altra parte lo Stato, dopo aver progressivamente assorbito il sociale, si è reso conto di soffocare ogni creatività sotto il fardello istituzionale; costretto a riespellerlo, ha chiamato questo scarto società civile, abbellendolo con tutte le ideologie della classe media: umanitarismo, volontariato, ambientalismo, pacifismo, antirazzismo democratico. Il consenso, nella dilagante passività, ha bisogno di continue iniezioni di politica. A questo servono i politici disobbedienti con i loro cittadini. Per gli orfani della classe operaia, infatti, è la figura astratta del cittadino ad avere oggi tutte le virtù. Giocando abilmente sui significati della parola (il cittadino è allo stesso tempo il suddito di uno Stato, il borghese, il citoyen della rivoluzione francese, il soggetto della polis, il sostenitore della democrazia diretta), questi democratici si rivolgono a tutte le classi. I cittadini della società civile si oppongono alla passività dei consumatori quanto alla rivolta aperta degli sfruttati contro l’ordine costituito.
Sono l’anima buona delle istituzioni statali (o pubbliche, come preferiscono dire), quelli che in una Genova qualsiasi inviteranno sempre, per dovere civico, la polizia a «isolare i violenti».
Con la complicità delle mobilitazioni democratiche dei “disobbedienti”, lo Stato può dare così maggiore forza e credibilità al suo ultimatum: o si dialoga con le istituzioni oppure si è “terroristi” da perseguire (si leggano, in tal senso, i vari accordi internazionali firmati dopo l’11 settembre). Il «movimento dei movimenti» è un potere costituente, cioè un’eccedenza sociale rispetto al potere costituito, una forza politica istituente che si scontra e interloquisce con la politica istituita – nell’idea di Negri, la versione militante del concetto spinoziano di potenza.
La strategia è quella della progressiva conquista di spazi istituzionali, di un consenso politico e sindacale sempre più allargato, di una legittimità ottenuta offrendo al potere la propria forza di mediazione e la propria cauzione morale.
Nel racconto negriano, il vero soggetto della storia è uno strano essere dalle mille metamorfosi (prima operaio-massa, poi operaio sociale, ora moltitudine) e dalle mille astuzie. È lui, infatti, ad avere il potere anche quando tutto parrebbe testimoniare il contrario. Tutto ciò che il dominio impone è lui, in realtà, ad averlo voluto e conquistato. L’apparato tecnologico incorpora il suo sapere collettivo (non la sua alienazione). Il potere politico asseconda le sue spinte dal basso (non il suo recupero). Il Diritto formalizza il suo rapporto di forza con le istituzioni (non la sua integrazione repressiva). In questa visione edificante della storia, tutto avviene secondo gli schemi del marxismo più ortodosso. Lo sviluppo delle forze produttive – autentico fattore di progresso – entra continuamente in contraddizione con i rapporti sociali, modificando l’assetto della società nel senso dell’emancipazione. L’impianto è lo stesso della socialdemocrazia tedesca classica, cui si deve l’irrefutabile privilegio di aver stroncato nel sangue un assalto rivoluzionario e poi gettato i proletari nelle mani del nazismo.
E socialdemocratica è l’illusione di opporre al potere delle multinazionali quello delle istituzioni politiche, illusione che Negri condivide con gli statalisti di sinistra de Le monde diplomatique. Se entrambi denunciano tanto spesso il «capitalismo selvaggio», i «paradisi fiscali», la «dittatura dei mercati», è perché vogliono nuove regole politiche, un nuovo governo della globalizzazione, un altro New Deal. In questo senso va letta la proposta di un reddito universale di cittadinanza, che i negriani meno “dialettici” non hanno scrupoli a presentare apertamente come un rilancio del capitalismo.
Nonostante due decenni di duri conflitti sociali, il capitalismo è riuscito ad aggirare la minaccia rivoluzionaria, attraverso un processo giunto a compimento alla fine degli anni Settanta, con lo smantellamento dei centri produttivi e la loro diffusione sul territorio, e col completo assoggettamento della scienza al dominio. A questa conquista di ogni spazio sociale corrisponde, quale ulteriore frontiera da varcare, l’entrata del capitale nel corpo umano attraverso il dominio degli stessi processi vitali della specie: le necrotecnologie sono l’ultimo esempio del suo vagheggiamento di un mondo interamente artificiale. Ma per Negri tutto ciò è espressione della creatività della moltitudine. La subordinazione totale della scienza al capitale, l’investimento nei servizi, nel sapere e nella comunicazione (la nascita delle «risorse umane», secondo il linguaggio manageriale), per lui esprime il «divenir-donna» del lavoro, cioè la forza produttiva dei corpi e della sensibilità. Nell’epoca del «lavoro immateriale» i mezzi di produzione di cui la moltitudine deve assicurarsi la proprietà comune sono i cervelli. La tecnologia, in tal senso, democratizza sempre più la società, poiché il sapere che il capitalismo mette a profitto oltrepassa ogni ambito salariale, coincidendo di fatto con l’esistenza stessa degli esseri umani.
Ecco cosa significa, allora, la rivendicazione di un reddito minimo garantito: se il capitale ci fa produrre in ogni istante, che ci paghi anche se non siamo impiegati come salariati e gli renderemo il denaro consumando.
Le conclusioni di Negri e soci sono il perfetto rovesciamento delle idee di chi, già negli anni Settanta, sosteneva che la rivoluzione passa attraverso il corpo, che la condizione proletaria è sempre più universale e che la vita quotidiana è il luogo autentico della guerra sociale. Il fine dei recuperatori è sempre lo stesso. Negli anni Settanta, per conquistarsi un posto al sole parlavano di sabotaggio e di guerra di classe; oggi propongono la costituzione di liste civiche, l’accordo con i partiti, l’entrata nelle istituzioni. Il loro gergo e le loro acrobazie linguistiche mostrano che la dialettica marxista è capace di ogni prodezza; passando da Che Guevara a Massimo Cacciari, dai contadini del Chiapas alla piccola impresa veneta, oggi giustifica la delazione come ieri teorizzava la dissociazione. D’altronde, come essi stessi riconoscono, l’importante non sono le idee né i metodi, bensì «le parole d’ordine perentorie».
Per i teorici “disobbedienti” le istituzioni politiche sono ostaggio del capitale multinazionale, semplici camere di registrazione di processi economici globali. In realtà, dal nucleare alla cibernetica, dallo studio dei nuovi materiali all’ingegneria genetica, dall’elettronica alle telecomunicazioni, lo sviluppo della potenza tecnica – base materiale di quella che viene definita globalizzazione – è legato alla fusione dell’apparato industriale e scientifico con quello militare. Senza il settore aerospaziale, senza l’Alta velocità ferroviaria, senza i collegamenti attraverso i cavi a fibre ottiche, senza i porti e gli aeroporti, come potrebbe esistere un mercato globale? Aggiungiamo il ruolo fondamentale delle operazioni di guerra, lo scambio continuo di dati fra il sistema bancario, assicurativo, medico e poliziesco, la gestione statale delle nocività ambientali, la sorveglianza sempre più capillare, e si coglierà come sia mistificatorio parlare di declino dello Stato. Quella che sta cambiando è semplicemente una certa forma statale.
A differenza di altri socialdemocratici, per Negri non è più possibile la difesa dello Stato “sociale” nazionale, in quanto costituzione politica ormai superata. Si apre però una prospettiva ancora più ambiziosa: la democrazia europea. Da un lato il potere si pone infatti il problema di come pacificare le tensioni sociali, stante la crisi della politica rappresentativa. Dall’altro i “disobbedienti” cercano nuove strade per rendere più democratiche le istituzioni, rendendo più istituzionali i movimenti. Ecco il possibile incontro: «Chi ha dunque interesse all’Europa politica unita? Chi è il soggetto europeo? Sono quelle popolazioni e quegli strati sociali che vogliono costruire una democrazia assoluta a livello di Impero. Che si propongono come contro-Impero. […] Il nuovo soggetto europeo non rifiuta dunque la globalizzazione, anzi, costruisce l’Europa politica come luogo dal quale parlare contro la globalizzazione, nella globalizzazione, qualificandosi (a partire dallo spazio europeo) come contropotere rispetto all’egemonia capitalistica dell’Impero» (da Europa politica. Ragioni di una necessità, a cura di H. Friese, A. Negri, P. Wagner, 2002).
Siamo giunti alla fine. Sotto una fitta cortina fumogena di slogan e di frasi ad effetto, sotto un gergo che ammicca e terrorizza, ecco ora definito un programma semplice per il capitale e grandioso per la moltitudine. Cerchiamo di riassumerlo.
Grazie ad un reddito garantito, i poveri possono essere flessibili nella produzione di ricchezza e nella riproduzione della vita, e rilanciare così l’economia; grazie alla proprietà comune dei nuovi mezzi di produzione (i cervelli), il «proletariato immateriale» può «cominciare attraverso l’Europa una lunga marcia zapatista della forza-lavoro intellettuale»; grazie a nuovi diritti universali di cittadinanza, il dominio può attraversare la crisi dello Stato-nazione e includere socialmente gli sfruttati. I padroni non lo sanno ma, lasciati finalmente liberi di svilupparsi, i nuovi mezzi di produzione realizzeranno di fatto ciò che contengono già in potenza: il comunismo. Occorre solo fare i conti coi capitalisti ottusi, reazionari, neoliberisti (insomma, con la “cattiva” globalizzazione). Tutto ciò sembra essere concepito apposta per confermare quello che Walter Benjamin constatava oltre sessant’anni fa, qualche settimana dopo il patto di non aggressione fra Stalin e Hitler: «Non c’è nulla che abbia corrotto i lavoratori tedeschi quanto la persuasione di nuotare con la corrente. Per loro lo sviluppo tecnico era il favore della corrente con cui pensavano di nuotare».
Ma le acque agitate della corrente nascondono insidie pericolose, come avverte lo stesso Negri: «adesso ci troviamo in una costituzione imperiale nella quale monarchia ed aristocrazia lottano tra loro, ma i comizi della plebe sono assenti. Ciò determina una situazione di squilibrio, dal momento che la forma imperiale può esistere in maniera pacificata solo quando questi tre elementi si equilibrano tra loro» (da “MicroMega”, maggio 2001). Insomma, cari senatori, Roma è in pericolo. Senza “dialettica” fra movimenti sociali e istituzioni, i governi sono “illegittimi”, quindi insicuri. Come hanno dimostrato mirabilmente prima Tito Livio e poi Machiavelli, l’istituzione del tribunato della plebe serviva a controbilanciare la continua espansione imperiale romana con l’illusione della partecipazione popolare alla politica. Ma il celebre apologo di Menenio Agrippa – che apostrofava la plebe ammutinata dicendole che solo grazie ad essa Roma viveva, come un corpo vive solo grazie alle sue membra – rischia in effetti di concludersi. L’Impero sembra aver sempre meno bisogno dei poveri che produce, lasciati a marcire a milioni nelle riserve del paradiso mercantile. D’altra parte, la plebe potrebbe farsi minacciosa, come un’orda di barbari – e scendere sì dal colle verso la città, ma con le peggiori intenzioni. Per gli sfruttati irrequieti e irragionevoli la mediazione dei nuovi dirigenti potrebbe essere odiosa quanto il potere in carica e inefficace quanto una lezione di civismo fatta a chi ha già i piedi sul tavolo. La polizia, anche in tuta bianca, potrebbe non bastare.
(dall’introduzione a Crisso, Odoteo, Barbari. L’insorgenza disordinata, NN, Pont St Martin (AO), 2002)