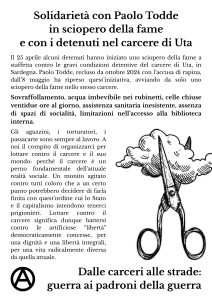Luci da dietro la scena (XVII) – Una duplice disumanizzazione, o sulle conseguenze del “sistema-Israele”
Qui il pdf: Una duplice disumanizzazione
Luci da dietro la scena (XVII) – Una duplice disumanizzazione
[…]
Nell’ambito della colonizzazione israeliana, i palestinesi, non più riconosciuti come comunità, sono ridotti a un problema ambientale: un ambiente che viene dislocato o ripulito secondo le esigenze dell’esercito di occupazione o della colonizzazione galoppante. Con la seconda Intifada, e con il mito della guerra di sopravvivenza, questa tendenza si è fortemente aggravata.
A partire dai primi mesi del 2001, l’intera popolazione palestinese è rinchiusa in zone e microzone, senza poter comunicare normalmente da una zona all’altra. Il blocco instaurato all’inizio del «processo di pace» si è trasformato nell’accerchiamento di un centinaio di città o di villaggi. A parte i taxi collettivi che fanno la spola fra le diverse zone e le ambulanze quando non vengono fermate ai posti di blocco, da due anni non si vedono quasi più automobili palestinesi nelle strade della Cisgiordania. I prodotti agricoli possono uscire dai villaggi, e i prodotti industriali entrarvi, solo raramente. La vita economica è interamente smantellata, come lo sono la vita familiare e, in generale, i normali rapporti umani. Per gli scolari dei villaggi, andare a scuola è un’avventura quotidiana. Per gli ammalati, l’ospedale è una meta che si può raggiungere solo dopo aver accuratamente preparato un itinerario che aggiri gli sbarramenti e preveda fino a cinque taxi collettivi e parecchi chilometri a piedi attraverso i campi, con una probabilità su due di arrivare a destinazione. Quanto a lasciare il paese, solo pochi privilegiati hanno il diritto di farlo.
Una popolazione di circa quattro milioni di persone è letteralmente imprigionata per garantire la sicurezza degli israeliani, e soprattutto per costringerla a capitolare e ad accettare le «generose offerte» di Barak o di Sharon. […] Per le autorità militari non esistono, infatti, ammalati, studenti, nonne morenti, ma un popolo di terroristi che bisogna domare o scacciare. […] Per l’esercito israeliano non vi sono feriti ma terroristi, non vi sono medici ma terroristi travestiti, non vi sono ambulanze ma automezzi camuffati da ambulanze che trasportano terroristi ed esplosivi.
[…] dal momento in cui, in nome della sicurezza, ci si attribuisce il diritto di negare la dimensione umana dell’avversario, il processo di disumanizzazione non può più fermarsi.
I membri della nona missione civile francese in Palestina (febbraio 2002) hanno avuto occasione di farne esperienza diretta quando, a un posto di blocco nella striscia di Gaza, hanno udito una voce proveniente da un altoparlante issato in cima a una torretta che gridava in ebraico: «Gli uomini a destra, le donne a sinistra, in riga per cinque, in ginocchio!» E solo dopo essersi inginocchiati, potevano passare. Costringere uomini e donne a inginocchiarsi, a correre nudi, a strisciare nel fango, marchiati sul braccio: sono altrettanti esempi di umiliazioni gratuite di cui parlano abbondantemente i media che non hanno come pretesto la sicurezza.
[…] La sistematica disumanizzazione del colonizzato comporta inevitabilmente la disumanizzazione del colono e della sua società. Il soldato israeliano, il colono che gode di una totale impunità, ma anche la brutalità del discorso politico dominante, hanno ormai contaminato la società israeliana: la violenza, come l’inquinamento, non si ferma alla Linea verde. Lo dimostrano le statistiche sulla criminalità in Israele, soprattutto quelle sulla violenza domestica: in due anni, le aggressioni e gli omicidi sono aumentati del più del 20 per cento, e non passa giorno senza che la stampa segnali il verificarsi di gravi incidenti, soprattutto fra i giovani. Questi ultimi hanno due modelli con i quali identificarsi: i soldati, la cui brutalità viene presentata dai media come eroismo, e i coloni, che Ehud Barak definiva i nuovi pionieri di Israele.
Nel corso dell’ultimo decennio, il colono è diventato un superuomo che non deve tener conto di alcuna legge, di alcuna istituzione. Ruba le terre ai suoi vicini arabi, raccoglie le loro olive, apre strade e ne chiude altre, vieta ai contadini arabi l’accesso alle loro terre e, quando si infuria, organizza spedizioni punitive. Ha diritto di vita o di morte sugli indigeni, e impone la sua legge anche ai militari che lo proteggono e senza i quali egli non è altro che un miserabile ladro.
Quanto ai soldati, la cui età media è ventun’anni, essi sono – collettivamente e individualmente – il potere. Un potere assoluto su circa quattro milioni di esseri umani. Da quasi due anni ormai, nuove disposizioni conferiscono al soldato le prerogative di ufficiale di polizia, di giudice, di esecutore di sanzioni penali e, se ne ha voglia, di educatore. Sono tutti ruoli che è possibile vedere esercitati da questi soldati appena usciti dall’adolescenza, nelle decine di posti di blocco che regolano la vita degli abitanti della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. […] Ai posti di blocco i soldati non parlano né l’arabo, né l’inglese, e neppure l’ebraico: urlano delle onomatopee gesticolando con i loro M16.
Nel dicembre 2001, con un gruppo di internazionalisti, accompagnavo al posto di blocco che separa Gerusalemme da Ramallah il corrdinatore delle ONG palestinesi, Mustafa Barghuti, dopo che la polizia lo aveva liberato da una detenzione di alcune ore per aver osato organizzare una conferenza stampa a Gerusalemme. A una ventina di metri dallo sbarramento, una pattuglia della polizia di frontiera si dirige, con aria minacciosa, verso di noi, e il suo capo ci grida qualcosa.
– Cosa vogliono?
– Non lo so, non parlano ebraico, credo sia russo.
– Sicuramente non russo. Ho studiato in Unione Sovietica, e conosco il russo.
Ci troviamo adesso faccia a faccia con i poliziotti. Urlano, ma continuo a non capire nulla. Esigo che smettano di gridare, che parlino, e in ebraico. E improvvisamente mi rendo conto che vociferano proprio in ebraico: o meglio, era una specie di ebraico-militare, qualcosa che stava tra la frase articolata e le grida che il cow-boy lancia alle vacche della sua mandria.
A forza di urlare addosso agli indigeni, i soldati israeliani perdono progressivamente l’uso della parola. Quando tornano alla vita civile, in Israele, hanno sempre pù difficoltà a ritrovarlo. È facile immaginare che dialogo possano avere con i loro genitori, con le loro compagne e, più tardi, con i loro figli.
Come non vedere?
[…] l’israeliano sente inconsciamente che l’equazione «paletinesi=nazisti» è falsa: tale è la potenza militare di Israele, la sua schiacciante superiorità nei confronti dei palestinesi, che diventa piuttosto difficile, per l’israeliano, identificarsi con i miseri ebrei di Varsavia e di Vilna, e più ancora con i combattenti del ghetto di Varsavia o con i gruppi di partigiani in Bielorussia. Si verifica allora un orribile, perverso, rovesciamento di posizioni. Il continuo riferimento al genocidio degli ebrei d’Europa, e l’onnipresenza delle sue terribili immagini, fanno sì che, se la realtà dei rapporti di forza rende impossibile adottare il comportamento delle vittime ebraiche, si adottano allora – di solito inconsciamente – i comportamenti dei massacratori del popolo ebraico: i palestinesi vengono marchiati sul braccio, costretti a correre nudi, ammassati dietro fili spinati e torrette di guardia; per un breve periodo, sono stati usati persino cani pastori tedeschi. Le retate nel campo di Deheisheh non possono non richiamare un altro periodo storico, anche se, chiaramente, la sorte dei rastrellati non sarà la morte, ma una detenzione senza limiti di tempo in condizioni spaventose. Il campo di detenzione di Offer non è un campo di sterminio, ma assomiglia molto ai campi di concentramento tedeschi degli anni trenta, con i fili spinati, le torrette, le masse di detenuti spaventati, privi di ogni diritto e tenuti in condizioni veramente disumane. Come non vedere che una fila di civili che sfilano con le mani in alto sotto la guardia di soldati armati mima l’immagine ossessiva degli ebrei di Varsavia in marcia verso la Umschlagplatz? Come non ricordarsi di questa stessa Umschlagplatz quando la televisione ci mostra, a Jenin, centinaia di uomini seduti per terra con le mani legate dietro la schiena, talvolta con gli occhi bendati?
[…]
Ho scritto «di solito inconsciamente» perché talvolta questo perverso rovesciamento di posizioni è del tutto consapevole, come nel caso di quell’ufficiale superiore dell’esercito israeliano che, alla vigilia dell’invasione dei campi profughi palestinesi, spiega ai suoi soldati che bisogna imparare dall’esperienza altrui, compreso il modo in cui le truppe tedesche hanno assunto il controllo del ghetto di Varsavia.
Giorni contati
La negazione dell’esistenza che si manifesta sempre più apertamente nei confronti degli arabi residenti nei territori occupati o cittadini israeliani, si estende ora anche agli israeliani che si rifiutano di unirsi al coro o che vorrebbero semplicemente condurre una vita normale in una società democratica e laica. […] La violenza non si manifesta solo nel campo politico, ma nei rapporti quotidiani, in famiglia e per la strada. La mancanza di buone maniere, che è sempre stata una delle tare della società israeliana, si è trasformata in pura brutalità. Se, un tempo, l’israeliano si caratterizzava per la sua incapacità di dire «per favore», «mi scusi» o «grazie», oggi esso aggredisce fisicamente chi non gli dà la precedenza e, poiché è spesso armato, la cosa può finire tragicamente. Pscicologi e operatori sociali mettono continuamente in guardia contro questa escalation della violenza, ma è poco versosimile che i loro avvertimenti abbiano effetto: è tutta la società che è malata, gravemente malata.
[…]
Solo una piccola minoranza continua a lottare, per i diritti del popolo palestinese e per impedire la trasformazione dello Stato di Israele in uno Stato integralista privo di ogni pretesa democratica. Sarà capace questa minoranza di sbarrare la strada alla fuga in avanti della società israeliana e di impedire che essa vada a schiantarsi contro il muro di odio che si sta costruendo con le proprie mani in tutto il mondo? Il rapporto di forze non è incoraggiante e i giorni sono contati.
[…]
Una delle più efficaci barriere poste alla politica estera israeliana è sempre stata una certa tensione fra gli obiettivi ultimi e massimalisti del sionismo e gli interessi delle potenze mondiali. Anche il più fedele alleato strategico di Israele, gli Stati Uniti d’America, era finora interessato a moderare le mire espansionistiche e belliciste israeliane. Lo esigeva la stabilità regionale. L’11 settembre ha cambiato la situazione, e Ariel Sharon è stato uno dei primi a capirlo.
Per Dick Cheney, Condoleeza Rice e Donald Rumsfeld la stabilità non è più un obiettivo in sé, e certamente non è una ragione sufficiente per porre un freno alle loro avventure militari o a quelle dei loro alleati. Si colpisce tutto ciò che si muove, dopo averlo naturalmente etichettato come «terrorista». […] Questa guerra contro il popolo palestinese (e domani contro i popoli arabi?) è vista dalla Casa Bianca e dal Pentagono come la punta avanzata della crociata del bene contro il male. […] L’identificazione incondizionata, nel Nordamerica e in Europa, dei dirigenti delle comunità ebraiche con Israele rischia di aver conseguenze fatali per le comunità che essi pretendono di rappresentare.
[…]
La società israeliana sta correndo a testa bassa contro il muro. […] Lottare contro l’occupazione, resistere contro la politica di forza, ostacolare le sinistre prospettive di pulizia etnica e di guerra totale contro il mondo arabo-musulmano. Ma combattere anche la filosofia della separazione che rinchiude Israele in un nuovo ghetto, potentemente armato ma pur sempre isolato; mantenere aperte le finestre di cooperazione e di solidarietà per evitare che anche dall’altra parte venga chiusa per sempre ogni prospettiva di coesistenza. È un atto di responsabilità – qualcuno direbbe di amore – far deragliare questa società che sta correndo a precipizio verso la propria distruzione, rifiutando di collaborare, se si è israeliani, e facendo l’impossibile, se si è cittadini del mondo, per porre fine a una condizione di impunità che non può che incoraggiare Israele nella sua folle corsa verso Masada*. Ci riusciranno? Ci riusciremo? È tutt’altro che sicuro. Ma è la sola via possbile, perché nella scommessa è in gioco la vita.
*Riferimento biblico, nonché nome in codice per l’opzione nucleare.
(Brani tratti da Michel Warschawski, A precipizio. La crisi della società israeliana, Bollati Boringhieri, Torino, 2004. «Una duplice disumanizzazione» è il titolo del secondo capitolo, mentre gli altri titoletti sono nostri)