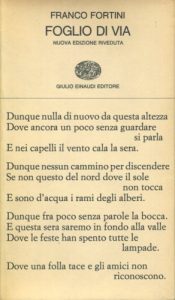Cantare per chi se n’è andata. Resistere con chi è rimasta

Riceviamo e diffondiamo:
Cantare per chi se n’è andata. Resistere con chi è rimasta
“…libertà va cercando, ch’è sì cara,
come sa chi per lei vita rifiuta.”
Vorrei, con le mie parole, cantare per le ossa di mia sorella, farla vivere ancora. E con lei, far rivivere tutte le persone che sono state letteralmente spazzate via da questo nuovo mondo votato alla salute meccanica e alla sopravvivenza.
Non che prima non si morisse, e male, non che prima non esistessero le dannate.
Ma il mondo che va delineandosi da oltre un anno a questa parte ridisegna, per me, il confine fra la vita come feticcio (I.Illich), come mero svolgimento di funzioni biologiche, e la vita piena, libera e radicata nella complessità – o quantomeno la tensione verso questa.
In questa morsa mia sorella è rimasta incastrata, e ha scelto per sé una via verso la libertà.
Una scelta che rispetto, per quanto il mio cuore sia finito in pezzi che non trovo il modo di ricomporre.
Sono sicura che tante fra noi abbiano perso una persona amata in situazioni più o meno direttamente collegate con l’emergenza sanitaria da covid-19 – o meglio, con la sua gestione. Questa sofferenza non può, per me, essere considerata solamente un fatto privato.
Fa male ripercorrere ciò che ci è successo e proverò a farlo senza scadere nella pornografia del dolore, che aborro, e provando a raggiungere l’obiettivo di questo scritto: rimarcare che il personale è politico.
Andare dal particolare al generale, in modo ricorsivo.
Noi siamo nate in Sardegna. Entrambe l’abbiamo lasciata, per ragioni diverse, ma condividendo con tante altre sarde quell’ingombrante contraddizione per cui a vivere nell’Isola ci si sente spesso in gabbia ma a starci lontane ci si sente deprivate, talvolta da non poter respirare.
Ne abbiamo parlato spesso nel corso dell’anno passato: improvvisamente non era più possibile tornare, per la mancanza di soldi per il viaggio o per via dei divieti, per il timore di portare con sé questo maledetto virus e mettere in pericolo le persone a noi care, non più giovani e piene di acciacchi.
Improvvisamente era tutto troppo lontano, irraggiungibile, le distanze accresciute dai dubbi che non riuscivamo a sciogliere, appesantite dall’isolamento indotto – che entrambe, in tempi e modi diversi, abbiamo affrontato e pure messo all’angolo per necessità.
Lo scorso settembre, infine, siamo riuscite a tornare: e vivranno per sempre nei miei occhi gli ultimi momenti che abbiamo trascorso assieme, ridendo e discutendo, guardandoci finalmente negli occhi e parlando a viva voce senza la mediazione di qualche supporto tecnologico, toccandoci, abbracciandoci.
Poco prima del natale 2020 mia sorella ha deciso di licenziarsi da un lavoro pesante e di cui non reggeva più i ritmi. Faceva la oss in una casa di riposo, il cui personale era sottodimensionato rispetto alla mole di mansioni da svolgere, e dove era assente un reale monitoraggio dei contagi.
Si è licenziata anche per poter tornare in Sardegna e stare un po’ con nostra madre. Ha preso le precauzioni che le sembravano sensate: test pre partenza (negativo), mascherina, distanziamento.
A pochi giorni dall’arrivo un ex collega le ha fatto sapere che alla casa di riposo si stavano moltiplicando le persone positive al covid-19, consigliandole di fare un nuovo test.
Così lei ha fatto, rendendosi conto di essere questa volta positiva.
Personalmente, ritengo molto probabile che abbia contratto il virus sul luogo di lavoro, date le scarse attenzioni della direzione nei confronti di possibili contagi, uno spirito dettato dal menefreghismo verso dipendenti e ospiti, vista anche la natura della struttura.
Nell’attesa del risultato aveva già cominciato a tenere tutte le precauzioni possibili. Quando ha avuto il responso, si è isolata in quella che un tempo era la nostra cameretta.
Questo isolamento è durato appena cinque giorni.
Sconvolta dal senso di colpa per la possibilità di aver contagiato nostra madre ed altre persone, non riusciva a darsi pace. In tante abbiamo parlato con lei in quei giorni, per ore.
Si sentiva delle morti sulla coscienza, mi ha detto in un frangente.
Il tre di gennaio, verso l’ora di pranzo, non ce l’ha fatta più: si è tolta la vita.
Mentre lo scrivo mi sembra ancora surreale, anche se già dei mesi sono trascorsi, ma è andata esattamente così. Mi sono precipitata in Sardegna anche io e quel mese là è stato, banalmente, un incubo. Non trovo davvero altre parole.
Al dolore della perdita si sono sovrapposte le linee guida della tanatologia ai tempi del covid: gli operatori bardati da capo a piedi, il suo corpo sigillato e intoccabile, le procedure da rispettare per il funerale in zona rossa. A quel funerale per gran parte del tempo mi sono sentita totalmente sola. Nessun contatto fisico: solo le amiche, le sorelle e i fratelli di sempre hanno infranto ogni codice per sostenermi con le loro braccia e aiutarmi ad andare per il cimitero e tornare indietro. Ho potuto sentire sulla mia pelle quanto il dolore sia più forte nel distacco, nell’assenza di mani, di carezze, e quanto possa essere alleviato da un abbraccio che ti solleva e ti porta quando le tue gambe non ce la fanno più: io non l’ho saputo realmente fino a quel giorno.
Per contro, ho visto la paura negli occhi di chi il contatto voleva evitarlo: non biasimo queste persone per un rischio che non hanno voluto correre, ma mi ha dato certamente da riflettere.
Io stessa non ho toccato mia madre per quasi un mese, ovvero per tutto il tempo che è risultata, infine, positiva.
Solo la mattina in cui sono venuti a prendersi mia sorella non ce l’ho fatta più e le ho preso le mani, dicendole di stringere forte le mie. Per il resto, sono andata a trovarla regolarmente, stando fuori di casa, a distanza, entrambe col volto coperto.
Qualcosa dentro di me diceva: “Resisti. Mantieniti “sana” secondo i canoni di questo nuovo mondo, così potrai renderti utile, potrai andare a prendere questo e quello, sbrigare tutte le faccende di cui c’è bisogno”.
L’ho fatto anche per rispetto di chi mi ospitava in quel frangente, cercando di essere “responsabile”.
A posteriori posso dire di aver fatto ciò che serviva per ridurre il rischio, ma c’è poco da fare: in questi concetti l’umanità ci affoga. E per umanità intendo la capacità di empatia, la prossimità che rincuora, che rinfranca, che schiaccia la solitudine. La prossimità che ha effetti straordinariamente benefici su tutti i livelli della vita (biologico, spirituale, emotivo…) e che questa epidemia ha messo al banco degli imputati. Credo che nell’ultimo anno in tante ci siamo trovate in situazioni simili: privilegiare la prossimità o la sicurezza? Quali rischi correre, in nome di che cosa? E come valutare il rischio, come renderlo verosimile in un vortice di informazioni che hanno spesso creato confusione e, di conseguenza, una visione non lineare, non libera?
Di tutto ciò ho discusso con le persone che mi sono affini, scegliendo di volta in volta quanto rischiare per non perderci completamente, per non ridurre le nostre vite alla mera sopravvivenza.
Ma in questa perdita improvvisa, in questo repentino cambio di latitudine, in questo essere catapultata in una situazione fino ad allora neanche immaginata e lontano dagli spiriti affini non c’è stato quasi il tempo per riflettere, e quando non c’è tempo per riflettere e la mente e il cuore sono oscurati, semplicemente ci si abbandona alla corrente. Questo, almeno, è ciò che è successo a me.
Vorrei avere la possibilità di parlare di questi dubbi con chi si è trovata a vivere situazioni simili. Parlarne fuori dai denti, senza appiattire il discorso sulla scelta fra libertà e sicurezza.
Parlarne con franchezza per capire come altre hanno vissuto questa dicotomia e se hanno avuto abbastanza lucidità per andarvi oltre, come hanno affrontato queste situazioni con persone con cui non discutono e non si organizzano abitualmente. Vorrei farlo perché Anarchia è anche questo – non solo smontare le logiche che informano l’azione di Stato, ma anche trovare modi per noi sensati, etici per far fronte ai problemi e alle questioni che quotidianamente ci si pongono, e fra queste vi è certamente il come affrontare una situazione epidemica senza scadere nell’autoritarismo e nell’atomizzazione tout court.
Voglio essere chiara: per me è straordinariamente vero che l’unica sicurezza è la libertà. Ma come allargare questa consapevolezza? Come comunicarla – con quali gesti, con quali parole – senza che sembri un motto fine a sé stesso? Come posso ad esempio far capire a chi ho intorno che per me è più irresponsabile lasciare una persona sola, pur nel rispetto di tutte le prescrizioni relative al confinamento, che non stare con lei e farle forza se sento che ne ha un’impellente necessità?
Questi avvenimenti – l’isolamento sanitario di persone care, la loro perdita in un contesto in cui la ritualità dell’ultimo saluto viene totalmente sconvolta – sono lungi dall’essere un ricordo lontano, dovremo farci i conti, ahinoi, sempre più spesso.
E vorrei parlare apertamente del terrorismo strillante a cui siamo sottoposte da oltre un anno a questa parte. Perché io lo so: mia sorella è stata uccisa anche dall’iper-individualizzazione della responsabilità. Dai nonsense autoritari e dalle retoriche dell’untore (di mese in mese differenti), in una logica che vorrebbe la nostra colpa pari a quella di chi dirige le deforestazioni dell’Amazzonia, gli scavi nelle viscere della terra, implementa torture negli allevamenti intensivi, gestisce i sistemi sanitari come vere e proprie società per azioni.
Questa spietata attribuzione di colpa, sentimento terribile e cristiano, ha distrutto rapporti di solidarietà e incrinato le volontà già stremate da altre pesanti emozioni, reso la delazione una pratica accettabile, blindato l’isolamento.
Ho cominciato a percepire un filo diretto fra i suicidi di chi è isolata in carcere e i suicidi di chi è isolata per via di queste nuove, aberranti condizioni di vita. Forse è un azzardo, non vorrei fare paragoni impropri, ma io sento questa continuità.
Allo stesso modo vedo nell’isolamento e nel pesante stigma a cui fino ad ora sono state sottoposte le persone psichiatrizzate il germe della forma mentis con cui, ora, potrebbero essere interpretate le volontà di chi vuole rifiutare una serie di trattamenti sanitari (su tutti, i vari sieri sperimentali ora in commercio e già obbligatori per una parte di popolazione, almeno in italia). Il ricatto psichiatrico si basa sull’annullamento dell’autonomia individuale e sul fatto che c’è sempre qualcun che sa meglio di te cos’è bene che tu faccia. Questo “sapere meglio” si fonda in parte sulle competenze – e fin qui, se si potesse discutere alla pari, mantenendo salda la propria autodeterminazione, sarebbe già qualcosa – e in parte sul potere di imporre quelle competenze e le visioni che ne derivano come unica via percorribile (grazie all’azione congiunta di apparato legislativo, giuridico e poliziesco accanto a quello sanitario).
Questo è solo uno degli elementi che rendono la scienza un campo di battaglia, l’ennesimo, e ben lungi da quell’aura di neutralità che va rafforzandosi sempre più nell’immaginario comune.
Quello che sto dicendo è in parte banale, nella misura in cui credo sia stato fino ad ora sotto gli occhi se non di tutte, di tante: ma adesso che questa prospettiva deleteria comincia ad allargarsi, che con l’etichetta omogeneizzante di no vax si comincia a patologizzare, streghizzare una consistente fetta di individui che semplicemente nutrono dei dubbi (ben fondati!) e vorrebbero decidere sul proprio corpo e sulla propria vita, che facciamo?
Mia sorella era una persona generosa e piena di coraggio. Era una creatura gentile e dalla profondissima sensibilità. Era consapevole della sua condizione di sfruttata e odiava le ingiustizie, specie quelle perpetrate contro gli animali non umani, da sempre gli ultimi fra gli ultimi.
Scrivo anche perché vorrei che di lei restasse qualcosa di forte, resistente al tempo e alla polvere, vorrei che tutt sapessero quanto fosse unica, sorprendente.
Quando osservo la boria di certi esponenti di Confindustria, di certi politicanti e militari, mi viene quasi il vomito a pensare che questa gente si senta la coscienza leggera, e che mia sorella abbia trovato insopportabile un senso di colpa indotto e calato dall’alto, e che a causa di questo abbia deciso di andarsene.
Quante come lei hanno lasciato questo mondo, nel silenzio?
Come muoverci per provare a far sì che resistano e restino con noi?
(scritto fra l’aprile e l’agosto 2021)
Testo in pdf: