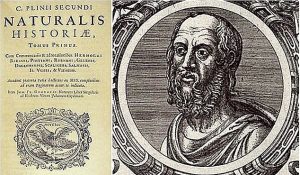Ma vi è qualcosa di più grande del tempio. A proposito di terrorismo rivoluzionario

Testo tratto dal libro Non sono vinta. Raccolta di scritti tra anarchia e antifascismo, edizioni Rina, pp. 125-133.
Ma vi è qualcosa di più grande del tempio
A proposito di terrorismo rivoluzionario
Tensione, angoscia, smarrimento e incertezze in quel tempo in Italia. Che cosa succedeva? Dove si andava? Con la resa delle fabbriche la discesa della parabola aveva cominciato a effettuarsi con velocità progressiva. Era un momento di sosta per riprendere il respiro e raccogliere le forze, o era il principio d’una tremenda disfatta? Era la raffica di un’ora, o la tempesta che si accanisce contro la nave poderosa, e la scuote, e la squassa, e la fende, e la inabissa nei suoi vertici senza fondo? Ci saremmo arrestati lungo la discesa per riconquistare le cime? Avremmo potuto, sia pure faticosamente, risalire sugli spalti insanguinati?
Io debbo aver di certo intuito l’oscuro nostro domani, se in quella occasione mi venne di gridare a noi tutti, la terribile realtà nella quale si era caduti. E di certo la gridai, affinché la comprensione esatta di quell’ora travolgente, ci aiutasse a poterla affrontare, a poterla superare, ché, altrimenti, abbandonando il nostro spirito a delle perniciose e chimeriche illusioni, noi non avremmo che affrettato la sconfitta irreparabile.
No, non cantate no. Questa è perduta,
Forse, per sempre, splendida battaglia!
La debolezza vostra oggi ben fiuta
Chi con leggi vi stringe e vi attanaglia
No, non cantate, no. Ponete il lutto
Su le bandiere, sotto il cielo nero.
«Il folle sogno, illusi, è ormai distrutto»,
Sogghigna lieto il vecchio di Dronero
Oh, in quel tempo, l’angoscia dei nostri giovani! Il loro ardore; il loro desiderio; la loro volontà di fare qualcosa; di far sentire la nostra forza, la nostra vita, la nostra risposta ai colpi ciechi, notturni e vili che venivano dalle paure d’un nemico agguerrito, armato e protetto da tutte le leggi e da tutte le impunità. Oh, i loro occhi ardenti e pieni di lacrime! Il loro silenzio sdegnoso, più eloquente di qualunque discorso: il tremito delle loro labbra che non avevano riposo! V’era nell’aria della elettricità dispersa. Vagava inafferrabile il volto della morte. Qualcosa minacciava di grondare: ammonitrice e salvatrice nello stesso tempo.
Le notizie che venivano da San Vittore, il vecchio carcere di Milano, erano gravi. Malatesta, Borghi e Quaglino rifiutavano di nutrirsi da oltre una settimana. Erano esauriti e ammalati: il loro cuore avrebbe potuto spezzarsi da un momento all’altro. Tempestose erano state le nostre riunioni quella sera.
Tepore primaverile per le vie di Milano; fresche mammolette di marzo a ogni angolo di via; stelle d’oro nel cielo, e una rete di fulgide luci sulla palpitante città dell’industria e del lavoro. Amarezza e veleno nei nostri cuori; lacrime e palpiti nella nostra gola, e l’arrivederci a domani, fu come un soffio, fu come un soffocato singhiozzo, fu come un nodo di commozione che si manda giù tanto male. Uno schianto formidabile: un urlo di lacerante dolore: un traballare disperato della terra e degli animi. La voce della dinamite era stata possente: l’aristocratico e ricco Teatro del Diana ne era stato tutto insanguinato. Ora triste e dolorosa per noi: pensosa ora di angoscia infinita che non ci trovò, purtroppo, tutti concordi nella valutazione del tragico episodio.
Ma sia nei primi momenti, allorché la canea reazionaria si avventò su di noi e fece scempio e ludibrio delle nostre idee; sia più tardi, allorché qualcuno mi scrisse in nome della sua giovane sposa rimasta vittima dell’esplosione; io che pur sento, e come profondamente, la desolazione che segue questi gesti estremi, gesti che sono inevitabili perché conseguenza logica di cause provocatrici, io scrissi a più riprese:
I bombardieri sono stati dei proiettili caricati dall’ingiustizia della società e dal cinismo e dalla viltà della reazione. Quando la tempesta è densa, e il cielo è nero, e i lampi rosseggiano sull’orizzonte, e l’albero maestro cade d’un tratto schiantato, ditemi, potremmo fare noi il processo al fulmine? Cercate altrove, cercate fra di voi il responsabile vero. E metta la società il velo nero, e chieda perdono a quei morti, e chieda perdono a quei sepolti vivi!
Da allora degli anni sono passati e i nostri occhi hanno veduto delle cose terribili. Hanno veduto l’espandersi del fascismo con quanto di più abbietto, di più selvaggio, di più barbaro, di più crudele può avere una reazione. Non è leggenda questa: è dura realtà. E tutto il mondo è pieno dello strazio dei martoriati, dei mutilati, degli strangolati, dei crivellati. Tutto il mondo sa che l’Italia è una prigione immensa: una di quelle ignobili galere romane nelle cui stive gli schiavi lavoravano di remi, incatenati l’uno a l’altro, sul loro posto di affanno e di morte. E pensavo che almeno oggi, che finalmente oggi, dopo tanta amara esperienza, dopo lo spettacolo di tanta ignobile violenza nemica, noi anarchici ci saremmo alfine trovati d’accordo sulla valutazione dei gesti di rivolta che esplodono di tratto in tratto fra le nostre file. Pensavo che l’argomento sarebbe stato ormai superato e che nessuno di noi avrebbe più tentennato davanti al vim vi repellere – respingere la violenza con la violenza. Ma il vostro articolo, compagno De Santillan, mi ha fatto pensosamente riflettere; mi ha fatto dolorosamente notare come siamo ancora purtroppo lontani da una mentalità adeguata alle esigenze sempre più crescenti di guerra sociale; nella lotta contro il nemico. Ah! Dunque voi mettete sullo stesso piano di valutazione, la violenza anarchica e la violenza fascista?
Ma i fascisti colpiscono per imbavagliare, per dominare, per asservire, per incatenare tutto un popolo dentro una prigione di terrore e di martirio. Gli anarchici colpiscono per accendere una fiamma in questa notte profonda: per strappare le orribili catene che ci rendono vili e inetti: per dire alla folla: «Alzati e cammina». Gli uni sono la mano nera della reazione: gli altri l’ala bianca e pulsante della libertà: gli uni sono dei luridi sicari pagati a un tanto ogni testa che cade: gli altri lasciano la testa sui patiboli, o la vita nelle galere.
Noi auspichiamo una società basata sul mutuo accordo, sull’amore e sulla giustizia? Verissimo. Ma se compagni, se amici nostri, col cuore avvelenato da tanti dolori, con l’anima piena di fiele per tante ingiustizie patite o vedute patire, riprendono ai capitalisti e ai banchieri, a questi corrottissimi ladri legali, oh, non temete, un poco, solo un poco delle immense ricchezze che essi hanno rubato a piene mani; se compagni e amici nostri, piena la gola di pianto e piena la bocca di amaro, fanno sentire il rombo della dinamite, noi, proprio noi abbiamo il diritto di respingerli e di condannarli in nome della pubblica opinione, o in nome d’un ideale d’amore e di giustizia?
La pubblica opinione? Essa può dividersi in due categorie. Quella che noi non disprezziamo e a cui rivolgiamo preferibilmente la nostra propaganda, e quella che è, e che resterà dall’altra parte della barricata. Ebbene, mentre noi non dobbiamo contribuire con le nostre scomuniche a rendere la prima più paurosa e più sorda alla voce della rivolta, dobbiamo invece disinteressarci dell’opinione dell’altra. E che cosa infatti può a noi interessare l’opinione di gente che noi detestiamo in virtù della nostra morale, e alla quale, prima di tutto, noi neghiamo ogni diritto di erigersi a giudice, dal momento che è essa l’accusata e noi gli accusatori?
L’ideale d’amore e di giustizia? Ma il prigioniero che vuole a ogni costo riconquistare la libertà e aprirsi una vita di pace e di affetti, ricorre necessariamente a un atto di violenza per ritrovare un libero cammino. Ma il chirurgo che vuol salvare il malato non esita a immergere il suo bisturi nella carne del paziente; non esita ad asportargli una parte del corpo affinché il cuore e il cervello non cessino di vivere.
Noi dobbiamo illuminare le menti, noi dobbiamo fare opera di persuasione e di propaganda per formare le coscienze del domani; questo è vero. Ma quando davanti a tanta oppressione che ne impedisce perfino il respiro, quando non si trova più riposo, tante sono le voci che salgono dalle tombe invendicate; se l’angoscia di uno dei nostri esplode e scava, sia pure con una ecatombe insanguinata, noi dobbiamo sentire un grande, un grave e solo dovere. Quello d’essere vicino a questo giovane valoroso, e allargare le braccia, perché fra tante ingiurie, calunnie e maledizioni, egli ritrovi un poco di conforto nell’affetto dei suoi compagni.
E noi che spesso, e con la parola e con lo scritto, abbiamo denunciato le criminose ingiustizie, di cui siamo circondati; noi che più volte, e con la parola e con lo scritto, abbiamo battuto sulla necessità della rivolta; noi, di cui forse qualche frase apocalittica si sarà incisa nella giovane mente che oggi ha agito; noi dobbiamo sentirci in qualche modo responsabili del suo gesto; responsabili morali, e come tali, nulla rinnegare, non rinnegando lui, il vendicatore!
Dunque voi vorreste solamente l’estetico e classico attentato dalla purezza plutarchiana! Bresci, per esempio, che sorge, pallido e impassibile davanti al re, al freddo e cinico responsabile dei massacri della Lunigiana, della Sicilia e della Lombardia. E chi non lo vorrebbe questo? Ma i tempi sono mutati e gli avvenimenti di questi ultimi anni ci debbono far sentire la necessità, le esigenze della rivolta e della cospirazione sotterranea, per respingere un nemico attaccandolo con le sue stesse armi.
Per respingere un nemico che è vile quando assale: per respingere un nemico che ben sapendo di quanto sangue grondino le sue mani, si corazza e si nasconde e si circonda di tutte le possibili cautele, sì da impedire il gesto giustiziere a chi volesse attaccarlo all’aperto. V’è qualcosa nella vita di più grande della casistica posta a guardia del tempio: il dolore e la sofferenza umana di cui è permeata l’idea.
«Un tempo Gesù passò in un giorno di sabato per i seminati, e i suoi discepoli ebbero fame e presero a svellere delle spighe e a mangiane». Ai farisei che accusarono costoro perché avevano fatto ciò che non era lecito fare in giorno di sabato, Cristo rispose: «Ora io vi dico che c’è qualcosa qui di più grande del tempio. E se sapeste che cosa significhi: voglio misericordia e non sacrificio, voi non avreste condannato gli innocenti».
Oggi un’intera nazione è dominata dai pugnali e dai randelli. Oggi a migliaia e a migliaia sono gli uomini dispersi pel mondo, senza affetti, senza famiglie, senza risorse. Oggi ognuno di noi è una angoscia vivente, che trova ancora possibilità di vita nella fede, che unica ricchezza fra tante ruine, gli è rimasta nel cuore. Oggi non vi sono che cadaveri mutilati e insanguinati attorno a noi: ecatombe sopra ecatombe, e voi potete sottilizzare, voi potete sofisticare sui distinguo d’un inqualificabile tolstoismo, voi potete fare del celebralismo, voi potete commuovervi, allorché dall’altra parte della barricata, senza che dalle nostre file sia stato mandato un cavalleresco biglietto da visita, un riparo salta all’aria, o una ignobile fortezza crolla e si sfascia? È in nome del sentimento che voi parlate? Ma nelle lotte sociali, il sentimento che non è fuso alla ragione e alla logica può paragonarsi a quelle bolle di sapone della nostra infanzia dorata e lontana. Con quanta grazia, con quanta attenzione, con quanto entusiasmo noi si soffiava nella cannuccia di legno. Era in quel lavoro tutta la tensione della nostra piccola, bella anima infantile. Ma ahimè! I variopinti, minuscoli castelli e i lumicini inargentati e le vele e le piccole barche, tutto viveva un istante, solo un breve istante tutto scompariva con le bolle di sapone! È in nome dell’amore che voi parlate? Ma nel campo sociale l’amore che non è figlio dell’odio è sterile palo, non è albero fecondo. Non ha radici nella terra; non ne beve i vividi succhi: non si nutre di vigorosa linfa: non respira e non vive, non dà le riposanti ombre negli afosi meriggi: non concepisce, né germoglia nei mesi di nevoso silenzio. È legno distaccato dal cielo e dalla terra: è legno secco e isolato che si lascia rodere dal tempo e dal tarlo. È in nome delle nostre istituzioni che ci sono così care, e che tanto sacrificio ci sono costate, è in nome di esse che voi parlate? Ma lo stesso militarismo ci insegna qualche cosa, allorché nelle ore delle lotte e delle necessità estreme, fa saltare le stesse fortezze che egli ha edificato con dispendio di tanto lavoro e di tante ricchezze.
Compagno De Santillan, io vi ho conosciuto a Berlino, nei primi tempi del mio esilio, allorché le ferite erano ancora fresche, ma non facevano così male, come fanno male oggi, ché non si vogliono cicatrizzare. Abbiamo più volte conversato delle nostre idee nella vostra stanzetta ingombra di libri, nella stanza nella quale passavate intere giornate curvo sul lavoro. Accettate questo mio richiamo con animo di fratello, e raccoglietevi un poco sopra queste mie riflessioni. Ché io ho visto i miei migliori compagni cadere trafitti nella terribile mischia: ché io ho visto i miei più buoni compagni gettati e rinchiusi nelle più orribili prigioni; ché io ho visto i miei più cari compagni dispersi in paesi dei quali non conoscono né le genti, né la lingua; soli, e spesso senza un soldo; soli, e spesso senza un pane. E quando qualche ribelle sorge d’improvviso fra noi, e un suo qualsivoglia gesto vendicatore schianta qualcosa di questo vecchio edificio nel quale siamo incatenati, io gli prendo la mano e gli dico: «Coraggio; viva l’anarchia!».
Virgilia D’Andrea