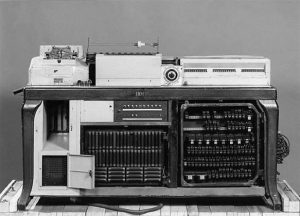Riflessioni sull’Ilva

Ripubblichiamo queste riflessioni, uscite nel febbraio 2013 sul numero 21 del giornale anarchico “Invece”, perché non hanno perso nulla, ci pare, della loro attualità.
Riflessioni sull’Ilva
Ciò che a partire dall’Ottocento si è chiamato questione sociale sta riemergendo, dopo decenni di rimozione, in tutta la sua violenza.
Il caso dell’Ilva di Taranto è un bagno gelido per tutti coloro che si erano addormentati con la nenia dello sviluppo, del progresso, della fine del conflitto di classe. Nocività, disastro ambientale, produzione capitalistica, profitto, lavoro salariato non sono chincaglierie di un’epoca remota né il triste privilegio di terre sventurate e lontane. I fumi dell’Ilva sono il nostro ora e il nostro qui.
Una Sfinge ha lanciato il suo terribile enigma agli abitanti di Taranto e a tutti noi. La posta in gioco non è un premio politico o filosofico, bensì la vita o la morte. Per sciogliere l’enigma, purtroppo, non basta capirlo e svelarlo. La Sfinge non scomparirà, questa volta, da sola nell’abisso.
Non racconteremo anche noi la storia dell’Ilva, dei danni che ha provocato, delle complicità politiche e sindacali su cui si è retta, dell’intervento della magistratura e infine del decreto del governo. Vogliamo fare qualcosa di diverso e di meno rassicurante: trarre delle conclusioni.
Se non fosse bastata la storia degli ultimi due secoli, l’esperienza dei “tecnici” al governo dovrebbe averci insegnato che la scienza non è mai neutra. Precarizzare ulteriormente le condizioni di lavoro, cancellare garanzie, allungare l’età pensionabile non sono misure da ragionieri chiamati a “far quadrare i conti”, bensì scelte orientate da un progetto di società. Se, per ipotesi assurda, gli stessi soldi fossero stati presi dalle tasche dei ricchi, questi ultimi non avrebbero certamente pensato di subire i rigori di una necessaria austerità per il cosiddetto bene comune, bensì di essere vittime della “violenza comunista”.
Le misure “tecniche” non sono, come si ripete a sinistra, un modo iniquo per ridurre il debito pubblico. Sono le condizioni richieste oggi – quale che sia il colore del governo – dal capitalismo a livello internazionale. Il colpo di Stato istituzionale (Napolitano-Pd) per insediare il professor Monti al governo aveva un duplice scopo: far approvare leggi di cui i partiti non volevano assumere in proprio la responsabilità e indorare la pillola dell’austerità (in dosi da cavallo) con l’imparzialità della scienza. Il decreto sull’Ilva, che dovrebbe tramortire da solo ogni residua illusione democratica, è l’ultimo atto del dramma. Rispuntano la «pubblica necessità» e l’«interesse strategico nazionale» in nome dei quali si sono imposti e militarizzati inceneritori, discariche e cantieri del TAV. E come ogni “misura urgente” che l’ha preceduta, anche questa varrà in futuro per altri casi.
Ma la scienza è sempre di parte anche in un altro senso. Una volta accumulati i dati sull’inquinamento, sui tumori, sulle malattie infantili, sulla sterilità provocati dall’Ilva (meglio: dal sistema di nocività in cui l’Ilva ha giocato un ruolo di primo piano), che succede? Quei dati, senza una forza che ne faccia uso, rimangono ciò he sono: dati. Ed è ben tragico che la forza in questione (certo non isolata dal suo contesto) sia stata la magistratura. Da un lato, magistrati che sequestrano impianti, prodotti e semilavorati industriali perché fonte e risultato di «omicidio colposo plurimo»; dall’altro, operai che bloccano le strade cittadine rifocillati dai padroni dell’Ilva: si stenta a trovare le parole per commentare questa immagine. Un’immagine ben stridente con la favola del libero lavoratore che liberamente offre le proprie competenze al mercato. Solo una società ignobile mette degli esseri umani nella condizione di dover scegliere tra il morire di cancro e il morire di fame. Gli interessi industriali sono intoccabili. Se, per una volta, vengono messi in discussione da un intervento della magistratura, a loro difesa si mobilita il governo; e lo fa, ovviamente quanto spudoratamente, in nome degli interessi dei lavoratori (gli stessi lavoratori licenziati un po’ ovunque a migliaia per via delle esigenze di profitto, esigenze che le leggi del governo promuovono e assecondano).
La vicenda dell’Ilva è davvero emblematica. Non solo per lo sfacelo ambientale e sociale che ha provocato, ma anche per il cosiddetto dibattito che ha aperto. “Bonificare” e “risarcire” sono espressioni che tornano di continuo.
Partiamo dalla seconda.
Non è possibile “risarcire” né gli abitanti né il territorio di Taranto. Non solo non è possibile compensare a livello economico le morti, le sofferenze, i danni ecologici irreversibili provocati, ma non si possono nemmeno vendicare, perché sono incommensurabili. Se il credente Dostoevskij scriveva che non c’è piano divino che possa giustificare la sofferenza di un bambino, con quale piano industriale si potrebbe giustificare ciò che i Riva hanno fatto ai bambini di Taranto (ai loro genitori e al loro ambiente)? La giustizia è fuori d’ogni portata, perché niente e nessuno può riportare in vita la morte. La vendetta, dice un proverbio arabo, non ripara un’ingiustizia, ma può impedire che altre cento vengano commesse. Ed è questo l’unico piano su cui possiamo metterci e agire. Un piano che nessun magistrato potrà mai effettuare.
Espropriare tutti i beni dei Riva (dai soldi ai prodotti industriali, dai capannoni alle proprietà immobiliari) e utilizzarli per pagare le cure mediche e ospitare le famiglie inquinate e impoverite dai profitti dell’Ilva: ecco il minimo. Il minimo non rispetto alla giustizia (per la quale tutto sarebbe troppo poco, compresa la fucilazione degli industriali), ma rispetto alla dignità e all’equità. Altro che riaprire la fabbrica per garantire i posti di lavoro senza cambiare rapporti di produzione e rapporti sociali. Dopo tutto quello che è successo, il minimo sarebbe che i lavoratori dell’Ilva venissero subito pagati dai Riva (direttamente o indirettamente) in cambio di niente, cioè che venissero pagati per non inquinare, per curare e curarsi: insufficiente, immediata, basilare equità. La giustizia sociale, invece, è un’altra faccenda. Essa pretende non solo di sbarazzarsi dei Riva e del loro mondo, ma di abbattere dalle fondamenta un sistema di produzione che ci priva persino della vita. Vendicarsi davvero dei Riva e di chi li ha sostenuti per anni significa allora sovvertire la società che li ha prodotti e arricchiti. Senza rompere il quadro attuale non c’è soluzione possibile (e a chiunque la proponga bisognerebbe rispondere, con il poeta, «mi rifiuto di mettere ordine in un porcile»). Il profitto se ne infischia delle leggi e dell’indignazione morale. Un inizio di vendetta e di equità consiste nel riprendersi – violando la sacra legge della proprietà – parte di ciò che l’Ilva ha sottratto al territorio e ai suoi abitanti. I dati di ciò che ha provocato ci sono. I dati di ciò che si è accaparrata si trovano (si sprecano persino le trasmissioni televisive al riguardo). Il punto rimane: quale forza può fare davvero un uso pratico e sociale di questo sapere?
E ora veniamo alla questione più spinosa. L’Ilva è bonificabile? La sua produzione, con tutti gli interventi necessari, è compatibile con la salute e con l’ambiente (non quello dei protocolli ministeriali, ma quello vivo e dei vivi)? La risposta non può essere delegata né alla magistratura, né al governo e ai suoi pretesi garanti – che per anni hanno garantito solo inquinamento e morte. Torniamo allora alla scienza e alla sua natura di parte. Abitanti e lavoratori di Taranto dovrebbero esaminare attentamente e autonomamente la questione. Se la risposta fosse negativa, i beni dei Riva – compresi capannoni, macchinari, prodotti finiti e semilavorati – dovrebbero essere espropriati e usati per creare altre attività, tra cui quella, urgente, di por mano ai disastri provocati al mare e all’agricoltura. Le 1700 mila tonnellate di prodotto giacente sequestrato dai magistrati in quanto “corpo del reato” (il cui valore si aggira attorno al miliardo di euro) potrebbero, ad esempio, essere un buon inizio.
Qualcuno propone un reddito garantito. Ma garantito da chi? Se i soldi venissero dalle istituzioni nasconderebbero un’insidia non trascurabile. Farebbero apparire lo Stato come una sorta di regolatore e mediatore del conflitto sociale, laddove esso è il difensore degli industriali. Non si tratta di un problema “ideologico”, ma pratico: un intervento economico da parte dello Stato (per strappare il quale ci vorrebbe comunque, soprattutto in un periodo come questo, una lotta molto dura) non sarebbe mai sganciato dall’Ilva e dalla sua rimessa in funzione. Che i soldi vengano da Stato o padroni non fa molta differenza, si dirà. La condizione, però, è che vengano visti entrambi come responsabili del disastro; e che ciò che si strappa loro per quello che hanno fatto non contenga alcuna ipoteca sul futuro degli abitanti e del loro territorio.
E se la risposta fosse positiva? Proviamo a immaginare degli scenari e a sollevare i conseguenti interrogativi, cosa ben più interessante che non suggerire soluzioni.
Gli interventi di bonifica potrebbero esser fatti (a produzione ferma) sempre con i soldi dei Riva. Una volta rimessa in moto la nuova e diversa produzione, gli utili potrebbero servire agli operai e a tutto il territorio tarantino per vivere, curarsi, risanare l’agricoltura ecc. Viste le pesanti e innegabili responsabilità istituzionali, ad abitanti e lavoratori spetterebbe il compito di tenere ben lontane dall’Ilva le mani dello Stato. Se la nazionalizzazione della produzione – caldeggiata dai sindacalisti più a sinistra – renderebbe solo gli operai schiavi di un diverso padrone, l’autogestione da parte di un Consiglio di lavoratori e abitanti insieme permetterebbe il controllo consapevole dell’intero processo produttivo. E i Riva, in tutto ciò, cosa ci guadagnerebbero? Forse di non finire fucilati.
Ma l’Ilva di Taranto è una costruzione mastodontica. Potrebbe essere gestita senza una direzione centralizzata (con i relativi rapporti gerarchici di produzione)? Anche ammesso che un Consiglio di lavoratori e abitanti potesse esercitare un controllo sullo stabilimento tarantino (ipotesi che solo un duro scontro sociale renderebbe possibile), che ne sarebbe dell’approvvigionamento di materie prime e poi della collocazione dei prodotti? Un controllo effettivo e una reale condivisione dei saperi presupporrebbero un allargamento dell’autorganizzazione all’intera filiera dell’acciaio, filiera che rappresenta un tassello decisivo di tutto il sistema industriale. Un simile processo di autorganizzazione (senza il quale il controllo dal basso dello stabilimento tarantino non potrebbe aver luogo oppure non farebbe altre che trasferire altrove i problemi) porrebbe la dimensione dello scontro con industriali e istituzioni a un livello insurrezionale. Che succederebbe allora?
Dall’acciaio dipende anche il comparto della produzione bellica. Ci si può preoccupare della propria salute senza interessarsi di chi, anche a causa del nostro lavoro, viene ammazzato o avvelenato in altre parti del mondo? Se operai e abitanti si rifiutassero di collaborare con la macchina della guerra, tuttavia, lo Stato non starebbe certo a guardare – perché ne andrebbe della sua stessa sopravvivenza. Ma a quel punto si rovescerebbe la necessità della difesa degli interessi immediati dei lavoratori e delle loro famiglie, con una nuova definizione dei bisogni, dei valori, dei rapporti sociali, della relazione tra campagna e città ecc. Fuori dalla difesa del salario (o del profitto, che è l’altra faccia della medaglia), l’attuale produzione di acciaio – sia in termini quantitativi che qualitativi – che senso potrebbe mai avere?
Non è solo un problema di emissioni nocive. Senza mettere in discussione come vengono estratte, trasportate e lavorate le materie prime; senza conoscere e controllare l’uso sociale dei semilavorati e dei prodotti finiti cosa significa la parola “autogestione”? E cosa diventa, in un autentico processo di autogestione, la cosiddetta scienza i cui dati sembrano così indiscutibili? Quale sapere porterebbero al campo della libertà gli “esperti” che scegliessero di disertare il campo del potere? Abbiamo evocato questi scenari e sollevato questi interrogativi non per mero gusto dell’estremismo, ma perché la miseria immaginativa è una delle principali miserie del nostro tempo; perché senza i vuoti del possibile la realtà si trasforma in una “cosa”; perché si tratta di possibilità sperimentate più volte nella storia, prima che la pacificazione socialdemocratica e consumistica trasferisse la questione sociale dalla terra degli uomini al cielo delle loro false rappresentazioni, oggi altrettanto tossiche dei fumi delle ciminiere.
Ma questi scenari sembrano convergere in un punto: la difesa degli interessi immediati di un gruppo di lavoratori non può che essere in contraddizione, nella società capitalista, con gli interessi, la salute o la vita di altre fasce della popolazione.
Il cerchio si chiude. Se si può ipotizzare che in una società diversa (la quale, come minimo, non avveleni gli esseri viventi e il loro ambiente) la produzione stessa dell’acciaio cambierebbe di senso e di modo, il mantenimento dell’Ilva si pone dunque solo in termini di difesa del salario. Questo è il problema. Ma allora un inizio di soluzione – contemporaneamente fuori e dentro l’ordine esistente, opera di salariati che non vogliono più esserlo – è espropriare quello che serve per vivere, non continuare a produrre ciò che fa e ci fa morire.
Spezzare la dipendenza di un intero territorio da una fabbrica maledetta, che ricatta tutto e tutti, è un passo fondamentale. I piani industriali vanno e vengano, ma la terra, l’aria e il mare restano. Senza i prodotti della terra e dei suoi cicli un territorio, appena si stacca la spina dell’Ilva di turno (cosa che prima o poi deve avvenire), si degrada, si spopola, muore.
La sola prospettiva umana è capire che il denaro non si mangia, benché ci permetta, in questo mondo disumano, di mangiare.
Ma un mondo in cui gli uni mangiano a danno degli non è solo disumano. È un mondo al capolinea.
Quel pane che avvelena noi, le nostre anime e i nostri figli non vogliamo più mangiarlo: ecco l’inizio della soluzione. Non inghiottire più ricatti né veleni, prendendo tutto ciò che ci serve a chi si è arricchito con il disastro delle nostre vite e dei nostri territori, a chi lo ha protetto, a chi lo ha giustificato, a chi lo ha difeso.
Difficile? Certo. Le soluzioni facili hanno tutte un gusto di diossina.
Con simili ragionamenti, si dirà, trascuriamo le urgenze e dimostriamo di avere poco realismo. Potremmo rispondere che in nome dell’urgenza ci stanno espropriamo di tutto e che di realismo, oggi, si muore.
L’enigma lanciato dalla Sfinge tarantina, come si vede, ha bisogno di intelligenze insorte, di cuori irrealistici e di scelte risolute. Se non riusciremo a raccogliere fino in fondo questa sfida mortale, il miasma si diffonderà senza confini di tempo e di spazio. Nessun Edipo verrà a salvarci.
Inutile illudere e illudersi. Abbiamo di fronte il sistema industriale e lo Stato. Senza uno scontro sociale aperto e duro, non potremmo mai scegliere cosa, come e perché produrre. Il prodotto della nostra attività collettiva continuerà allora a ritorcersi contro di noi e l’ambiente in cui viviamo, sotto forma di sfruttamento, divisione, inconsapevolezza, passività, inquinamento, morte.
Solo una rivoluzione sociale può ricacciare la Sfinge nell’abisso. Ciò non toglie che contro le mille ingiustizie bisogna agire subito, perché non c’è tempo per scansarci o transigere quando esseri umani e animali muoiono di veleni e i bambini non riescono a respirare.
Quelle sofferenze e quelle morti chiamano vendetta, perché altri ancora non soffrano e non muoiano.
Ci chiamano a liberare le nostre vite e i nostri territori, perché la libertà soltanto può proiettare un’ombra di giustizia.
Pianeta Terra,
inizi di gennaio 2013