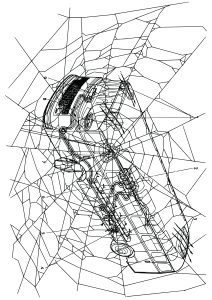Luci da dietro la scena (XXXI) – Siamo tutti palestinesi?
Luci da dietro la scena (XXXI) – Siamo tutti palestinesi?
Qui in PDF: Luci (XXXI)
C’è resistenza e «resistenza»
Sulle pagine del New York Times, «La resistenza in Ucraina si sta intensificando», mentre «I combattenti di Hamas si nascondono sotto i quartieri residenziali». «I combattenti ucraini lottano in clandestinità nelle periferie che conoscono a fondo, usando auto-bombe e trappole esplosive, oltre a omicidi mirati con le pistole», invece i combattenti di Hamas «nascondono le loro armi in tunnel lunghi chilometri, e nelle case, nelle moschee e nei divani». Sulle pagine del Times, entrambe le resistenze si stanno «mescolando alla popolazione locale», «confondendo il confine tra civili e combattenti». Il giornale dichiara: «operando in questa maniera, Hamas è responsabile di tanti morti tra i civili, secondo la legge internazionale». Ma lo stesso giornale si compiace quando il rapporto di Amnesty International, in cui si accusano i militari ucraini di violare le leggi internazionali e di mettere a rischio le vite dei civili perché agiscono negli ospedali, nei quartieri residenziali e nelle scuole, «è stato accolto da una condanna diffusa e quasi universale».
Se leggi il Times, finisci per concludere che gli ucraini vanno in guerra nella giungla di cemento perché, a differenza dei palestinesi, «hanno sempre meno scelta quando si tratta di posizionare i loro soldati». L’Ucraina «si sta difendendo dall’esercito russo che ha una potenza di fuoco largamente maggiore». Ma «le tattiche di Hamas [in uno dei posti più densamente popolati della terra] spiegano perché Israele è stato costretto a colpire così tante infrastrutture civili, uccidere così tanti palestinesi e incarcerare così tanti civili».
La resistenza, nella mente occidentale, è un concetto mutante. Mentre la resistenza ucraina è elogiata per le sue tattiche di guerriglia, la resistenza palestinese – definita «terrorismo» – è sconcertante, perversa e patologica. I media istituzionali non insistono su queste caratteristiche perché sussistono differenze fondamentali nel modo in cui entrambe le resistenze esercitano violenza. Né questo atteggiamento dipende interamente dal colore della pelle degli ucraini: basta considerare l’Esercito Repubblicano Irlandese (IRA) per vedere che la pelle bianca da sola non è un biglietto vincente, per lo meno non in una guerra contro il colonialismo britannico.
Piuttosto, i media utilizzano toni diversi perché sono a servizio degli interessi strategici dell’Occidente. Mentre il regime colonialista d’insediamento di Israele è l’alleato più importante degli Stati Uniti in Medio Oriente, e praticamente una branca dell’Europa per proteggere l’imperialismo occidentale, la Russia rappresenta una minaccia «esistenziale» per l’Occidente. Perciò, non è certo una sorpresa che i giornali di proprietà delle classi dominanti, e da esse manovrati, delegittimano la ribellione palestinese nelle stesse pagine in cui celebrano quella degli ucraini. Per sostenere il progetto sionista in Palestina, per proteggere le imprese militaristiche e capitalistiche dell’impero nella regione, il combattente per la libertà palestinese deve cadere. E di conseguenza, gli stenografi dell’impero normalizzano la deumanizzazione dei palestinesi e demonizzano la loro resistenza. Quanti palestinesi sono stati uccisi proprio da quelle stesse forze e istituzioni che esigono «neutralità» e «imparzialità» da loro per poterne asserire l’«innocenza»? In un modo o nell’altro, siamo tutti terroristi agli occhi dei giornali più letti.
[…] Se vuoi umanizzare il palestinese, devi renderlo innocuo: ecco qual è il problema.
[…] Quando l’esercito di occupazione israeliana ha ucciso il quindicenne Adam Ayyad nel campo profughi di Dheisheh a Betlemme, le domande sono state: Ha lanciato veramente una bomba molotov contro i soldati? Non è risaputo che gli israeliani inventano storie del genere? Quando invece avrebbero dovuto essere: Perché ci sono truppe israeliane a Betlemme, tanto per cominciare? Perché Adam Ayyad è nato in un campo profughi? Perché c’è “molotov” nel titolo di un articolo sui soldati che uccidono un ragazzino? E allora, se lancia una bomba molotov? Chi non lo farebbe?
[…] L’invenzione del civile come figura “imparziale”, “neutrale” ha esacerbato la depoliticizzazione della causa palestinese. Essere ritenuto un civile significa esistere in una dimensione mitologica in cui siamo senza prospettiva. La nostra causa, così com’è immaginata in questa mitologia, non è più percepita come una lotta di liberazione, ma come una “crisi umanitaria”, in cui i rivoluzionari non sono parte integrante della nostra nazione, motivati da aspirazione politica e sogni di emancipazione. Vengono invece interpretati come banditi che senza motivo causano scompiglio e lasciano sgomenti i passanti indifesi: le donne e i bambini disinteressati, i paramedici e i giornalisti imparziali.
Se questo è un bambino
Nel momento esatto in cui il palestinese esce dall’utero, viene privato dell’infanzia – scaraventato via dall’infanzia da un «macchinario che esiste sempre e ovunque» e trattato come uno zero buono a nulla e, allo stesso tempo, come una pericolosa bomba a orologeria. Il palestinese è privato dell’infanzia la prima volta che parla con suo zio dietro il vetro divisorio della prigione, o chiede a sua zia perché vivono sotto i tetti in lamiera, o cerca di decifrare che cosa è stato cancellato dalle insegne delle vie. O quando abbraccia suo padre accanto a un blocco di cemento, dicendo a se stesso che le esplosioni che sente sono soltanto fuochi d’artificio. O quando gioca a calcio sulla spiaggia. Da qualche parte, lungo la stessa linea, il bambino palestinese s’imbatterà nell’espressione «bambino ucciso illegalmente», usato per descrivere i suoi coetanei ammazzati; un professore di Yale scriverà un articolo sull’Atlatic su come «sia possibile ammazzare legalmente i bambini». E il cecchino eseguirà gli ordini.
La palestinese è privata dell’infanzia la prima volta che supera un checkpoint e sente la mano pesante di un estraneo sotto la sua camicetta, la prima volta che si siede accanto al banco vuoto della sua compagna di classe. O quando prende l’autobus per tornare a casa e guarda fuori dal finestrino e vede un’altra studentessa in una pozza di sangue. Viene esiliata dalla sua infanzia la prima volta che chiede perché sulla foto di sua madre c’è un nastro nero, o perché i vicini piangono quando si congratulano con lei. La prima volta che lancia i sassi su un mare di divise verde militare o imbeve uno straccio prima di cacciarlo in un collo di bottiglia, o quando sente il bozzolo d’acciaio che diventa una farfalla dentro il suo ginocchio [riferimento alle “pallottole a farfalla” progettate per espandersi nel corpo al momento dell’impatto]. La prima volta che un ragazzino palestinese sente la botta del martelletto del giudice, o l’acciaio freddo sui polsi minuti, è costretto a diventare adulto. Osserva il suo riflesso in una pozza di sputi; scopre di avere già i capelli grigi. Cresce sotto la luna del neon, diventa grande nella sala degli interrogatori.
Siamo davvero tutti palestinesi? *
Noi, a migliaia e a milioni, mentre protestiamo in coro per le strade di New York e Londra? Mi faccio questa domanda in modo incessante, con ossessione. Due anni fa, avrei detto, dichiarato addirittura, che il cemento delle barriere israeliane è proprio questo, cemento, e ha soltanto un peso simbolico. I loro confini coloniali, per quanto ci provino, non recidono, e non potranno recidere i legami sociali e nazionali che tengono insieme le nostre città isolate. I nostri documenti diversi – documenti di viaggio, passaporti, lasciapassare o la mancanza di questi – sono soltanto parole su una pagina, incapaci di dividerci.
Quelli che sono dispersi dietro i muri e il filo spinato, avrei detto, possono comunque unirsi nei loro cuori. Eppure, io cammino per queste metropoli, protestando – c’è repressione, ma ancora niente lacrimogeni – e Omar è in cella in una prigione dell’Occupazione, in cui almeno sessanta prigionieri politici palestinesi sono stati martirizzati dal 7 ottobre. A Khan Yunis, uomini in tuta da ginnastica vengono uccisi con colpi di arma da fuoco al petto, alla testa, nel coraggio della loro ultima azione, sia che stiano correndo verso un Merkava corazzato [carro armato usato esclusivamente dall’esercito israeliano] o verso una relativa sicurezza. Nel campo profughi di Shatila a Beirut, un nonno vive e muore tormentato dalle visioni della sua vecchia casa sulla spiaggia, un ricordo così viscerale che quasi riusciva a sentire il profumo del mare. A Gerusalemme, mi preoccupo della casa della mia famiglia, di mio fratello che fa il pendolare per andare al lavoro e dei poliziotti con il grilletto facile. Altri posti potrebbero essere altri pianeti, ognuno con le proprie principali cause di morte.
Nel Naqab i beduini palestinesi vengono sradicati e rimpiazzati da alberi di pino tedeschi. A Silwan, le forze di occupazione demoliscono case per realizzare una fantasia biblica. A Sheikh Jarrah, la pulizia etnica viene mascherata da «disputa immobiliare». A Beita, i coloni costruiscono avamposti in cima alle colline, i soldati assieme a loro. A Masafer Yatta, un giudice della Corte Suprema israeliana – lui stesso un colono della Cisgiordania occupata – delibera di espellere alcune migliaia di palestinesi dalle loro terre ancestrali, che abitano e coltivano da generazioni. Di tutti i beni saccheggiati, la terra rimane – senza ombra di dubbio – il più prezioso.
[…]
Per i palestinesi, la Nakba è implacabile e ricorrente. Succede al presente – e succede ovunque sulla mappa. Non un solo angolo della nostra geografia viene risparmiato, non una generazione sin dagli anni Quaranta. Per la mia famiglia, la Nakba è stata l’esperienza di mia nonna, espulsa da Haifa dall’Haganah [«La Difesa», organizzazione paramilitare sionista creata durante il mandato britannico e poi integrata nell’IDF] nel 1948 – ma anche i suoi racconti che mi avvisavano di quello che sarebbe stato inevitabilmente il mio destino quando i coloni con l’accento di Brooklyn, protetti dall’esercito israeliano, hanno occupato metà della mia casa a Sheikh Jarrah nel 2009, dichiarandola loro proprietà per diritto divino. Per altre famiglie, la Nakba è cominciata quando un’amata nonna è stata espulsa da Giaffa e ha cercato rifugio a Gaza, dove la Nakba continua nel rombo degli aerei militari che sganciamo bombe sui campi profughi sovraffollati, facendo conoscere ai suoi nipoti la loro prima (o forse terza o sesta) guerra. Ci sono le facce di quei nipoti sui poster che non sono ancora stati stampati.
[…] Una volta, riuscivo a separarmi con facilità dalle classi che a lungo ho disprezzato, le élite, i borghesi, e quelle per cui la Palestina è una metafora estetica. Ma una nuova classe è emersa nell’inferno angusto della Striscia di Gaza: gli affamati e i reietti, cacciati più volte, senza fine, in maniera implacabile, ed è impossibile essere qualcosa di più di uno spettatore impotente, impossibile appartenere a quella classe, non senza lividi, non senza sacrificio.
È una tentazione, quasi una consolazione, in particolare quando guardo il cibo sulla mia tavola e il tetto sopra la mia testa, concedersi la colpa, ma è un sentimento improduttivo: non dà vita alle rivoluzioni. […]
In questi giorni sono tormentato da un ritornello meno vistoso, ma più mortale, una consapevolezza non voluta: Gaza ha il diritto di dimenticarci, di non perdonarci mai, di sputarci in faccia. Quante guerre ha subìto? Quanti martiri ha dato? Quanti corpi le sono stati rubati, strappati dall’abbraccio dei loro padri? E quanti di noi balbettano quando ci viene chiesto della resistenza, o quanti di noi rinnegano il nostro diritto a resistere, il nostro bisogno di resistere?
Dal 7 ottobre, molti personaggi pubblici, molti di loro palestinesi, soprattutto in Occidente, hanno riconsiderato, addirittura rinnegato, la catarsi che hanno provato vedendo le immagini delle “ruspe palestinesi” che abbattevano pezzi del muro israeliano di filo spinato che circonda Gaza. (Ho messo “ruspe palestinesi” tra virgolette perché è una frase incredibile). Molti si sono pentiti di aver festeggiato i deltaplani a motore che sfuggivano dal loro campo di concentramento.
[…]
Lo slogan Siamo tutti palestinesi deve abbandonare la metafora e manifestarsi materialmente. Significa che tutti noi – palestinesi e non palestinesi – dobbiamo incarnare la condizione palestinese, la condizione di resistenza e rifiuto, nelle vite che conduciamo e nelle compagnie che frequentiamo. Significa che respingiamo la nostra complicità in questo bagno di sangue e la nostra inerzia davanti a tutto quel sangue. Significa che Gaza non può stare da sola nel sacrificio.
* Non ho alcun problema con il canto di protesta in sé; penso che sia piuttosto bello.
Una nuova alba
Il sionismo, al di là della facciata della superpotenza impenetrabile che afferma di essere, oggi è più vulnerabile che mai. E non lo dico ingenuamente: non chiedo di glissare sulle capacità del nostro nemico o sul potere degli imperi e dei mercenari che lo sostengono. Né chiedo di banalizzare il peso schiacciante di centinaia di migliaia di martiri o di rendere glamour gli uomini che affrontano i carri armati in tuta da ginnastica gravandoli con un peso maggiore di quello che riescono a gestire. I combattenti per la libertà sanno che il loro avversario è Golia, che le probabilità giocano a loro sfavore, che non hanno scelta se non prendere la pietra. Ma questa è una nuova alba. Tramite un’analisi approfondita – guardando i media di stato, ascoltando la narrazione globale che sta cambiando, assistendo al rinascimento dei movimenti radicali, persino leggendo le scritte nei bagni degli aeroporti – scopriamo che questa è una nuova alba. Il sionismo può restare un avversario formidabile, ma è anche una bestia tremante, una bestia che sta invecchiando, accecata dal suo stesso significato, per quanto sia imprevedibile. A volte ti piomba addosso e affonda le zanne nella tua carne. Altre volte, non è altro che una tigre di carta.
E questa scoperta non soltanto infrange il mito dell’invincibilità coloniale, ma ci ricorda che la libertà è ottenibile, che il futuro è alla nostra portata. In mezzo alle incessanti incursioni aeree e al caos delle città demolite, potrebbe sembrare fatuo concentrare l’attenzione sul gelsomino in fiore. Ma ci meritiamo di guardare ogni cosa, di cercare ogni cosa. Vedere il quadro con tutti i particolari. Per quanto sia mortale e infida e inarrestabile, la Nakba non durerà in eterno. Il mondo sta cambiando, perché deve cambiare. Se i semi sono in grado di germogliare all’inferno, così fa la rivoluzione.
Non è teocrazia: è il sospiro della creatura oppressa
Al telefono, mia madre mi dice, la pioggia sta arrivando e Dio è onnipotente.
(Brani tratti da Mohammed El-Kurd, Vittime perfette e la politica del gradimento, Fandango, Roma, 2025)