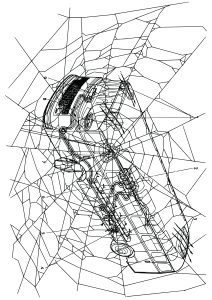Luci da dietro la scena XXVIII – Vous travaillez pour l’armée, madame?
Qui il pdf: Luci da dietro la scena (XXVIII)
Luci da dietro la scena XXVIII – Vous travaillez pour l’armée, madame?
La corrente principale della storia (e le storie negate)
[…] ho cercato di distinguere i due significati di maternità, di solito sovrapposti: il rapporto potenziale della donna con le sue capacità riproduttive e con i figli; e l’istituto della maternità, che mira a garantire che tale potenziale – e di conseguenza le donne – rimanga sotto il controllo maschile. Tale istituto è stato la trama dei più disparati sistemi sociali e politici. E ha impedito a più di metà del genere umano di prendere decisioni che riguardavano la sua stessa vita; ha esonerato gli uomini dalla paternità, svuotando di ogni autentico significato questo concetto; ha creato un pericoloso scisma tra vita «pubblica» e «privata»; ha sclerotizzato scelte e potenzialità umane. In quella che è la contraddizione più fondamentale e incredibile, ha alienato la donna dal suo corpo incarcerandola in esso. In alcuni momenti storici, e in alcune culture, l’idea della donna–come–madre ha fatto sì che la donna venisse considerata con rispetto e persino con timore, e che avesse voce in capitolo nella vita di una popolazione o di un clan. Ma alla luce di quanto noi conosciamo come «corrente principale» della storia documentata, la maternità come istituto ha limitato e degradato il potenziale femminile.
[…]
La maternità – mai nominata nelle storie di conquiste e di servitù, di guerre e di trattati, di esplorazioni e di imperialismo – ha una sua storia, una sua ideologia, ed è più fondamentale del tribalismo e del nazionalismo.
[…]
Mi sono convinta che la biologia femminile – la sensualità diffusa interna, di clitoride, seno, utero, vagina; i cicli lunari delle mestruazioni; la gestazione e la creazione di vita che può aver luogo nel corpo femminile – abbia implicazioni molto più radicali di quanto ci si rende conto. Il pensiero patriarcale ha limitato la biologia femminile alle sue qualità più ristrette. La visione femminista, per questi motivi, si è sottratta alla biologia femminile; potrà, ritengo, giungere a considerare il nostro corpo come una risorsa piuttosto che come un destino. Per vivere una vita pienamente umana dobbiamo avere non solo il controllo sul nostro corpo (anche se tale controllo è fondamentale), ma dobbiamo toccare l’unità e la risonanza del nostro fisico, il nostro legame con l’ordine naturale, il territorio corporeo della nostra intelligenza. […] Il corpo è stato reso così problematico per le donne che spesso è sembrato più facile scrollarselo di dosso per pensarsi come spirito disincarnato.
Il corpo, un ribollire di ambivalenze
Il corpo della donna, con il suo potenziale per la gestazione, la procreazione e il nutrimento della nuova vita, è stato nei secoli un campo di contraddizioni: uno spazio investito di potere, e una profonda vulnerabilità; una figura sacra e l’incarnazione del male; un ribollire di ambivalenze che per lo più hanno contribuito a escludere le donne dall’atto collettivo di dare forma alla cultura.
[…]
«Senza dubbio nelle prime età della storia umana la forza magica e il miracolo della donna erano fonte di meraviglia quanto l’universo stesso, e questo dava alla donna un potere prodigioso che la parte maschile della popolazione ha cercato con tutti i mezzi di piegare, controllare e sfruttare ai suoi fini» (Joseph Campbell, Le maschere di Dio).
Questa sua capacità riproduttiva ha avuto un’importanza fondamentale nella prima divisione del lavoro; ma d’altra parte, come ha notato Bruno Bettelheim, in ogni cultura i maschi hanno cercato di imitare, investirsi e condividere magicamente i poteri fisici della femmina. Le tecniche altamente sviluppate (e altamente sospette) della moderna ostetricia sono semplicemente un recente sviluppo di ciò che Suzanne Arms ha definito «il graduale tentativo da parte dell’uomo di sottrarre alla donna il processo della nascita e di appropriarselo». […] La forza qui operante non è semplicemente il capitalismo occidentale, ma l’esigenza di controllare i poteri riproduttivi femminili. […] Gli organi di riproduzione femminili, la matrice della vita umana, sono diventati uno dei bersagli della tecnologia patriarcale.
[…]
Come hanno partorito le donne, chi le ha aiutate, come e perché? Non sono semplicemente interrogativi che riguardano la storia dell’ostetricia: sono questioni politiche.
Dalla presenza femminile in tutto il cosmo…
La religione prepatriarcale riconosce la presenza femminile in tutto il cosmo. La luna, che generalmente si ritiene sia stato il primo oggetto di adorazione, e le cui fasi corrispondono ai cicli mestruali, è sempre stata associata alle donne.
[…]
Il pensiero prepatriarcale ginecomorfizzava ogni cosa. Dall’utero-terra usciva vegetazione e nutrimento, così come il bambino esce dal corpo della donna. Le parole per madre e materia (la matrice di cui è composto il pianeta) sono molto simili in diverse lingue: mater, mutter, mother, matter, moeder, modder. Il termine «Madre Terra» viene tutt’ora usato anche se, fatto significativo, ai nostri tempi ha acquistato un sapore antiquato, arcaico, sentimentale.
In inverno la vegetazione si ritira nell’utero-terra e con la morte anche il corpo umano ritorna in quel grembo, in attesa della resurrezione. […]
L’oceano le cui maree, come le mestruazioni della donna, sono regolate dalla luna, l’oceano che corrisponde al liquido amniotico in cui ha inizio la vita umana, l’oceano che le navi possono solcare ma nelle cui profondità i marinai trovano la morte e si nascondono mostri, questo oceano è a metà tra la terra e la luna nella ginecomorfizzazione della natura. […]
La Grande Madre, il principio femminile, era originariamente personificato sia nelle tenebre sia nella luce, nella profondità delle acque e nella volta celeste. Solo con l’evoluzione di una cosmogonia patriarcale la vediamo limitata a una presenza puramente «ctonia» o tellurica, rappresentata dalle tenebre, l’inconscio, il sonno.
…alla donna murata in casa
Dai primi insediamenti umani fino allo svilupparsi delle fabbriche come centri di produzione, la casa non è stata un rifugio, un luogo di riposo e di protezione dalla crudeltà del «mondo esterno»; è stata una parte del mondo, un centro di attività, un’unità produttiva. In essa donne e uomini, e anche i bambini, non appena ne erano in grado, svolgevano tutta una serie di attività: allevamento e coltivazione, preparazione e conservazione del cibo, lavorazione di pelli, canne, argilla, tinture, grassi, erbe, produzione di tessuti e indumenti, di bevande, sapone e candele, cure mediche, l’insegnamento di tutte queste arti ai giovani. Di rado una donna era sola in casa a doversi occupare unicamente del figlio o dei figli. Donne e bambini facevano parte di un nucleo sociale molto attivo. Il lavoro era duro, complesso, spesso fisicamente gravoso, ma era diversificato e di solito svolto in comune. La mortalità da parto e gravidanza, e quella infantile, erano altissime, la vita media delle donne era breve e sarebbe ingenuo romanticizzare un’esistenza continuamente minacciata da malnutrizione, carestia e malattie. Ma la maternità e le cure della casa come rifugio privato non erano, non potevano essere, l’occupazione fondamentale delle donne, né madre e figlio erano isolati in un rapporto a due.
L’ideale della madre murata in casa con i figli, la specializzazione della maternità per le donne, la separazione tra la casa e il «mondo degli uomini» fu una creazione della rivoluzione industriale, un ideale rivestito di un potere quasi divino, potere che da un punto di vista concettuale è tutt’oggi intoccato.
[…]
L’immagine della madre in casa, per quanto poco realistica, ha perseguitato e colpevolizzato l’esistenza delle madri lavoratrici. Ma, per gli uomini come per le donne, è diventata anche un pericoloso archetipo: la Madre, fonte di amore angelico e di perdono in un mondo sempre più spietato e impersonale; l’elemento femminile lievitante, emotivo in una società dominata dalla logica maschile e dalla pretesa maschile di giudizio “obiettivo”, “razionale”; simbolo e residuo di valori morali e di tenerezza in un mondo di guerre, di competizioni brutali e di disprezzo per la debolezza umana.
Vous travaillez pour l’armée, madame?
Per generazioni abbiamo mandato i nostri figli in una qualche battaglia: non sempre così aperta e sanguinosa come quelle di Sparta o la guerra di secessione. Mettere al mondo figli maschi è stato il modo in cui la donna poteva lasciare la “sua” impronta nel mondo.
[…]
Messi al mondo tre figli, mi sono ritrovata a vivere, a tutti i più profondi livelli di passione e confusione, con tre piccoli corpi, e ben presto con tre persone, la cui cura spesso pareva divorare la mia stessa vita, ma la cui bellezza, humour, ed espressioni fisiche d’affetto non cessavano di stupirmi. Li vedevo non come «figli maschi» e potenziali eredi del patriarcato, ma come tenere creature, corpi che esploravano con delicata insistenza, purezza di concentrazione, dolore e gioie che nei bambini esistono in forme assolute, tutte cose che mi riportavano a parti da tempo dimenticate di me stessa. Ero una madre irrequieta, impaziente, stanca, discontinua, lo shock della maternità mi aveva lasciata stordita; ma sapevo di amare appassionatamente quei tre giovani esseri.
Ricordo di aver trascorso un’estate in casa di un’amica nel Vermont. Mio marito era all’estero, e io e i miei tre figli, rispettivamente di nove, sette e cinque anni, vivevamo praticamente da soli. Senza un maschio adulto in casa, senza alcuna necessità di rispettare programmi, sonnellini, pasti a ore fisse, o di mandare i bambini a letto presto per lasciare liberi i genitori, vivevamo secondo un ritmo che mi appariva molto piacevole e vagamente colpevole. Faceva molto caldo, il cielo era limpido, e mangiavamo quasi sempre all’aperto, senza tante cerimonie, eravamo sempre mezzi nudi, stavamo alzati a guardare pipistrelli, stelle e lucciole, leggevamo e ci raccontavamo storie, dormivamo sino a tardi la mattina. Vedevo i loro snelli corpi di ragazzini che si abbronzavano, ci lavavamo all’aperto, con l’acqua della pompa, vivevamo come naufraghi su un’isola di madri e figli. La sera ci addormentavamo esausti e io restavo alzata a leggere e a scrivere fino alle ore piccole, come quand’ero all’università. Ricordo che pensavo: ecco come potrebbe essere la vita con i bambini, senza orari di scuola, routine fisse, sonnellini obbligati, e il conflitto di essere madre e moglie senza uno spazio per essere semplicemente me stessa. Una sera tornando a casa dopo la mezzanotte, da un drive-in, con tre bambini addormentati sul sedile posteriore, mi sentii perfettamente sveglia, euforica: avevamo infranto insieme ogni regola, regole che io stessa avevo ritenuto di dover osservare in città se non volevo essere una «cattiva madre». Eravamo complici di una congiura, fuorilegge rispetto all’istituzione della maternità; mi sentivo meravigliosamente padrona della mia vita. Naturalmente l’istituzione ci ripiombò addosso, e mi tornarono i dubbi su me stessa come «buona madre» insieme al risentimento per l’archetipo. Ma anche allora sapevo che non volevo che i miei figli agissero per me nel mondo, così come non volevo che uccidessero e morissero per il loro paese. Volevo agire, vivere per me stessa e amarli come esseri a sé stanti.
[…]
Se dovessi esprimere un desiderio per i miei figli, augurerei loro di avere il coraggio delle donne. Mi riferisco a qualcosa di molto concreto e preciso: il coraggio che ho visto in donne che, nella vita privata e pubblica, nel mondo interiore del sogno, del pensiero e della creatività, e in quello esterno del patriarcato, corrono rischi sempre maggiori, psicologici e fisici, nell’evolvere una nuova visione. A volte ciò comporta piccoli atti di immenso coraggio; altre volte azioni pubbliche che possono costare a una donna il posto di lavoro o la vita; spesso comporta momenti, o lunghi periodi, in cui si è costrette a pensare l’impensabile, ci si sente chiamate pazze, o ci si sente tali; e sempre una perdita delle sicurezze tradizionali. Ogni donna che decide di assumere il controllo della sua vita lo fa sapendo che dovrà affrontare enormi lacerazioni, inflitte sia dall’interno sia dall’esterno. Vorrei che i miei figli non si ritraessero di fronte a questo genere di lacerazioni, che non si accontentassero delle vecchie difese maschili, inclusa quella di un fantastico odio per se stessi. E vorrei che lo facessero non per me, o per altre donne, ma per loro stessi e per la vita sul pianeta Terra.
[…]
Vous travaillez pour l’armée, madame? Nulla garantisce, né col socialismo né col capitalismo «liberale», col protestantesimo, con l’«umanesimo», né con alcune delle etiche esistenti, che una politica progressista non si trasformerà in oppressione sino a che le donne non avranno assoluto controllo sull’uso dei loro corpi. Abbiamo visto programmi per la conservazione dei territori cedere al disboscamento, agli oleodotti, alla violazione della natura. Abbiamo anche visto leggi e opinioni circa il controllo delle nascite e l’aborto modificarsi nel corso della storia, secondo le esigenze militari, di mercato, o climi culturali di puritanesimo o di «liberazioni sessuali» controllati dal patriarcato.
[…]
Quale donna, nella cella d’isolamento di una vita in casa, con bambini piccoli, o nella lotta per far loro da madre pur dovendo provvedere da sola al loro mantenimento, o nel conflitto tra la sua personalità e il dogma per il quale è per prima, per ultima cosa, e sempre madre, quale donna non ha sognato di lasciarsi andare, di rinunciare a ciò che viene definito il suo equilibrio, perché ci sia qualcuno che si occupi di lei, una volta tanto, o semplicemente per trovare il modo di occuparsi di se stessa? Le madri: vanno a prendere i bambini a scuola; siedono alle assemblee dei genitori; tranquillizzano bambini irritati piazzati nei carrelli dei supermercati; si trascinano a casa per per preparare la cena, fare il bucato, e occuparsi dei bambini dopo una giornata di lavoro; si battono per ottenere un’assistenza e una scuola accettabili per i loro figli; aspettano gli assegni dell’ex marito per il mantenimento dei figli mentre il padrone di casa minaccia lo sfratto; restano nuovamente incinte perché la loro evasione nel piacere e nell’abbandono è il rapporto sessuale; si straziano con ferri da calza; si svegliano al pianto di un bambino dai loro sogni eternamente incompiuti… le madri, se potessimo leggere nelle loro fantasie, nei loro sogni ad occhi aperti, nelle esperienze immaginarie, potremmo scorgere le raffigurazioni della rabbia, della tragedia, del sovraccarico di energia d’amore, di disperazione creativa, vedremmo tutto l’apparato della violenza istituzionalizzata distorcere l’esperienza della maternità.
Ciò che lascia stupiti, ciò che può darci grande speranza, fiducia per un futuro in cui le vite di donne e bambini verranno risanate da mani femminili, è tutto ciò che siamo riuscite a salvare, di noi, per i nostri figli, persino nel clima distruttivo dell’istituzione: la tenerezza, la passione, la fiducia nei nostri istinti, l’emergere di un coraggio che non sapevamo di possedere, la cura costante di un’altra vita umana, la piena consapevolezza del costo e della precarietà della vita. La battaglia della madre per il figlio, contro la malattia, la povertà, la guerra, deve diventare una battaglia comune dell’umanità, condotta nell’amore e nella passione per la sopravvivenza. Ma perché ciò avvenga l’istituto della maternità deve essere annullato.
I mutamenti necessari per arrivare a questo echeggiano in ogni recesso del sistema patriarcale. Distruggere l’istituto non significa abolire la maternità. Significa portare la creazione e il mantenimento della vita sullo stesso piano di decisione, lotta, sorpresa, immaginazione e razionalità di qualsiasi altro compito arduo ma liberamente scelto.
(brani tratti da Adrienne Rich, Nato di donna [1976], Garzanti, Milano, 1977)