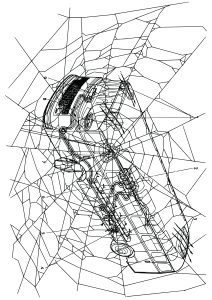Luci da dietro la scena (XXV) – Ethica more Gaza demonstrata
Qui il pdf:
Uno scomodo rumore
Il mondo dei diritti individuali, delle frontiere aperte e del diritto internazionale si sta allontanando rapidamente. Oggi, la recinzione statunitense lungo il confine messicano, la pratica australiana di imprigionare i richiedenti asilo su isole al di fuori del suo territorio, l’aperto incitamento rivolto da un ministro degli Interni britannico ai nazionalisti inglesi di estrema destra e la crescente ossessione di molti giovani uomini per il «genocidio bianco», la «Grande Sostituzione» e altri scenari apocalittici prospettati all’inizio del Ventesimo secolo, rendono crudelmente visibile il ritorno a casa del suprematismo bianco nel cuore dell’Occidente moderno.
Il 7 ottobre il suo feroce atteggiamento difensivo si è infiammato, quando Hamas ha distrutto, in modo definitivo, l’aura di invulnerabilità di Israele. Quest’assalto a sorpresa da parte di persone che si presumeva fossero state schiacciate rappresenta, per molte maggioranze bianche turbate e inorridite, la seconda Pearl Harbor del Ventunesimo secolo, dopo l’11 settembre. E, come è già successo, la percezione diffusa che il potere bianco sia stato pubblicamente violato ha «scatenato», secondo le parole di John Dower, «una rabbia che rasenta la furia genocida».
Nel tentativo di riconquistare la propria immagine di potenza attraverso un bagno di sangue, Israele e i suoi sostenitori barcollano verso la «terribile probabilità» delineata in passato da James Baldwin: che i vincitori della storia, «lottando per mantenere ciò che hanno rubato ai loro prigionieri, e incapaci di guardarsi allo specchio, scateneranno un caos nel mondo che, se non porrà fine alla vita su questo pianeta, provocherà una guerra razziale di dimensione che il mondo non ha mai visto». Abbiamo già assistito a Gaza – dopo i milioni di morti evitabili nel corso della pandemia – a un’altra fase di quella che l’antropologo sociale Arjun Appadurai chiama «una vasta correzione malthusiana mondiale» che è «orientata ad approntare il mondo per i vincitori della globalizzazione, senza il rumore scomodo dei suoi perdenti».
Non è esagerato affermare che raramente la posta in gioco etica e politica è stata più alta.
L’abisso che abbiamo davanti
Gaza ha allungato l’ombra della Shoah su molte più persone della popolazione ebraica mondiale. Nella storia moderna, è stato il destino di miliardi di persone in tutto il mondo quello di vedere la pulsione di morte all’opera. Rimarranno a lungo impressi nella loro memoria momenti isolati di un’orgia di violenza bestiale: Sha’ban al-Dalou, uno studente di ingegneria di diciannove anni, bruciato vivo, con una flebo attaccata al braccio, in uno dei tanti ospedali bombardati da Israele; soldati israeliani, intervistati dalla CNN, che affermano di «non riuscire più a mangiare carne» dopo avere schiacciato centinaia di palestinesi sotto i bulldozer ed essersi accorti di come «tutto schizza fuori». Imprimendo nella nostra coscienza la violenza gratuita delle nostre società, un’offesa così incomprensibile è insanabile, come avvertiva Primo Levi. Essa «pullula in mille modi, contro la stessa volontà di tutti, come sete di vendetta, come cedimento morale, come negazione, come stanchezza, come rinuncia». E renderà più difficile l’urgente compito etico di connettere tra loro le diverse storie di sofferenza, di esplorare insieme un passato di catastrofi collettive, per orientarci verso le sfide di un futuro inevitabilmente pluralista e il destino comune del cambiamento climatico.
Dopo aver assistito per diversi mesi a un feroce genocidio, con la consapevolezza che è stato concepito, eseguito e approvato da persone molto simili a loro, che lo hanno presentato come una necessità comune, legittima e persino umana, milioni di persone adesso si sentono meno a casa nel mondo. Lo shock di questa rinnovata esposizione a un male tipicamente moderno – il male commesso nell’era premoderna solo da individui psicopatici e scatenato nel secolo scorso da governanti e cittadini di società ricche e teoricamente civilizzate – non può essere ignorato. Né può esserlo l’abisso morale che abbiamo davanti.
Una scossa di consapevolezza etica
Il Ventesimo secolo – segnato dai conflitti più brutali e dai più grandi cataclismi morali della storia – ha messo in luce i pericoli di un mondo in cui non esisteva alcun vincolo etico su ciò che gli esseri umani potevano o osavano fare. La ragione secolare e la scienza moderna, che avevano rimpiazzato la religione tradizionale, non solo hanno rivelato la loro incapacità di legiferare sulla condotta umana, ma hanno anche avuto un ruolo nelle nuove e più efficienti modalità di sterminio impiegate a Auschwitz e Hiroshima. Il rispetto religioso dei sani princìpi era in declino ovunque. Ma nei decenni di ricostruzione successivi al 1945 è stato possibile, anzi imperativo, sperare che la malvagità umana organizzata fosse largamente in ritirata. Si poteva quantomeno provare ad aggrapparsi alla teologia laica negativa, il «mai più» adottato nelle commemorazioni della Shoah, anche se fu spesso ripudiato, come in Cambogia, Ruanda e nei Balcani.
Quella a cui siamo di fronte oggi è una rottura definitiva nella storia etica globale dopo il Ground Zero del 1945; la storia in cui la Shoah era il riferimento universale per indicare un tragico fallimento della moralità umana.
Da qualche tempo le immagini idealizzate che abbiamo dei nostri Paesi, siano essi l’India, Israele, gli Stati Uniti o l’Europa, sono al collasso. Il mondo come lo conoscevamo, modellato a partire dal 1945 dai beneficiati della schiavitù, del colonialismo e del nazionalismo anticoloniale, si sta sgretolando.
[…]
In Oriente così come in Occidente, nel Nord e nel Sud del mondo, siamo stati chiamati a nuove lotte per la libertà, l’uguaglianza e la dignità e per creare un mondo in cui ci sia meno miseria. Ma è stata proprio Gaza a spingere molti a fare i conti con il profondo malessere delle loro società. È Gaza che ha accelerato l’idea di un mondo decrepito che non ha più alcuna fiducia in se stesso e che, preoccupato solo dell’autoconservazione, calpesta i diritti e i princìpi che un tempo considerava sacri, ripudia ogni senso di dignità e onore, e premia la violenza, la menzogna, la crudeltà e il servilismo.
Allo stesso tempo in cui provoca sensazioni di vertigine, di caos e di vuoto, Gaza diventa per molte persone impotenti la condizione essenziale della coscienza politica ed etica del Ventunesimo secolo, proprio come lo è stata la Prima guerra mondiale per una generazione in Occidente.
I crimini di Gaza e i numerosi atti di complicità e voluta indifferenza che li hanno resi possibili hanno avuto un impatto più profondo tra i giovani nella tarda adolescenza e nei ventenni. Al confine tra l’infanzia e l’età adulta, hanno ricevuto una rapida e brutale formazione sulle barbarie della storia e su come gli adulti che detengono il potere le giustificano: un’esperienza finora del tutto estranea alla loro percezione collettiva. Mentre politici, burocrati, uomini d’affari mentivano e insabbiavano, o fingevano di ignorare, i giovani studenti si sono trovati ad affrontare in tempo reale un fenomeno sconvolgente che gli storici dei genocidi affrontano retrospettivamente, e con cui sono ancora alle prese […].
[…]
Scendendo in strada a protestare, i giovani hanno affrontato, soprattutto negli Stati Uniti, la forza della condanna da parte della classe dirigente, che si trattasse di rettori delle università che scatenavano la polizia militarizzata contro di loro, di miliardari che cancellavano offerte di lavoro o di un candidato alle presidenziali che prometteva di espellere i giovani stranieri. […]
Nel suo libro I sommersi e i salvati Primo Levi descrive Auschwitz come «il microcosmo della società totalitaria» in cui «viene concesso generosamente il potere a chi sia disposto a tributare ossequio all’autorità gerarchica, conseguendo in questo modo una promozione sociale altrimenti irraggiungibile». Levi poi devia inaspettatamente chiedendosi se «una vasta fascia di coscienze grigie che sta fra i grandi del male e le vittime pure» sia peculiare di un regime totalitario. Si chiede, pessimisticamente, se il collaborare dei nazisti sia più simile a noi di quanto ci piaccia pensare, perché «anche noi siamo così abbagliati dal potere e dal denaro da dimenticare la nostra fragilità esistenziale». «Ovunque le persone aspiravano a un avanzamento di carriera» conclude in modo simile Christopher R. Browning in Uomini comuni (1992), il suo studio pionieristico su come persone addestrate a rispettare l’autorità e le norme convenzionali dei propri simili perdano il senso di responsabilità individuale e arrivino a partecipare alla violenza genocida.
Nella loro indifferenza verso gli avanzamenti di carriera e sfidando l’establishment o a riformarsi o a schiacciarli, i manifestanti hanno dimostrato un coraggio non comune. Rifiutando la complicità con istituzioni corrotte, hanno espresso la necessaria fiducia nella capacità umana di resistere all’autorità criminale e di riconoscere i deboli e solidarizzare con loro in ogni situazione. Hanno avuto il coraggio di correre dei rischi in nome della libertà, della dignità e dell’uguaglianza. Alla mentalità di autoconservazione passiva che domina la vita politica e professionale, hanno opposto una formidabile sfida morale con i loro atti di abnegazione personale.
Si ha sempre più l’impressione che per ripristinare la forza e la dignità della coscienza individuale si possa confidare solo nelle persone in cui la catastrofe di Gaza ha prodotto una scossa di consapevolezza etica.
(brani tratti da Pankaj Mishra, Il mondo dopo Gaza, Guanda, Milano, 2025)