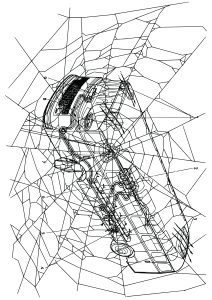Luci da dietro la scena (XXX) – Il nodo-guerra e la linea disfattista
Qui in pdf: Luci da dietro la scena (XXX)-1
Luci da dietro la scena (XXX) – Il nodo-guerra e la linea disfattista
Tagliare il nodo
Il più grande paradosso della vita moderna è il fatto che non solo nella vita civile si calpesta la dignità di coloro che un giorno verranno mandati a morire per la dignità della nazione, ma che proprio quando la loro vita è così sacrificata per difendere l’onore comune, vengono esposti a umiliazioni assai più dure che in precedenza. Che cosa sono le offese considerate nei vari paesi motivi di guerra di fronte a quello che un ufficiale può impunemente infliggere a un soldato? Può insultarlo, e senza che sia ammessa replica alcuna; può dargli pedate – un autore di ricordi di guerra non si è forse vantato d’averlo fatto? Può impartirgli qualunque ordine sotto la minaccia del revolver, compreso quello di sparare a un compagno. Può infliggergli, a titolo di punizione, le angherie più meschine. Può quasi tutto, e ogni disobbedienza è punita con la morte o potrebbe esserlo. Coloro che, nella retrovia, sono ipocritamente celebrati come eroi, sono in realtà trattati come schiavi. E, tra i soldati sopravvissuti, quelli poveri, liberati dalla schiavitù militare, ricadono in quella civile, dove più d’uno è costretto a subire le insolenze di coloro che si sono arricchiti senza rischi.
L’umiliazione continua e quasi metodica è un fattore essenziale della nostra organizzazione sociale, in pace come in guerra. Ma in guerra è portato a un grado più elevato. Se fosse applicato all’interno del proprio paese il principio in base al quale si dovrebbe respingere l’umiliazione al prezzo della vita stessa, si sovvertirebbe tutto l’ordine sociale, e, in particolare, la disciplina indispensabile per portare avanti la guerra. Che qualcuno osi, in queste condizioni, fare di questo stesso principio una regola della politica internazionale è veramente il colmo dell’incoscienza. […] Certo, ci sono sempre state delle guerre; ma l’elemento che caratterizza la nostra epoca è che sono fatte dagli schiavi. E, per di più, queste guerre in cui gli schiavi sono mandati a morire in nome di una dignità che non viene mai loro accordata, queste stesse guerre costituiscono l’ingranaggio essenziale del meccanismo dell’oppressione. Tutte le volte in cui esaminiamo da vicino e in maniera concreta i mezzi per diminuire effettivamente l’oppressione e la disuguaglianza, ci si scontra sempre con la guerra, con le conseguenze della guerra, con le necessità imposte dalla preparazione alla guerra. Non si scioglierà mai questo nodo, bisogna tagliarlo.
(da un progetto di articolo scritto da Simone Weil nel marzo 1936)
Circolo vizioso
Viviamo in un’epoca in cui la relativa sicurezza, che un certo dominio tecnico sulla natura dà agli uomini, è ampiamente controbilanciata dai pericoli di rovine e massacri che i conflitti tra i gruppi umani provocano. […] I conflitti più minacciosi hanno un carattere comune che potrebbe rassicurare gli animi superficiali, ma che, malgrado l’apparenza, ne costituisce il vero pericolo: non hanno un obiettivo definito.
[…]
La nostra sedicente epoca tecnologica si batte soltanto contro i mulini a vento.
[…]
Così, quando si fa la guerra è per conservare o accrescere i mezzi per farla. Tutta la politica internazionale ruota attorno a questo circolo vizioso.
Simone Weil, Non ricominciamo la guerra di Troia, 1937
Nella quiete dei magazzini
Ora siamo anche noi una entità maneggiabile, che può magari sopravvivere a lungo nella quiete dei magazzini, ma in qualunque momento deve aspettarsi di essere chiamata a contribuire a un riequilibrante massacro.
[…]
Tutto ormai va più in là di qualsiasi previsione, di qualsiasi intenzione, eppure tutto obbedisce a una sua consequenzialità, lavora sul corpo e sulla psiche delle vittime, non fa in tempo a impacchettare un’impresa che già si accinge a nuove confezioni, non lascia finire una guerra senza gettare le basi dei campi di concentramento che fioriranno nelle successive.
Roberto Calasso, La guerra perpetua (in Karl Kraus, Gli ultimi giorni dell’umanità, Adelphi, Milano, 1980)
“Viva Menelik!”, “Abbasso Crispi!”, “Via dall’Africa!”
[…] Crispi aveva mandato [nel 1894] contro il movimento contadino dei fasci siciliani un vero e proprio corpo di spedizione di cinquantamila uomini, e contro l’agitazione dei cavatori della Lunigiana aveva fatto intervenire l’esercito, proclamato lo stato d’assedio e affidato ai tribunali militari l’incarico di riportare l’ordine e di reprimere ogni agitazione sociale.
[…]
L’avventura africana finisce con il disastro di Adua [il 1° marzo 1896, l’esercito italiano viene pesantemente sconfitto nella città etiope dall’esercito abissino del negus Menelik]: per Umberto I, che “giocava a fare l’imperatore”, si tratterà di far rifondere le monete con la corona imperiale che già aveva fatto coniare dalla zecca. Per Crispi significa dover abbandonare per sempre il potere.
“Viva Menelik!”, “Abbasso Crispi!”, “Via dall’Africa!” grida, la sera del 3 marzo 1896, una folla eterogenea e fittissima […] ammassata in piazza del Duomo, sotto la Galleria, in piazza della Scala a Milano, per esprimere lo sdegno popolare e chiedere le dimissioni del governo e la fine della guerra d’Africa, dopo la notizia della sconfitta di Adua.
Davanti al municipio il sindaco moderato si affaccia per parlare alla folla, ma è accolto da bordate di fischi, mentre «volano sassate contro le guardie di pubblica sicurezza e i soldati inviati in servizio d’ordine vengono abbracciati, issati sulle spalle e portati in trionfo al grido di “viva l’esercito”, “viva i nostri fratelli”, frammisto al canto dell’Inno dei Lavoratori».
«Poco dopo la mezzanotte la manifestazione è soffocata e sciolta dalle cariche brutali della cavalleria: sul terreno rimane un morto, un tipografo di diciannove anni trapassato da parte a parte da un colpo di baionetta; i feriti gravi sono sette, ottanta gli arrestati […] Una rabbia cupa, una tensione preinsurrezionale che [esplode] in manifestazioni di piazza spontanee […] A Pavia e Cremona migliaia di dimostranti invadono la stazione ferroviaria da dove sono in partenza contingenti di soldati per l’Africa, occupano i binari, si stringono intorno alla truppa per impedirne la partenza […]
«Nelle città dell’Emilia e della Romagna sono presi d’assalto i palazzi comunali e le prefetture per imporre le dimissioni di Crispi […] Nel cuore di Torino, in piazza Castello, dinanzi al palazzo reale […] il presidente del Consiglio è bruciato in effigie» [per queste cronache vedi: Umberto Levra, Colpo di Stato della borghesia, Feltrinelli, Milano, 1975].
Le manifestazioni contro Crispi continuano a Bergamo, Genova, Bologna, Massa e Carrara, Macerata, Verona, Venezia, Monza, Ferrara, Padova, Pesaro, Fano, Firenze, Napoli. La popolazione scende nelle strade a chiedere il lutto nazionale, costringendo alla chiusura teatri, ritrovi, negozi.
A Milano le manifestazioni riprendono il giorno dopo più violente; sono divelti i binari sul ponte Ticino per impedire la partenza di un contingente di soldati per l’Africa; a Parma, nel popolare quartiere dell’Oltretorrente compaiono le barricate.
Circolano voci di indisciplina anche fra le truppe; manifestazioni si sarebbero avute nelle caserme di Milano; a Napoli molti alpini, in procinto di partire per le colonie, avrebbero disertato; molti coscritti, di fronte agli ufficiali, avrebbero gridato: “abbasso il re”.
Crispi non vuole cedere. Da Roma chiede alla magistratura severi provvedimenti e ordina ai prefetti di prendere accordi con le autorità militari per stroncare la “rivoluzione”.
Ma il suo governo è divenuto ormai insostenibile. La crisi di un gabinetto non deve trasformarsi in crisi dell’istituzione. Il re è costretto a intervenire. Le camere sono chiuse, ma a Crispi vengono imposte le dimissioni prima ancora dell’apertura delle camere.
[…]
All’esterno, quando vengono annunciate le dimissioni del “dittatore” e del suo ministero, da una folla di diecimila persone che avevano sostato per ore sotto la pioggia in piazza Colonna, si levano applausi e grida […].
(brani estratti da Massimo Felisatti, Un delitto di polizia? Morte dell’anarchico Romeo Frezzi, Bompiani, Milano, 1975)
Dice Ottolenghi
Dice Ottolenghi: “Io preferisco essere ufficiale e non soldato… io voglio avere in mano una forza con cui agire…”.
– Comandante della 11°: “Contro chi vuole impugnare quelle armi?”.
– Ottolenghi: “Contro tutti i comandi”.
– Comandante della 11°: “E dopo? Aspireresti tu ad essere il comandante supremo?”.
– Ottolenghi: Io aspiro solo a comandare il fuoco. Il giorno X, alzo battuto, fuoco a volontà! E vorrei cominciare dal comandante di Divisione, chiunque esso sia, perché tutti, regolarmente, sono uno peggio dell’altro.
– Comandante della 11°: “E dopo?”.
– Ottolenghi: “Sempre avanti, seguendo la scala gerarchica. Avanti sempre, con ordine e disciplina. Cioè, avanti per modo di dire, perché i nostri nemici non sono oltre le nostre trincee. Prima, quindi, dietro front, poi avanti, avanti sempre”.
– Un sottotenente: “Cioè indietro”.
– Ottolenghi: “Naturalmente. Avanti sempre, avanti, fino a Roma. Là è il quartier generale nemico”.
– Comandante della 11°: “E dopo?”.
– Ottolenghi: “Ti pare poco. Il governo andrà al popolo”.
– Comandante della 10°: “Se tu farai marciare l’esercito su Roma, credi tu che l’esercito tedesco e quello austriaco resteranno fermi in trincea? O credi che, per far piacere al nostro governo del popolo, i tedeschi rientreranno a Berlino e gli austro-ungarici a Vienna e a Budapest?”.
– Ottolenghi: “A me non interessa conoscere quello che fanno gli altri. A me basta sapere ciò che io voglio… questa guerra non è altro che una miserabile strage”.
– Comandante della 10°: “E la tua rivoluzione non è anch’essa una strage? Non è anch’essa una guerra, la guerra civile?”.
– Ottolenghi: “Nella rivoluzione, io vedo il progresso del popolo e di tutti gli oppressi. Nella guerra, non vi è nient’altro che strage inutile”.
(tratto da Emilio Lussu, Un anno sull’altipiano, Einaudi, Torino, 1945)
La continuità di una linea
«L’interventismo nel movimento anarchico» ha scritto Pier Carlo Masini «non fu un fenomeno, non fu una corrente, non fu neppure il tema di un dibattito o il termine di una scissione, ma solo una serie di sporadici e slegati casi personali, qualcuno di rilievo, qualcun altro di nessun rilievo». La quasi compatta opposizione degli anarchici alla guerra ne fece dei protagonisti di quello che fu chiamato «disfattismo», rendendoli comodi bersagli della repressione militarista. Molti disertarono, scegliendo l’esilio svizzero o americano. Molti furono arrestati, processati, internati. […]
Alla formula «neomalthusiana» dei socialisti – «né aderire né sabotare» – gli anarchici italiani ne avevano opposta un’altra, assai più chiara: «guerra alla guerra». Né prima né durante il conflitto essi avevano infatti sposato la tesi della neutralità. Neutri non erano ma ostili a tutti gli stati, a quello in cui vivevano non meno che agli altri. E per questa ostilità antistatale e antiborghese, per l’intransigente antibellicismo, per la volontà di trasformare la guerra tra gli stati in guerra di classe, non avevano potuto riconoscere tregue o patteggiamenti, né in nome della neutralità né in nome della guerra.
La continuità di questa linea viene ribadita subito dopo la fine del conflitto. Non si può accantonare la sfiducia nei segreti intrallazzi delle vecchie volpi della diplomazia militarista e capitalista solo perché si incontrano in nome della pace. Scrive Volontà riprendendo le pubblicazioni:
Non crediamo al ramoscello d’ulivo agitato sui popoli da coloro che hanno ancora al fianco una spada insanguinata. Come ieri dicevano «questa guerra non è la nostra guerra» oggi diciamo: questa pace non è la nostra pace. Se anche sarà sincera (del che dubitiamo, anzi siamo certi che non sarà), la pace fra i dominatori e gli sfruttatori dei popoli non sarà la pace dei popoli.
(tratto da Vincenzo Mantovani, Mazurka blu. La strage del Diana, Rusconi, Milano, 1979)